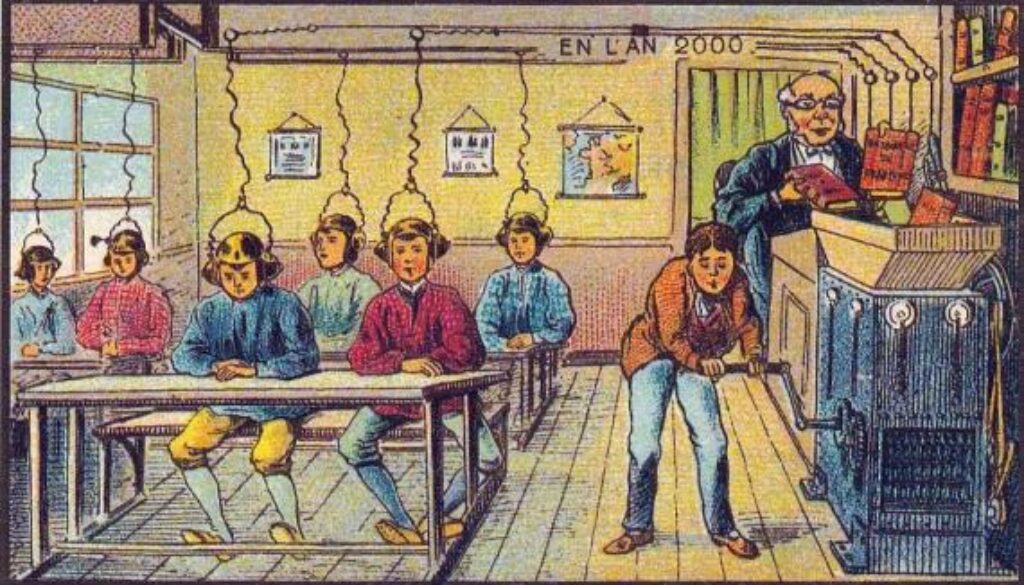Angela Azzaro, femminista e giornalista, è nata a Nuoro e oggi vive a Roma dove è vice-direttrice del quotidiano Il Riformista. Dal 2004 al 2009 ha curato e creato l’inserto culturale di Liberazione, “Queer”. È antimoralista e antigiustizialista. Un’impresa oggi quasi impossibile.
Con lei parliamo di stereotipi, immaginario, diritti.
Nel nostro paese sono ancora radicati profondamente gli stereotipi di genere. Oltre al fatto che per le donne non è ancora garantita una parità di diritti alla stregua di quelli degli uomini, soprattutto in alcuni ambiti (penso alla politica, al mondo scientifico, all’economia), nonostante diversi progressi siano stati raggiunti, anche a livello di conquista di posizioni egemoniche a livello internazionale, credo che gravi ancora una pressione sociale e mediatica che sottopone le donne che rivestono un ruolo pubblico, rispetto al loro aspetto fisico piuttosto che alle loro idee. Una donna è sottoposta, più di un uomo, al giudizio estetico e determinati giudizi, che siano di apprezzamento o che siano demolitivi e denigratori rischiano di mettere a tacere la loro voce e concentrare il discorso sull’aspetto fisico. Temo che sia una componente culturale difficile da sradicare. Ci sono delle modalità secondo te con cui è possibile rimuovere questi pregiudizi e queste pressioni estetico-sociali, che a volte vengono interiorizzate dalle stesse donne?
È uno dei cambiamenti più profondi e più difficili da raggiungere. Per sconfiggere lo stereotipo che associa le donne alla bellezza (gentilezza, natura, sottomissione) e non alle loro capacità (intelligenza, determinazione, autonomia) si deve fare un lavoro costante, indefesso, che non ceda a nessuna tentazione. Si deve per un verso vigilare e denunciare, dall’altra – secondo me l’aspetto più interessante e determinante – si devono costruire nuovi modelli, un nuovo immaginario, un nuovo simbolico. La vittoria dei Dem, con la prima vice presidente donna degli Stati Uniti, ha un valore in questo senso: costruire un immaginario diverso, dove per le donne non conta la bellezza. Contano invece le proprie capacità. Kamala Harris, subito dopo la notizia della vittoria democratica, ha detto una frase bellissima riferita alle giovanissime: vedendo dove è arrivata lei, le ragazze avrebbero capito che la Casa bianca è una possibilità anche per loro. Questo vuol dire costruire modelli diversi, immaginari diversi, che cambiano anche il nostro modo di percepire noi stesse. Il modello della bellezza come segno distintivo dell’essere donne è un fatto che abbiano introiettato da una storia millenaria. Lo sforzo di mettere in discussione quel modello lo dobbiamo fare per prime noi, sapendo che è un lavoro lungo ma fondamentale. Non cederei però in questo senso a censure o critiche nei confronti delle singole che sfruttano la loro bellezza, come a volte accade, sbagliando totalmente l’obiettivo. Solo moltiplicando i modelli possiamo uscire dallo stereotipo costruendo identità libere, anche da questo punto di vista.
Molti ragazzini, ma soprattutto molte ragazzine fin dall’adolescenza sviluppano alcuni disturbi legati all’aspetto fisico, indirettamente imposto o implicito dai canoni e dai modelli diffusi, più o meno sottilmente (ma spesso ostentati) a livello sociale e mediatico, che impongono di essere belli, magri, realizzati, fisicamente tonici, di successo ecc… Questo il più delle volte genera frustrazione e senso di inadeguatezza che si protrae fino all’età adulta, portando anche, nei casi più gravi, a forme di depressione o a suicidi, che sono aumentati anche in età giovanissima. Come o chi può agire per sovvertire questi modelli o per far sì che non divengano così determinanti nella crescita di una persona? Sicuramente l’educazione e la scuola hanno un ruolo fondamentale ma la pressione sociale e gli imperativi della società e dei media diventano comunque molto difficili da scalfire o da non immagazzinare come dati oggettivi e massime kantiane…
La bellissima serie We are who we are di Luca Guadagnino, di recente proposta su Sky e Now tv, racconta il mondo dell’adolescenza in un modo finalmente libero dagli stereotipi di genere. E fa vedere come la dualità maschile/femminile sia una costruzione che incastra le identità. Io penso che il discorso sullo stare male di tante ragazze e tanti ragazzi vada visto anche da questo punto di vista. Nel momento in cui non si sa bene chi si è, in cui si è alla ricerca di se stess*, ragazzi e ragazze trovano davanti il muro dello stereotipo, dei ruoli, del predefinito dal punto vista sessuale e fisico. Non è così nella realtà psichica. Questa discrepanza genera dolore, smarrimento, solitudine e porta spesso anche ai casi di bulimia a anoressia molto diffusi nell’adolescenza. Sono sintomi di un corpo che si sente imprigionato in un aspetto che viene imposto socialmente. La scuola, il cinema, le serie tv, le televisioni generaliste, il web: tutte queste realtà devono fare lo sforzo, oggi più che mai, di liberare le identità e far capire a chi attraversa l’adolescenza che nessuno, nessuna, nessun* è sbagliat*.
Vi è anche una polemica insita all’ambito del linguaggio. Vengono rifiutati termini come “avvocata”, “presidentessa”, “vigilessa”, “ministra” e simili in nome di una purezza linguistica, come se questi termini potessero contaminarla risultando cacofonici. Simile polemica è nata dai tentativi, provenuti soprattutto da alcune figure che da anni si occupano di linguistica e di evoluzione della lingua (come Valeria Gheno ad esempio) per evolvere la lingua in senso più inclusivo. Penso alla questione dello schwa o dell’asterisco per permettere a tutt* coloro che non si riconoscono in uno dei due generi primari o che hanno una identità fluida e non definibile entro il metto binarismo di genere, di potersi riconoscere e poter trovare un’identificazione anche all’interno della pratica linguistica. Certo, penso siano cambiamenti che richiedono tempo per poter entrare a far parte della comunità di parlanti, ma spaventano un po’ reazioni conservatrici (ad esempio anche la Crusca si è totalmente dissociata dalle posizioni di Vera Gheno) che intendono la lingua come un monolite immutabile, mentre credo che questa sia in continua evoluzione e debba rispecchiare i mutamenti della società, se non addirittura fungere da primo catalizzatore virtuoso, perché a volte le parole possono determinare cambiamenti importanti. Tu che opinione ti sei fatta di questo dibattito che è linguistico, politico e sociale al tempo stesso?
La lingua è per definizione qualcosa che evolve. E non lo diciamo né io né lei. Lo dice la linguistica. Una lingua che non si apre ai mutamenti del mondo, è una lingua morta. Quindi le resistenze all’uso del linguaggio sessuato sono segnate non dall’amore per la lingua, ma per i propri privilegi. Sono la difesa di un mondo che invece va messo in discussione. Sull’uso di una lingua che tenga conto della complessità individuerei due passaggi. Il primo è quello che rappresenta la rottura dell’Uno maschile universale neutro: l’ingresso – con pari dignità grammaticale – del femminile rappresenta anche concettualmente il riconoscimento che il mondo non è composto solo da uomini. L’avvocata (e non l’avvocatessa), la presidente, la medica, la ministra: sono tutte parole che indicano questa fondamentale rottura. Ma la rottura dell’Uno maschile non deve fissarsi in una nuova dualità. L’ingresso del Due deve essere l’apertura al molteplice. Siamo così al secondo passaggio dove l’uso dell’asterisco è la rappresentazione di questa molteplicità, di questa fluidità che attraversa la società. Il femminismo è per me la costruzione dell’apertura: la contrapposizione iniziale all’Uno maschile va intesa come un primo passaggio per poi stare dentro il divenire delle soggettività.
La performance di genere, come la chiama Judith Butler, agisce fin dalla prima infanzia. I maschi devono giocare con le macchinine, con le pistole, devono vestirsi di azzurro, a una certa età è bene che non giochino con bambole o cucinine, non devono piangere, devono essere forti, farsi valere e sapersi difendere, viceversa le bambine si vestono di rosa, si fanno giocare con le bambole e la cucina. Se fin dalla prima infanzia vengono incuneate e di conseguenza, via via che cresciamo, interiorizzate queste norme di genere come si può intervenire per far sì che poi queste norme non agiscano sul nostro senso comune, indirizzandoci a determinate performance di genere? Chi non rientra nelle maglie del binarismo di genere diventa spesso un soggetto inintelligibile, spesso anche oggetto di scherno o addirittura violenza verbale e fisica. Si pensi anche all’osteggiamento, proveniente non solo dal mondo della destra, ma anche da movimenti lesbici femministi, contro il Ddl Zan….
Dobbiamo essere tutt* grat* a Judith Butler per come ha spiegato la costruzione del genere. Però la mia generazione deve anche tanto a Dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti che ha riscattato la vita di tante di noi. Ci ha spiegato che giocare a calcio o con la fionda, stare tutto il giorno all’aria aperta, fare la guerra tra bande, non era prerogativa biologica dei maschietti, che desiderare quei giochi era anche un nostro diritto e che era l’educazione che ci condizionava provando a farci sentire in colpa. Il blu e il rosa, la libertà e la gentilezza, la voglia di esplorare il mondo e il desiderio di maternità: sono tutte dicotomie imposte ancora prima che si nasca e che diventano regole, tabù da cui è difficilissimo liberarsi. Mi fanno ridere (o piangere) coloro che dicono: ma mio figlio ama la fionda, mia figlia la bambola, come si trattasse di scelte libere, non condizionate. Il genere è una costruzione complessa in cui confluiscono vari fattori tra cui l’identità sessuale, di classe, di religione, di cultura. La teoria che mette al centro il costrutto di genere comporta la rottura della dicotomia maschile/femminile. Invece in Italia un certo femminismo, scaturito dal pensiero della differenza sessuale che negli anni 80/90 in Italia dettava legge, resta dentro quella dicotomia, ribaltando esclusivamente il segno del femminile a cui viene data pari, anzi più dignità del maschile. È un rovesciamento che però non produce libertà, ribadendo lo stesso schema. Da qui il fatto che una parte del movimento femminista lesbico contrasti il Ddl Zan perché riconosce l’esistenza di altre identità fuori dello schema uomo/donna. È una posizione dal mio punto di vista reazionaria e pericolosa.
Tu ti definisci femminista. Che significa per te definirsi in questo modo? E perché dobbiamo essere femminist*?
Perché significa mettere in discussione la cultura patriarcale fondata sulla supremazia di un sesso sull’altro, sulla costruzione di stereotipi e ruoli e che ingabbiano le libere soggettività. Per me il femminismo significa la costruzione di una società e di individualità libere. Il femminismo come movimento è la rivoluzione più lunga e più efficace. I femminismi sono una risorsa filosofica e politica che pensa dal profondo una cultura diversa. Sono stati fatti grandi passi avanti, ma ancora tanto resta da fare. Combattiamo contro una cultura millenaria, non bastano un paio di secoli per sconfiggerla. La strada è lunga. Soprattutto se l’obiettivo è la libertà di tutt* coloro che la cultura patriarcale ha messo fuori dalla regola: donne, mostri, migranti, cyborg. Il mondo è nostro, deve essere nostro. Di tutt*.
Citando Simone De Beauvoir donna non si nasce, ma si diventa. Cosa significa per te questa frase? Esistono secondo te prerogative biologiche/innate che differenziano gli uomini dalle donne o sono soprattutto categorie storico-culturali che abbiamo finito di interiorizzare come dati e differenze biologici e naturali?
Su questo ho una posizione radicale. La biologia è già una costruzione discorsiva. Non esiste la biologia come concetto avulso dal contesto, come concetto, appunto, puro, assoluto. Esiste la nostra idea di biologia, segnata storicamente. La biologia è già cultura. E quindi non posso che prendere alla lettera quanto dice Simone De Beauvoir: donne non si nasce, donne si diventa. Questo vale anche per gli uomini. Uomini non si nasce, uomini si diventa. Creare la contrapposizione biologia/cultura è una falsità che va radicalmente criticata. Peccato che il femminismo essenzialista continui a cadere in questa trappola. Penso a quello che ci ha insegnato la psicoanalisi: la molteplicità e l’individualità con cui ogni riferimento alla nostra storia biologica viene elaborato dalla psiche. Cade così ogni costruzione dogmatica: uomo/donna, etero/omo, maschio/femmina, natura/cultura…
Ti definisci anche antigiustizialista e ti sei occupata molto della questione carceraria. I detenuti sono soggetti invisibili e invisibilizzati, che spesso vedono scemare i propri diritti e soprattutto la stessa identità e dignità umane, non sono riconosciuti come soggetti agenti e degni di riconoscimento e diritto, tant’è che anche in Italia la situazione delle carceri è deleteria, per le condizioni dei reclusi, per l’ottica punitiva anziché rieducativa, per la mancanza di spazi idonei, di attività volte all’umanizzazione delle persone detenute e che conferiscano dignità alla loro vita sia tra le sbarre che a quella che potrebbero avere una volta uscite. Come potrebbe intervenire la politica su questo enorme problema, che porta a sofferenze, depressioni, addirittura suicidi da parte dei e delle reclus*, le cui condizioni sono ulteriormente peggiorate nel periodo Covid-19?
Più volte in questi anni, nei giornali in cui ho lavorato, abbiamo titolato: aboliamo il carcere. È l’unica strada. Le persone veramente pericolose in carcere sono poche, per il resto diventa un luogo dove nascondere problemi sociali o psichici (le Rems, dove dovrebbero essere ospitate le persone con disturbi psichici, funzionano poco e male), dove occultare povertà, disagio. Ci sarebbero molti modi diversi per applicare l’articolo 27 della Costituzione là dove si parla di rieducazione della pena. Ci sono o se non ci sono vanno creati. Ma si deve fare in modo che la punizione sia una occasione per scontare la pena riabilitandosi. Invece questo succede molto poco. Le carceri sono sovraffollate, mancano i servizi minimi di assistenza. E oggi che c’è il Covid sono una bomba epidemica pronta ad esplodere, anzi che sta già esplodendo. Il problema è che nella società, purtroppo anche a sinistra, il giustizialismo trionfa. Più il carcere è duro, più si afferma lo Stato come vendetta, più i cittadini si sentono soddisfatti. Bisognerebbe fare una grande battaglia politico-culturale per spiegare due principi. Primo: una società fondata sulla vendetta (perché questo è oggi il carcere) è più violenta. E se è più violenta, lo è per chiunque, anche per noi, anche per chi sostiene questa idea del carcere. Il secondo principio è che una società fondata sulla vendetta è meno sicura. La recidiva scende in maniera drastica quando i detenuti possono accedere a misure alternative al carcere. Invece oggi – grazie anche e soprattutto al sistema mediatico, anima del giustizialismo – se un detenuto lavora in una cooperativa si ritiene che non stia scontando la pena. La pena viene intesa come sofferenza. Esattamente il principio della legge del taglione. Siamo tornati a questo punto. Si chiama barbarie. Si chiama inciviltà.
Sei anche molto attiva sulla questione migratoria. Quali pensi che potrebbero essere le strategie per affrontare la questione, senza cadere nella retorica dell’emergenza che mette a tacere anche dati e statistiche comprovati ma che purtroppo non fanno presa su quella che è diventata la costruzione e la rappresentazione sociali dominanti?
La questione migratoria è emblematica di quest’epoca che stiamo attraversando. Ci sono fenomeni globali che spingono i popoli a migrare e c’è chi invece di ragionare su che cosa fare per affrontare questa situazione, nel rispetto del principio dell’uguaglianza tra esseri umani, pensa a come bloccarli. La vita non è vita per tutti. Anche in questi giorni nel Mediterraneo sono morte sei persone, tra cui un bambino di sei mesi. È uno scandalo! È qualcosa di inaccettabile. Sull’accoglienza io penso che non si debbano fare sconti, penso che non si possa mediare. O si sta di qua, insieme a papa Francesco, o si sta con chi ha la responsabilità politica per i morti in mare. Veniamo da anni – a proposito di giustizialismo – in cui sono state criminalizzate le O.n.g. con accuse che si sono rivelate infondate. Intanto però è stato ostacolato il loro lavoro, rendendo ancora più difficile il soccorso in mare, mentre non esiste più da anni un piano europeo che salvi chi attraversa il Mediterraneo. La stampa ha una grande responsabilità: numeri sballati sui migranti (si parla di invasione quando è evidente che non c’è) si enfatizzano le accuse dei PM contro le O.n.g. (quando è evidente che non hanno nulla in mano) si dà spazio ai politici che lucrano sul tema aizzando le persone. Nel mentre siamo diventati un Paese più razzista e qualunquista. Non credo neanche alla contrapposizione tra migranti e chi vive in periferia: è una grande menzogna che mette gli uni contro gli altri. Contro questa cultura dobbiamo rilanciare i valori della solidarietà, della sorellanza e fratellanza, dell’uguaglianza. E per farlo si deve agire su due piani: modificare certo le condizioni materiali delle persone ma soprattutto rilanciare una idea diversa di società.

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.