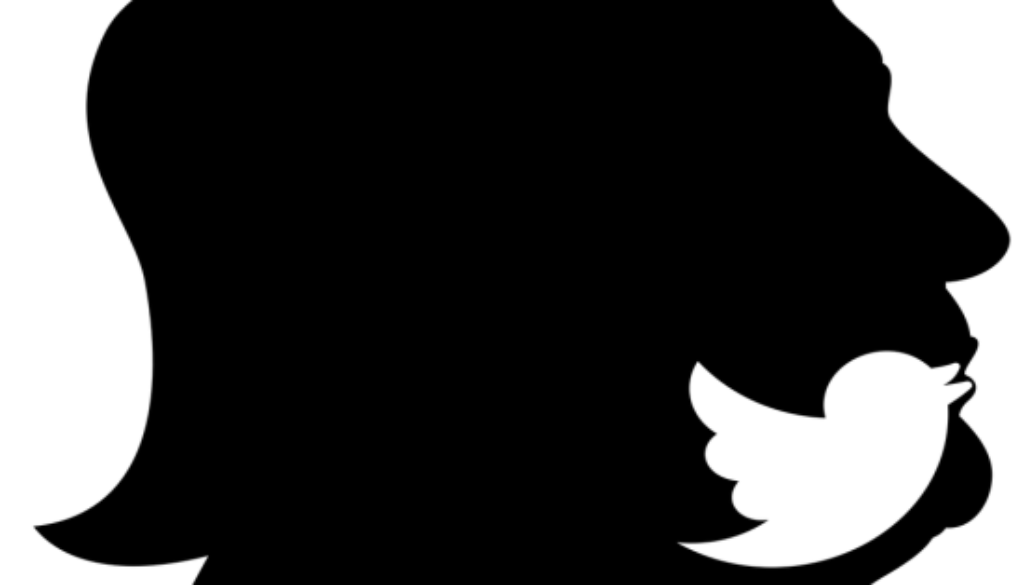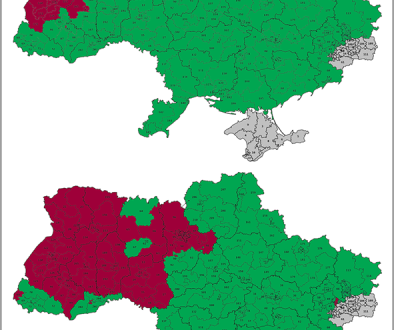Nella serata di venerdì 8 gennaio Twitter ha comunicato di aver sospeso a tempo indeterminato l’account privato di Donald Trump (sempre usato dal Presidente, a differenza dell’account pubblico che si limitava a ritwittare l’ufficio stampa della Casa Bianca). La decisione segue il blocco bisettimanale deciso da Facebook e controllate e un precedente blocco provvisorio della stessa Twitter. In quest’ultimo caso, pur avendo ottenuto la riattivazione dopo aver cancellato, come richiesto, tre cinguettii, Trump si è visto cacciato a vita per due ulteriori messaggi che a giudizio dell’azienda costituivano, nel contesto politico attuale, un continuato incitamento alla violenza.
La decisione ha sollevato numerose polemiche, anche di segno opposto: per alcuni è un atto tardivo, per altri addirittura una fuga dei social dalla responsabilità che condividono per aver fatto da megafono a Trump per anni; per altri ancora, il problema risiede nel potere di una grande azienda privata di silenziare personalità politiche anche di alto livello. Si ripropone ancora una volta quindi il tema dei confini della sfera pubblica, dei limiti alla comunicazione politica, nonché se un potere di censura debba esistere e, in tal caso, dove debba risiedere.
Francesca Giambi
Negli ultimi giorni l’attenzione sembra essersi spostata dalla preoccupazione per i fatti di Capitol Hill ad una discussione generalizzata sugli strumenti di comunicazione e sulla “censura”, con tantissimi articoli ed approfondimenti, online o fisici che siano (per esempio La Repubblica di domenica 10/01).Ammetto che in questo caso mi trovo un po’ in difficoltà, perché sento di non avere delle convinzioni “granitiche”, e che forse è anche sbagliato averne… in una sorta di “ma anche” che in questo caso cerca di coglierne la complessità.
La complessità principale è data dal fatto che i social network sono di fatto strumenti privati assurti a ruolo pubblico. La comunicazione istituzionale è ormai demandata a questi mezzi in una sorta di forte confusione tra ruolo pubblico e privato. Trump ne è proprio l’esempio principale, nel momento in cui la sua totale comunicazione è stata fatta attraverso il suo canale personale e non tramite quello ufficiale della Casa Bianca/del Presidente.Per questo bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di considerare in maniera diversa comuni cittadini e politici, anche per il peso e la possibile diffusione che possono avere le idee, regolamentando in maniera più puntuale: non possiamo più accettare “hate speech” da nessuno, a maggior ragione da istituzioni pubbliche.È questo che quindi ha spinto Facebook e Twitter a bloccare gli account dell’ex presidente americano? Che si sia davvero capito che c’è una forte relazione tra un messaggio e le azioni conseguenti? La speranza è che sia così, ma la “malizia” dice di no… Soprattutto perché l’intervento appare tardivo, come a mettere una pezza su una situazione reputata *ora* incontrollabile…
Dove era il dibattito su un eventuale “limite” alla libertà di parola in questi anni? Come mai non si è mai deciso di intervenire in maniera ferma su alcune situazioni, americane e non, che hanno innalzato il livello dell’odio e dello scontro sociale? Si pensa sempre (e qui forse tutto il mondo è paese) che si debba intervenire “a danno fatto”, ma in questo caso siamo andati oltre… proprio perché per le società private l’interesse principale non è certo l’etica…
Ma allora davvero la reale discussione da intavolare riguarda da una parte la stesura di una normativa precisa e senza ambiguità, dall’altra il ripensare la comunicazione politica e sociale anche al di fuori delle attuali piattaforme generaliste.
Dmitrij Palagi
In questi giorni WhatsApp ha aggiornato i termini di condizione di uso dell’applicazione per i messaggi. La cosa sta occupando alcuni spazi di informazione e alimenta i pensieri di complotto e bufale, o almeno così sembra indicare il dibattito pubblico. Lasciando da parte il sensazionalismo quante persone realmente leggono le condizioni poste dagli strumenti che vengono utilizzato nel quotidiano per aspetti centrali nella concretezza della vita delle persone?
Così le istituzioni e la politica hanno fatto con le reti sociali, utilizzando le piattaforme per raggiungere forme di consenso più immediato e meno faticose di altre pratiche, in modo analogo ad alcuni comportamenti individuali.
Quando CasaPound si è vista cancellare le proprie pagine Facebook c’è stata meno discussione. In fondo questa realtà di estrema destra non può essere paragonata al consenso elettorale del Presidente uscente degli Stati Uniti. Il problema però era lo stesso. Chi sta sui social pare abbia un vantaggio in termini di consenso elettorale e riconoscibilità pubblica. Perché? Questo è il tema.
Quanto potere di fatto hanno aziende monopolistiche? Che tipo di intervento si stanno immaginando per arginarlo? Queste discussioni sono relegate a piccoli ambiti militanti o a circuiti che applicano forme di dietrologia. Raramente sono oggetto di campagne politiche e programmi elettorali.Che le affermazioni delle istituzioni tedesche e francesi (critiche verso le decisioni di Twitter verso Trump) siano un segnale di qualche novità, almeno a livello europeo?
Il 1999 di Indymedia sembra davvero lontano, con la fine del movimento altermondialista è terminata anche una consapevolezza politica che pure sarebbe urgente recuperare.
Jacopo Vannucchi
La cosa che più mi stupisce non è che nel vasto campo del centro-sinistra vi siano i liberali che soffrono intimamente nel venire a patti col crollo di chimere in cui hanno creduto tutta la vita. Coloro che avvertono “attenzione a gioire per il blocco di Trump! Che direste se bloccassero i giovani di Hong Kong?” non colgono alcune cose.
1) Twitter non ha bloccato, per dirne uno, Nicolás Maduro. Segno che non opera una censura politica.
2) Twitter non blocca i giovani di Hong Kong, come non bloccò i giovani di piazza Tahrir.
3) Anche senza valutare quanto le twittate abbiano giovato a Hong Kong o all’Egitto, cosa è stato peggiore per gli Stati Uniti (dico, da una prospettiva liberale): silenziare Trump o avergli consentito per dieci anni di parlare?
Ma, appunto, non è questo che mi stupisce. Quando si può leggere che la democrazia liberale è “in crisi” (assalto fascista al Parlamento, strage di Covid-19, crollo del PIL) mentre la democrazia cinese “non è vera democrazia” (istituzioni popolari stabili, Covid-19 pressoché eradicato, PIL in crescita) si capisce che il problema è comprensibilmente cognitivo: una visione del mondo gli crolla attorno e non sanno che fare.
La cosa più stupefacente sono invece quei metacritici della sinistra non liberale che dicono: “attenzione a gioire per il blocco di Trump! Davvero volete che un colosso monopolistico metta a tacere la politica?”. Intendiamoci, il principio in sé è giusto: i monopoli economici non devono potersi imporre sulla politica democratica. Trump anzitutto non è democratico, ma restiamo pure al principio: questa “sinistra” (?) ci sta sostanzialmente dicendo che, siccome è iniquo che un privato censuri l’informazione, le piattaforme di informazione devono restare private e nessuno può esserne espulso. In breve, questa “sinistra” (?) difende in un colpo solo il capitalismo monopolistico e la propaganda fascista via web.Siamo così di fronte a un triplice livello di appiattimento sullo status quo: 1) quello popolare immediato, di chi è contento per la cacciata di Trump da Twitter senza porsi il problema dei monopolii; 2) quello intellettualoide-liberale, che si duole per la cacciata di Trump perché censurare l’informazione è in sé anatema; 3) quello intellettualoide-rossobruno (eh sì), che si duole per la cacciata di Trump perché è anatema che la censura provenga da un ente privato.Nessuno dei tre livelli riesce a scorgere la trave nel loro occhio, ossia che un programma di sinistra dovrebbe essere sia antifascista sia antimonopolista. Se i social media diventano uno spazio pubblico, allora devono essere difesi nel modo in cui è difeso lo spazio pubblico: con l’esercizio del diritto garantito dal monopolio della forza nelle mani dello Stato.Infine: i social media sono uno spazio pubblico, certo, ma non sono un servizio pubblico. Il fatto che molte forze e personalità politiche li usino come canale primario di comunicazione è ancora una volta il dito che indica la luna. Il problema vero è l’assenza di fondi affinché la politica possa comunicare in proprio, senza appoggiarsi a piattaforme esterne. Nella necessaria ricostruzione sociale post-Covid, se la avremo in Occidente, ci si dovrà occupare anche dell’autonomia finanziaria della politica.
Alessandro Zabban
I social in quanto strumenti di comunicazione sono anche strumenti di propaganda. Trump non è stato bloccato da Twitter per istigazione alla violenza, ma per istigazione alla violenza contro istituzioni americane. Quando i politici americani hanno aizzato i teppisti a vandalizzare il Parlamento di Hong Kong, nessuno si è sognato di chiedere a Twitter di bloccare i loro profili.
Di fronte all’assalto al Campidoglio, Biden ha detto che “l’America non è questo”. Ma invece l’America è esattamente questo quando si tratta di attaccare le istituzioni di Paesi non allineati con l’Occidente. È antidemocratico assaltare il Parlamento americano, mai quello Boliviano, Russo o Venezuelano. Allo stesso modo è riprovevole istigare alla violenza contro le istituzioni americane, mai contro quelle cinesi, cubane o nordcoreane.
Perché non si possono trovare regole comuni per limitare l’odio e la diffusione di idee pericolose sui social? Non per difficoltà tecniche nel limitare i poteri delle grandi piattaforme del web ma per un calcolo politico. Bloccare chiunque istighi alla violenza significherebbe bloccare anche chi giustifica le violenze squadriste in Bolivia, in Ucraina, a Hong Kong, chi vorrebbe attuare colpi di stato in Venezuela o in Bolivia, chi si augura che l’ascesa della Cina venga fermata militarmente. Gli stessi che si sono scandalizzati per l’assalto al Campidoglio sono gli stessi che hanno esaltato le violenze dei teppisti pro-Trump di Hong Kong o dei golpisti venezuelani e boliviani.
La regola d’oro della propaganda è quella di applicare sempre il principio “due pesi due misure”. Trovare delle regole standard per i social violerebbe questo principio. I valori liberali del rispetto delle istituzioni e della protesta pacifica sono sempre stati legati a doppio filo e sottomessi alla logica imperialista. In uno scenario di Guerra Fredda con la Cina, a essere bloccati sui social non saranno coloro che inneggiano alla violenza ma solo chi rischia di procurare un danno di immagine a un ordine Occidentale in crisi.
Immagine da www.pixabay.com

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.