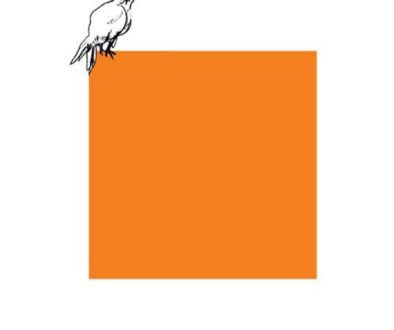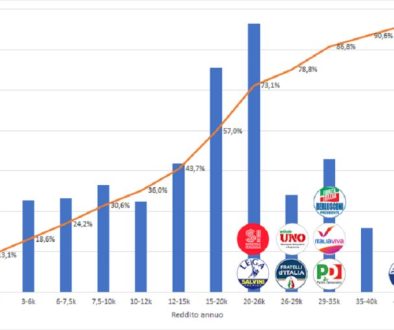Pubblicato per la prima volta il 3 agosto 2015
Forme
architettoniche postmoderne aggressive ed esuberanti, spaziosi
pavimenti dai colori sgargianti, altissimi soffitti con maestose
volte d’acciaio e vetro, in un incontro continuo fra terra e acqua,
oriente e occidente, è quello che si presenta agli occhi dello
spettatore che non può non rimanere incantato di fronte alla
abbagliante magniloquenza e ai continui richiami retro-futuristi del
Dubai Mall, inaugurato sei anni fa nel cuore della città degli
Emirati. Si tratta del più grande centro commerciale al mondo per
superficie totale, uno sconfinato spazio contenente 635 negozi, un
hotel con 250 camere di lusso, 22 schermi cinematografici e 120 fra
negozi e ristoranti che, pur nella loro smisuratezza, impallidiscono
al cospetto dell’enorme acquario e zoo sottomarino del mall, con i
suoi 10 milioni di litri d’acqua e le centinaia di specie marine
contenute o di fronte al grandioso parco tematico SEGA Republic,
dedicato ai videogiochi della celebre casa produttrice
giapponese.
Quello del Dubai Mall è solo uno degli esempi più
sgargianti e appariscenti di un più ampio processo di trasformazione
del modo in cui i centri commerciali in ogni parte del mondo vengono
progettati e costruiti. L’Ishafan City Center in Iran, col suo
spettacolare gioco di colori e preziosismi architettonici, il suo
museo e il suo centro finanziario internazionale o l’Americana at
Brand a Glandale, California con i suoi parchi e le sue fontane
“multimediali” sono altri esempi di un cambiamento avvenuto
recentemente e che attiene a nuove modalità tramite cui i centri
commerciali vengono ripensati puntando con sempre maggiore insistenza
su innovative forme di attrazione e di divertimento.
Fin dalle origini,
il successo dei centri commerciali è dovuto in primo luogo al loro
ruolo di palcoscenico dove viene messo in scena “lo spettacolo del
consumo delle merci”. Il sociologo urbano Vanni Codeluppi argomenta
che se la commedia si esprime al meglio in un teatro, la partita di
calcio in uno stadio, la merce, che rispetto alla sua necessità
funzionale, ha assunto storicamente su di sé significati sociali e
culturali legati alla distinzione di classe e all’appartenenza a
subculture, si manifesta modernamente in tutto il suo splendore
ostensivo nel centro commerciale. A questo luogo è richiesto dunque
il possedere un aurea seducente e intrigante quanto le merci ivi
esposte: architetture monumentali e moderne, organizzazione spaziale
razionale e abbastanza prevedibile da risultare familiare, interni
eleganti e patinati, ampie vetrate che restituiscono il senso di
apertura e di spaziosità, luci al neon e pulizia per un senso di
sicurezza e di accoglienza massimi.
È questa finzione, questo
ambiente sterilizzato, ovattato, simulato che ha spinto l’antropologo
urbano Marc Augé a parlare anche per i centri commerciali di “non
luoghi”: quegli spazi della surmodernità che non sono preposti a
“generare né identità individuali né relazioni, solo
solitudine e similitudine […] non c’è posto là per la storia a
meno che non sia stata trasformata in un elemento di spettacolo, di
solito nelle forme di un testo allusivo. Ciò che regna là è
l’attuale, l’urgenza del momento presente”.
Contrariamente
al luogo antropologico, che è un territorio occupato da un
popolazione che lo abita e che in esso iscrive i propri significati
storici, culturali, sociali e che si caratterizza per la costruzione
simbolica dello spazio, il non luogo è caratterizzato dal semplice
transitare di persone, è uno spazio senza storia ed identità,
designato per certi fini specifici come l’acquisto, il relax o il
viaggiare e in cui non vi accedono persone in tutta la loro
complessità e multidimensionalità ma solo in quanto clienti,
consumatori o passeggeri.
A regnare nel non
luogo non sono leggi sociali e istituzioni culturali locali, mediate
da persone fisiche, ma messaggi testuali come la piantina
dell’edificio, pubblicità, divieti di transito, cartelli di
informazioni. Si tratta di un sistema di immagini che tende a creare
un sistema, un sistema all’interno del quale identità e storia
sono abolite, decontestualizzate e rese merci per diventare parte
dello spettacolo stesso (riproduzioni di statue greche, manichini
vestiti secondo gli abiti tipici della Scozia rurale dell’ottocento,
finti mosaici bizantini, caffè che riproducono le atmosfere fumose
di una Dublino proto-industriale, prodotti “tradizionali”
provenienti dall’Arabia e così via).
Si tratta di luoghi
dunque prevedibili, che si basano su semplici regole universali da
rispettare, in cui ognuno si può sentire a casa anche se lontano
migliaia di chilometri dal proprio paese e che permettono
all’individuo di non doversi mai mettere in gioco in relazioni e in
pratiche identitarie complesse: si entra e si esce da un centro
commerciale in qualità di consumatori. Non vi è ricerca, non vi è
esperienza, se non quella legata alla merce da consumare.
La sua capacità di
moltiplicare il potere attrattivo della merce, di generare la
sensazione di avere tutto a portata di mano, di emanare un’atmosfera
di sicurezza e prevedibilità, in un mondo esterno invece dominato
dal rischio e dall’incertezza, sono tutti elementi che ha garantito
a lungo la fortuna del centro commerciale.
L’emergere
dell’e-commerce, dell’acquisto online di prodotti tramite
modalità ancora più autistiche e solitarie di consumo e un esercito
di consumatori sempre più esigenti, soprattutto in occidente, di
consumare (anche) prodotti immateriali, ha però sancito, dall’inizio
del nuovo millennio, una fase di declino dei centri commerciali. A
seguito della crisi economica del 2007, che ha tolto potere
d’acquisto al ceto medio, il processo si è a tal punto
intensificato che ci si chiedeva se i centri commerciali fossero
giunti al capolinea. Il fenomeno dei così detti “dead malls”
faceva presagire un generale abbandono di queste moderne “cattedrali
del consumo”, usando la fortunata formula del sociologo Ritzer che
vede nei centri commerciali i nuovi luoghi sacri dove masse di
pellegrini vanno a passare le domeniche per venerare il dio del
consumo. L’errore degli analisti è stato quello di non considerare
il fatto che questa divinità postmoderna sa sempre come farsi
adorare perché ha dietro di sé sacerdoti estremamente abili nel
diffondere in modalità mediatiche e con linguaggi comunicativi
diversi il messaggio di fede.
Le grandi aziende
legate all’immobiliare e alle costruzioni, gli investitori nel
settore, hanno compreso che le forme tradizionali di centro
commerciale cominciavano a essere superate per il cliente occidentale
che si aspetta ormai modalità di consumo molto più accattivanti ed
espressive.
Se giovani e anziani non trovano più gusto a vagare
senza una meta per i corridoi labirintici del centro commerciale, ma
desiderano forme di divertimento più sofisticate come cinema,
mostre, parchi tematici o eventi sportivi, così anche la famiglia
vuole che lo shopping domenicale venga intervallato da momenti di
relax all’aperto, in cui far giocare i bambini a palla in un bel
parco recintato, sicuro e protetto. I vecchi centri commerciali,
tutti incentrati sui negozi e su qualche punto ristoro, avevano la
pecca di essere delle mere parentesi consumistiche in un pomeriggio
feriale, allettanti solo per appagare i desideri più materialistici.
Se questo modello ancora funziona nei paesi in via di sviluppo dove
queste modalità di fruizione sono ancora percepite come nuove e
moderne e tendono così ad attirare ancora moltissimi consumatori,
sempre più nel mondo occidentale si avverte l’esigenza, non certo
di porre un limite al consumismo, ma al contrario, di far sì che
quest’ultimo assorba ogni istante dell’esistenza umana.
Il
motto dei nuovi progettisti è quello di fare del consumo
“un’esperienza totale”, ovvero non solo materiale (legata
all’acquisto di vestiti, gioielli, elettrodomestici o prodotti
gastronomici) ma anche e soprattutto spirituale e legata
all’appagamento del desiderio di essere intrattenuti: ecco allora
che i nuovi centri commerciali propongono al loro interno sempre più
cinema, spettacoli teatrali, concerti, gallerie d‘arte, casinò,
centri estetici, aree gioco per i bambini, zone rivolte al relax.
I
centri commerciali sono ormai degli ibridi in cui forme di shopping
tradizionale si mescolano con attività culturali, del tempo libero e
di intrattenimento. Intrattenimento che viene usato per attrarre le
persone in modo che così possano spendere e acquistare prodotti. In
questo modo però la cultura espressa da musei, cinema, teatri,
gallerie d’arte, viene trasposta entro i confini di una zona
commerciale, completamente assoggettata alle logiche consumistiche.
Storia, arte, tradizione, invece di godere dell’autonomia
necessaria per risultare esperienze di accrescimento individuale e
collettivo, vengono tutte utilizzate al fine di spingere l’individuo
a consumare.
Neanche la politica rimane immune da questo
processo contagioso. I mall sono ormai dei veri e propri “community
centers” che tendono ad assumere sempre più il ruolo di spazi
urbani in cui le principali attività di una comunità cittadina
prendono luogo, togliendo alla sfera pubblica il ruolo di organizzare
le attività e incentivare la ricchezza culturale delle città. Ogni
aspetto della vita urbana è ormai inglobata entro un principio
economico fondato sul profitto e sul consumo, l’autonomia della
cultura dall’economia diventa così un anacronismo.
Occorre sottolineare
la forza ideologica tramite cui queste operazioni vengono compiute.
Nelle parole e nelle intenzioni dei grandi costruttori, questi nuovi
centri commerciali multifunzione, in grado di riportare l’individuo
di nuovo all’interno del non luogo, costituirebbero il trionfo
della socialità e dell’aggregazione contrapposta alla solitudine
del commercio on-line. Interpretati come la risposta postmoderna alla
richiesta di forme di condivisione e appartenenza collettiva, i malls
dovrebbero diventare il luogo nel quale la comunità si
incontra.
Augé ci insegna a non cadere in questa retorica: la
relazione sociale esito di uno scambio di mercato, o assoggettata
alle logiche consumistiche, è fittizia poiché manca quella
spontaneità e quel disinteresse che producono una vita comunitaria
solida, incentrata sulla solidarietà e sul riconoscimento
dell’altro. Riconoscimento dell’altro a cui una massa di
consumatori alla ricerca di qualche superficiale appiglio
identitario, non può e non vuole aspirare.
La trasformazione
dei centri commerciali in spazi ibridi, segna l’ennesima vittoria
delle logiche del capitale e l’assoggettamento sempre più
persistente di ogni aspetto della vita ai dettami dell’economia di
mercato. Gli spazi di manovra per invertire il processo sono stetti,
ma occorre tornare a reclamare il luogo anche come spazio di vita,
storia, cultura, relazione e non esclusivamente come spazio di
movimento delle merci.
Immagine di Christian Junker (dettaglio) da flickr.com

Nato nel 1988 a Firenze, laureato in sociologia. Interessi legati in particolare alla filosofia sociale, alla politica e all’arte in tutte le sue forme.