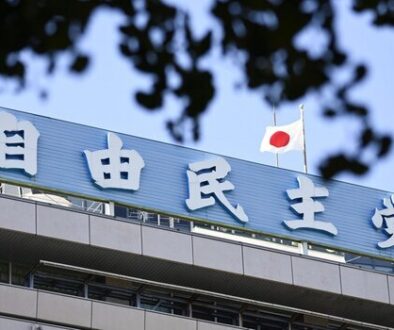Negli ultimi giorni ha girato sui social, attraverso numerosi siti di comune frequentazione, la notizia che il koala sarebbe funzionalmente estinto, dato che la sua popolazione conta solo 80.000 esemplari. Il confronto tra il numero (non enorme, ma nemmeno così minuscolo, soprattutto se confrontato con le abbondanze di altri organismi) mi ha immediatamente fatto dubitare della fondatezza della prima affermazione: l’unico tipo di organismo che mi viene in mente che possa essere considerato “funzionalmente estinto” con una popolazione di 80.000 esemplari è una formica. Una rapida ricerca, in effetti, conduce ad una drastica rivalutazione dell’affermazione: il koala è in declino un po’ ovunque, molte popolazioni, specie in aree suburbane, mostrano una diversità genetica ridotta e si estingueranno a breve, ma al momento non è possibile prospettare un’estinzione della specie, men che meno affermare che sia già funzionalmente estinta.
L’equivoco nasce in primo luogo da un’interpretazione ambigua del termine “funzionalmente estinto”. Questo termine in genere viene impiegato per definire una specie la cui popolazione è così rarefatta, dal punto di vista numerico e genetico, da rendere estremamente implausibile o impossibile un recupero. Un’estinzione funzionale è possibile anche in caso una popolazione includa ancora alcune decine o addirittura centinaia di organismi, specialmente in specie caratterizzate da una sex ratio (il rapporto numerico tra i sessi) estremamente sbilanciata, di solito a favore dei maschi, che porta a generazioni successive geneticamente sempre più omogenee, con la possibile diffusione di varianti genetiche deleterie e una maggiore sensibilità verso patologie.
La variabilità genetica di una popolazione, e la conseguente diversità a livello delle risposte a cambiamenti ambientali e malattie, rappresentano in un certo senso un backup che permette alla popolazione di sopravvivere ad eventi avversi. Nel koala (come in molti altri organismi) sta gradualmente venendo meno questo backup, che è in un certo senso più importante del numero bruto di individui, ma resta il fatto che ottantamila esemplari non sono pochissimi per un mammifero di media taglia. Il koala non può, quindi, essere definito funzionalmente estinto.
Esiste, però, un fenomeno in realtà molto più subdolo e molto più grave, rappresentato dalla perdita del ruolo ecologico. I koala sono tra i pochi organismi in grado di digerire le foglie di eucalipto, notoriamente coriacee, indigeste e ricche di sostanze tossiche, e rimettono in circolo una parte dei nutrienti contenuti in esse attraverso le feci, rendendoli disponibili per altri organismi; è verosimile che una diminuzione del numero di koala corrisponda a una minore efficienza del processo, ma con 80.000 individui non si tratta di un buon esempio di reale perdita di funzione ecosistemica.
L’entità del processo è invece chiara se guardiamo al mare, dove numerose specie, che spesso hanno un ruolo chiave negli ambienti marini, sono sempre presenti, a volte abbastanza semplici da osservare, ma sono talmente ridotte a livello di numerosità da non avere più un ruolo reale nelle dinamiche degli ecosistemi naturali. È il caso, ad esempio, delle balene, delle foche monache in Mediterraneo, degli squali o delle foreste di antozoi (coralli, gorgonie, antipatari). Tutti questi organismi esistono ancora, non sono ad immediato rischio di estinzione, in alcuni casi, come la foca monaca, osserviamo una leggera ma incoraggiante tendenza all’aumento, sia della numerosità, sia della diffusione.
Tuttavia questi organismi non hanno un ruolo reale nelle dinamiche degli altri organismi e degli ecosistemi che popolano – sono di fatto ininfluenti: secoli di modificazioni antropiche (l’estirpazione della foca monaca in quanto competitore dei pescatori, la pesca industriale di coralli, balene e squali) hanno cambiato drasticamente il funzionamento degli ecosistemi marini, che sono ad oggi semplificati, con flussi di energia dominati da poche specie molto abbondanti con cicli vitali molto rapidi.
Le specie chiave, relativamente rare, con cicli vitali lunghi, e in grado di controllare le dinamiche di popolazione di intere reti trofiche, sono sempre là, ma sono troppo rare per poter realmente avere un impatto. A loro volta, organismi con cicli vitali brevi sono più rapidi a rispondere ai cambiamenti climatici innescati da altre azioni umane, portando molto più facilmente a ricadute a cascata su interi ecosistemi. Per quanto negli ultimi quaranta o cinquant’anni abbiamo imparato a contrastare con una certa efficacia le singole estinzioni, la situazione è da certi punti di vista più critica di quel che potremmo immaginare, e la posta in gioco è molto più alta.
E proprio perché la posta in gioco è così alta, non possiamo permetterci il catastrofismo e la visione apocalittica vagamente compiaciuta che in questo momento dominano nell’ambientalismo. Sappiamo, dallo studio continuato su sistemi compromessi soggetti a totale protezione che il recupero è possibile, ma estremamente lento. La nostra generazione, ma probabilmente nemmeno quella dei nostri figli e quella dei nostri nipoti, non vedrà un mondo in cui balene, squali e foreste animali abbiano un reale ruolo ecologico. È una prospettiva avvilente, ma è necessario pensare che un giorno qualcuno che non conosceremo avrà la possibilità di vedere di nuovo quel mondo che abbiamo distrutto. Che è necessario cominciare qualcosa di cui non vedremo la fine, per riavere qualcosa che ci siamo tolti (e che in realtà non abbiamo mai conosciuto personalmente).
Il concentrarsi sull’estinzione delle singole specie, le grida d’allarme sproporzionate, la richiesta di cambiamenti irrealistici e superiori a quanto suggerito dagli studiosi del clima, non rappresentano una strategia utile per convincere i comuni cittadini dell’importanza di un intervento drastico in relazione alla crisi ambientale che stiamo attraversando. Al contrario, non fanno che instillare l’idea che tutto è perduto e non c’è nulla da fare se non avvolgerci in una coltre di senso di colpa ed aspettare la fine.
Proprio perché la situazione è così critica, questo non è l’atteggiamento giusto. Con due secoli di industrializzazione abbiamo danneggiato l’ambiente in una maniera tale che ce ne vorranno almeno altrettanti per avere un recupero non completo, percettibile. La strada è lunga e non ne vedremo la fine, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. Lo dobbiamo a chi verrà, ma prima di tutto a noi stessi.
Questo articolo deve molto ad un bellissimo intervento del prof. Sergio Rossi (Università del Salento) tenuto il 12 Giugno 2019 in occasione del 50° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), il cui abstract non è purtroppo disponibile online. È sottinteso (ma val la pena ribadirlo) che eventuali inaccuratezze sono comunque responsabilità dello scrivente.
Immagine Queensland State Archives (dettaglio) da flickr.com

Joachim Langeneck, assegnista di ricerca in biologia presso l’Università di Pisa, nasce a Torino il 29/11/1989. La sua ricerca si concentra principalmente sullo studio di processi evolutivi negli invertebrati marini, con sporadiche incursioni nell’ambito dell’etica della scienza, in particolare a livello divulgativo.