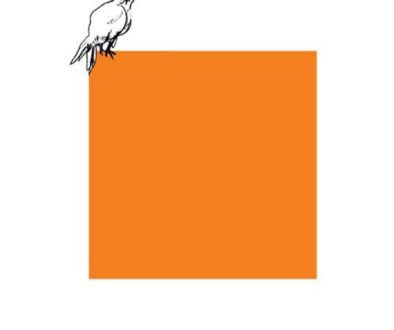Pubblicato per la prima volta il 7 agosto 2013
Un gesto di ospitalità non può che essere poetico
Jacques Derrida
Straniero. Dal greco Xenos. Nella voce presente su Wikipedia si legge: “Xenos può essere tradotto con straniero, nel senso di una persona proveniente da un altro stato greco e un viaggiatore straniero oppure una persona introdotta in una in una relazione di amicizia di lunga distanza. Xenos quindi si riferisce generalmente alla varietà di ciò che un particolare individuo può essere, in particolare, ospite, straniero, amico. E si legge ancora: “L’ambiguità del significato di Xenos non è un moderno malinteso, ma era di fatto presente nella Grecia antica. Può essere usato per riferirsi a guest-amici il cui rapporto è costruito sotto il rituale di Xenia (“guest-amicizia”). In tale uso è comunemente tradotto come “ospite-amico” per distinguerla dalla Philos, parola greca, che è stata utilizzata per fare riferimento ad amici locali e ai parenti non strettamente vincolata da Xenia”.
Fin da Omero, gli
stranieri-ospiti erano rivestiti di dignità e rispetto, in quanto
protetti da Zeus. Come sottolinea Umberto Curi, docente di Storia
della Filosofia all’Università di Padova, nella società omerica lo
straniero, essendo privo di diritto, viene accolto dalla comunità e
con questa stabilisce un rapporto di reciprocità testimoniato dal
Symbolon, una “tessera ospitale”, un coccio di pietra che,
come scrive Umberto Galimberti “spezzato in due testimoniava il
legame tra due persone […] Ognuno portava con sé il segno di una
comunione, di un patto amichevole che la distanza non poteva
annullare. Se poi accadeva di ricongiungersi, allora si procedeva
alla ricomposizione delle due metà, e l’unità così ottenuta
attestava, dopo l’assenza, un’intimità ininterrotta, un legame che
non era stato spezzato”.
Insomma, nella Grecia arcaica, gli
xenoi diventavano philoi, amici degni di rispetto e
benevolenza e rivestiti addirittura di una sacralità inviolabile,
garantita e assicurata dalla protezione di Zeus e di Athena. Per
questo chi commetteva empietà nei confronti dello straniero veniva
punito dagli dei. Perché lo straniero era un ospite e in quanto
tale sacro.
Così leggiamo,
nelle pagine dell’Odissea, al momento dell’incontro tra
Ulisse che torna a Itaca sotto le mentite spoglie ( grazie
all’incantesimo di Atena) di un mendicante e il suo vecchio e
fedelissimo servo Eumeo, che nonostante non riconosca il padrone che
si cela sotto quei poveri stracci lo tratta con dolce benevolenza,
proprio in forza del rispetto e dell’onore che si deve concedere agli
stranieri. Il libro XIV è infatti interamente occupato dalla scena
che vede il leale servo offrire i migliori doni al suo ospite,
addirittura il proprio mantello, necessario per uscire di notte per
governare le bestie.
“Ei, la riva lasciata, entrò in
un’aspra
Strada, e per gioghi, e per silvestri lochi,
Là
si rivolse, dove Palla mostro
Gli avea l’inclito Euméo, di
cui fra tutti
D’Ulisse i miglior servi alcun non era,
Che
i beni del padron meglio guardasse. […]
Poi, rivolto al suo
Re, […] gli disse […]
“Ma tu seguimi, o vecchio, ed al mio
albergo
Vientene, acciò, come di cibo, e vino
Sentirai
sazio il natural talento,
La tua patria io conosca, e i mali
tuoi.”
Ciò detto, gli entrò innanzi, e l’introdusse
Nel
padiglione suo […]
L’eroe gioiva dell’accoglienza amica,
E
così favellava: “Ospite, Giove
Con tutti gli altri Dei compia
i tuoi voti,
E d’accoglienza tal largo ti paghi.
E tu
così gli rispondesti, Euméo:
Buon vecchio, a me non lice uno
straniero,
Fosse di te men degno, avere a scherno:
Ché gli
stranieri tutti, ed i mendichi
Vengon da Giove.”
Dunque gli stranieri
erano ospiti. Anche in molte delle tragedie greche si ritrova questo
concetto. Si pensi al Filottete di Sofocle o al
Prometeo di Eschilo, nel quale la sacralità
dell’ospite appare in tutta la sua pregnanza laddove si espongono i
castighi riservati a coloro che offendono non solo gli dei o i
genitori ma anche gli ospiti, senza che vi sia una gerarchia tra
questi atti empi.
La reverenza nei confronti dello xenos
e della xenia appare anche in molte delle tragedie di
Euripide: nell’Ecuba ad esempio vengono pronunciate le
seguenti forti parole: “Nefando, innominabile crimine, al di là di
ogni stupore, empio, intollerabile. Dov’è la giustizia degli
ospiti [Dika Xenon]?” Nella tragedia euripidea dunque
l’essere inospitali nei confronti dello [echtroxenos] è
paragonabile ad un crimine immondo, innominabile addirittura [arreta
anonomosta] e punibile dagli dei.
In ciò emerge tutta
l’ambiguità del termine Xenos, che qui ha per l’appunto
l’accezione di ospite da accogliere nella propria casa e il cui
rifiuto, il cui rigetto “provocherebbe un male che va ad
aggiungersi ad altri mali”.
In un’altra delle tragedie di
Euripide, l’Alcesti, nella scena in cui compare Eracle a
chiedere ospitalità ad Admeto, re della Tessaglia, quest’ultimo si
rivolge al più forte degli eroi con tali parole: “che egli sia
accompagnato e a lui siano date stanze appartate; i servi preparino
cibo in quantità. Chiudete le porte che danno sul cortile. Non è
conveniente che i banchettanti odano i lamenti, perché gli ospiti
non devono essere afflitti”. Tutto ciò, perché – come
sottolinea lo stesso Admeto – “la mia casa non sa respingere un
ospite [apothein…xenous] né fargli torto [atimazein]”.
In questa visione si capisce perché il Coro possa riferirsi alla
casa di Admeto come “dimora di un uomo ospitale [polyxeinou]
e generoso” [eleutherou]”.
Anche in Platone
emerge l’obbligo di giustizia e rispetto che deve essere osservato
nei confronti dello straniero e l’importanza della xenia,
soprattutto nelle Leggi, nel quale, come scrive ancora Curi,
viene sottolineato “che i medesimi riguardi vadano riservati, oltre
che agli stranieri, anche alle straniere, col riconoscimento di
diritti non sempre attribuiti alle donne nella società greca.
Ricompare, in secondo luogo, chiarendosi ulteriormente, l’idea di
una relazione simmetrica nel campo dell’ospitalità, nel senso che
gli stranieri dovranno essere accolti nello stesso modo col quale si
pretende di essere accolti quando sia il nostro turno di andare
lontano dalla nostra patria.”
Anche il termine
latino hostis che indica lo straniero – in opposizione al
termine in-genuus che designa il cittadino, ovvero colui che
appartiene per sangue e cultura alla comunità d’origine – non
contiene in sé nessuna sfumatura di ostilità, come invece accadrà
più tardi, fino ad arrivare a quell’ambiguo binomio di
ostilità-ospitalità.
L’hostis inizialmente nel
mondo latino non era visto come un nemico che giunge dall’esterno con
intenzioni bellicose, ma era semplicemente l’altro, un altro che però
non aveva niente di negativo in questo. Nel De Officis
Cicerone usa questo termine per indicare “l’advena”,
ovvero semplicemente “colui che viene da fuori”, un peregrinus
proveniente dai confini esterni alla comunità, il quale, come si può
già vedere dalle XII tavole – corpo di leggi redatto nel
450-451 a. C. dai Decemviri Legibus Scribundis e che costituisce la
prima compilazione scritta di leggi nella storia di Roma – riceveva
gli stessi diritti dei cittadini romani in base a qualche accordo o
patto – non dimentichiamo inoltre che il verbo che sta alla radice
di hostis, vale a dire hostire equivale al verbo
aequare, che per l’appunto significa paragonare, rendere
uguale.
Solo successivamente il termine acquista una valenza
antagonistica, e hostis trapassa nel significato di inimicus
– sebbene non con la medesima esatta valenza, in quanto, mentre
l’hostis finisce per rappresentare il nemico pubblico, il
nemico esterno, il nemico della città di Roma contro cui tutti sono
tenuti a mobilitarsi, l’inimicus indica piuttosto il nemico
interno e privato, il concorrente, il concittadino con cui si ha una
relazione di antagonismo – così che lo straniero diventa un
nemico, da temere, respingere o combattere. L’hostis si
distacca perciò dal significato di hospes – ospite –
sebbene rimanga aperta la possibilità che il primo possa convertirsi
nel secondo e diventare oggetto di accoglienza e ospitalità.
Facendo un volo
pindarico si può arrivare al saggio di Jacques Derrida –
che in realtà è una raccolta di conferenze – intitolato
Sull’ospitalità. Qui il filosofo francese affronta diverse
tematiche – della sepoltura, del nome, l’identità, la lingua, la
memoria, la follia, l’esilio – “come segnali rivolti alla domanda
del luogo, che invita il soggetto a riconoscere d’essere per prima
cosa un ospite […] Come se il luogo coinvolto nell’ospitalità
fosse un luogo che non appartiene originariamente né all’ospite né
all’invitato, ma al gesto con cui l’uno accoglie l’altro.” (Anne
Dufourmantelle).
I due soggetti trapassano l’uno nell’altro,
non esiste più dualità netta tra di essi, così come ognuno di
noi in fondo è ospite di sé stesso, straniero persino a sé
stesso. L’altro è già dentro di noi, “io è un altro”,
direbbero Deleuze e Guattari, riprendendo l’espressione “je est
un autre” di Rimbaud.
Tornando a Derrida, per lui la
domanda sullo straniero è una questione venuta dal fuori “una
domanda allo straniero, rivolta allo straniero. Come se lo straniero
fosse innanzitutto colui che pone la prima domanda o colui al quale
si rivolge la prima domanda. Come se lo straniero fosse l’essere in
questione, la questione stessa dell’essere in questione,
l’essere-questione dell’essere in questione o l’essere in questione
della questione. Ma anche colui che, ponendo la prima domanda mi
mette in questione.”
La questione dello straniero è per il
filosofo “una questione interna al logos” – come è testimoniato
anche dal Sofista di Platone – che oltre a concernere la
questione sull’ospitalità riguarda anche la questione dell’essere e
del linguaggio. La prima alterità dello straniero è data infatti
dalla sua lingua. Egli deve esprimersi in una lingua che non è
la sua, è straniero in primo luogo rispetto alla lingua giuridica in
cui sono formulati i diritti e i doveri dell’ospitalità, i codici,
le leggi ecc. Deve chiedere asilo in una lingua che gli è imposta. È
forse questa è il primo sradicamento, la prima violenza. Perché la
lingua è una sorta di “casa mobile”, una patria che ci segue
ovunque ci spostiamo. La lingua dei nostri padri, dei nostri
antenati, la lingua in cui pensiamo, la lingua che ci portiamo
addosso come una seconda pelle, come un secondo corpo. E in cui ci
sentiamo noi, ci riconosciamo, sappiamo identificarci, in un certo
qual modo.
“Le persone che sono costrette ad abbandonare la
propria patria, gli esiliati, i deportati, gli espulsi, gli
sradicati, i nomadi hanno in comune due sospiri, due nostalgie: i
loro morti e la loro lingua” (Derrida).
Ho detto prima
violenza. Forse non proprio. La prima violenza, secondo Derrida sta
nel chiedere il nome a colui che
arriva. Come se il diritto di ospitalità fosse riservato
soltanto dopo che abbiamo riconosciuto uno status allo straniero,
soltanto dopo che lo abbiamo nominato, identificato, a cui abbiamo
fornito uno stato giuridico. Come se l’ospitalità non potesse esser
concessa all’anonimo assoluto, allo straniero assoluto, privo di nome
e di identità. Come se non potesse esistere l’ospitalità
incondizionata, quella che aprirebbe le porte a colui che viene,
senza chiedergli il nome, senza domanda alcuna sulla sua identità,
la sua discendenza e il luogo da cui proviene, o la direzione cui è
diretto.
L’ospitalità
incondizionata paradossalmente rompe quella che era “la legge
dell’ospitalità”, che prevedeva il riconoscimento e
l’identificazione dello straniero, che doveva presentarsi, dire chi
fosse e da chi discendesse. L’ospitalità assoluta che lascia entrare
il senza nome e il senza dimora e che non ha bisogno di interrogarlo
ma soltanto il desiderio di accoglierlo, di lasciarlo entrare,
contrasta con i vincoli imposti dal patto d’ospitalità, con quella
xenia che abbiamo prima accennato.
A differenza di
quest’ultima e delle sue norme, l’ospitalità incondizionata “esige
che io apra la mia dimora e che la offra non soltanto allo straniero
(provvisto di un cognome, di uno statuto sociale ecc..), ma all’altro
assoluto, sconosciuto, anonimo, e che gli dia luogo, che lo lasci
venire, che lo lasci arrivare e aver luogo nel luogo che gli offro,
senza chiedergli né reciprocità (l’entrata nella xenia, nel patto)
e neppure il suo nome. La legge dell’ospitalità assoluta impone di
rompere con l’ospitalità di diritto […]”.
Questa
ospitalità comincia dunque con l’accoglienza pura, senza domanda
alcuna, è un dono gratuito che si offre, semplicemente a colui che
arriva. Non importa chi sia o da dove arrivi. Lo si lascia venire e
basta.
Oggi, se già è rara o comunque non rispettata l’ospitalità di diritto, ancor più difficile è la possibilità che sia praticabile un’ospitalità assoluta. Coloro che arrivano ci fanno paura. Se non li conosciamo, se non sappiamo chi sono, se non possiamo identificarli, etichettarli sotto qualche nome ci fanno paura. Sono diversi. Sono cattivi. Sono nemici. Sono hostes che non riusciamo a far diventare e accogliere come hospes. Anche il diritto d’asilo, oggi, ha perso qualsiasi valenza. Ripudiamo e scacciamo lo straniero, senza renderci conto che nella società contemporanea siamo tutti stranieri gli uni agli altri. Essa ha snaturato completamente il significato di ciò che è vicino e di ciò che è lontano, che ha trasformato la distanza in motivo di paura o di esclusione o che l’ha annullata in una prossimità che è solo quella virtuale, quella dei social network o delle notizie viste attraverso schermi, in modo che non ci tocchino, non ci riguardino, in modo che non le sentiamo vivide e vicine.
È una prossimità fasulla che ci rende in realtà più distanti gli uni dagli altri, ognuno ovattato nella sua prigione più o meno dorata, insensibile al fuori, all’altro, agli altri. E tutto diventa più anonimo, noi diventiamo più anonimi ed estranei a noi stessi e al mondo che ci brulica intorno. Chi giunge dal fuori delle nostre stanze, delle nostre fortezze, dal fuori che ci appare abissale e pericoloso, porta con sé un sentore di minaccia intollerabile e ci serriamo ancora di più nei nostri nidi di cieca apatia, di ottusa grettezza mentale.
E nello stesso tempo nel mondo avanziamo senza sentirlo nostro, e in questo forse ci sentiamo ospiti. Ma ospiti che non sanno rispettare il luogo in cui vivono, il luogo che brutalmente trasformano per le loro esigenze sempre più eccessive. Siamo ospiti del mondo ma ce ne sentiamo i padroni. Gli altri sono nemici, concorrenti, minacce per la nostra incolumità, per la nostra bieca tranquillità, per la nostra quiete mediocre.
“Comincio a considerare straniero indesiderabile, e virtualmente nemico, chiunque invada la mia privacy, la mia ipseità, il mio potere di ospitalità, la mia sovranità. L’altro diviene così un individuo ostile del quale rischio di diventare ostaggio” (J. Derrida). L’advena se ne deve tornare da dove è venuto e con lui si diparte qualsiasi possibilità di arricchimento, qualsiasi risorsa preziosa che con la sua alterità, la sua diversità così ricca e pregnante, porta con sé, da tutti i punti di vista.
Solo chi ha il coraggio di aprire la sua dimora, di offrire il suo spazio, di intrattenere una prossimità e un’intimità autentiche, chi dona una sacralità allo straniero che bussa alle proprie porte, può crescere e diventare veramente soggetto, non più alienato in un mondo sempre più alienato. Solo chi ha il coraggio, come si legge in un documento – riportato sempre nel saggio di Derrida – intitolato Le leggi dell’ospitalità, non solo di far venire l’altro, ma senza indugio, senza tardare, di farlo “entrare dentro di sé, di farsi occupare, di lasciargli prendere posto in lui, di fargli prendere il suo posto”, può acquisire coscienza e consapevolezza di sé stesso, possibile solo con un rapporto, vero, con l’ altro. È questi che ci regala anche la nostra identità, è solo attraverso l’incontro e il dialogo con l’altro che essa può essere costruita. Il padrone giunge a entrare in casa propria solo grazie all’ospite, solo grazie al “desiderio d’ospitalità o al desiderio come ospitalità”.
L’ospite inatteso. Questo è uno dei doni che l’immensità del mondo in cui siamo, l’imprevedibilità delle trame infinite delle infinite esistenze ci offre. Nell’intreccio di vite che si toccano e si fondono, e nella possibilità meravigliosa che esse possano realmente entrare in contatto, non solo sfiorarsi, e tessere insieme altri fili, altri intrecci da snodare lungo le strade che percorrono. Ospiti gli uni degli altri.
Come scrive il poeta franco egiziano Edmond Jabès: “l’ospitalità è crocevia di cammini”. […] siamo “parti inseparabili – momenti – d’un corpo indivisibile nel desiderio insaziato che l’unione spezza”.
In fondo, probabilmente l’“Io è davvero un miracolo del Tu” (E. Jabès)
Bibliografia: Umberto Curi, Filosofia dello straniero
Immagine da Wikimedia Commons

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.