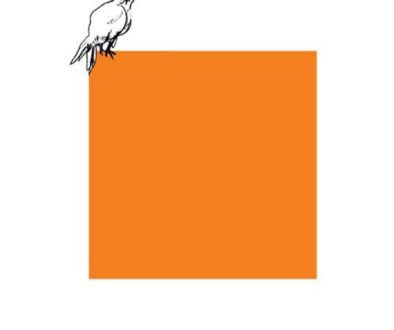“Maria, 50 anni ha un tumore. Potrà farsi uccidere”: questi e tanti altri cartelli simili stanno invadendo le strade delle nostre città per la campagna “#NoEutanasia”, che si oppone alla possibilità di una legge per regolamentare il tema del fine vita. Tralasciando le considerazioni in merito alla finalità di tutto ciò, è interessante osservare e discutere le modalità comunicative utilizzate.
Si è scelto di calare il messaggio nella realtà quotidiana dei destinatari, facendo parlare persone a loro vicine, in modo da rimarcare che la questione potrebbe interessare ognuno di loro.
Dietro questa modalità di comunicazione si ritrova la scelta di fare leva sui sentimenti di amore per i congiunti, e sul desiderio (umanissimo peraltro) di averli sempre accanto a noi: si fa ricorso a piccole storie in cui si cerca di dare un volto a un messaggio politico che, in caso contrario, rimarrebbe astratto agli occhi della gente, e non farebbe breccia nelle loro menti.
Ma
nella forza della strategia suddetta si palesa, se solo si arrischia
un’analisi un po’ più profonda, la sua stessa debolezza: l’uso di
una struttura fissa, pur essendo senz’altro un artificio che aiuta la
memorizzazione del concetto che si vuole veicolare, tende a
stereotipare il personaggio: ognuno dei protagonisti della
campagna è presentato solamente con nome, età e problematica.
Certo, non sarebbe possibile in un manifesto raccontare “vita,
morte e miracoli” di chicchessia, ma probabilmente non è
neanche desiderio degli ideatori di “#NoEutanasia”.
Infatti,
un identikit che lascia molto all’immaginazione permette il processo
di identificazione cui si accennava poco fa, mentre troppi dettagli
rischierebbero di far saltare fuori una differenza secondo la quale
si potrebbe pensare che la persona descritta “non è”
nostra madre, nonna o altro, e che quindi il problema non ci
riguarda.
Non si vuole dare il tempo a chi guarda il manifesto (magari mentre è nel traffico impazzito dell’ora di punta) di riflettere sulle ragioni che posso spingere “Maria” a optare per l’eutanasia, perché l’obiettivo è bloccare la possibilità di avere questa opzione: non è importante se si sta soffrendo orribilmente, o se sappiamo di avere un male che non concede scampo. Non si fa! E questo ci viene detto, come ad un bambino che vuole mangiare la seconda tavoletta di cioccolato in un pomeriggio: no e basta!
Ma c’è un’altra considerazione da fare, forse ancora più sconcertante di tutto quello che è venuto fuori sinora: la frase scelta per la campagna è “potrà farsi uccidere“. Non solo si mette in discussione la possibilità di scelta del protagonista della triste vicenda, ma chi vuole aiutare la persona a raggiungere il suo obiettivo si guadagna l’infamante marchio di “assassino”. Questa scelta lessicale disegna una vignetta nella quale una delle due persone, il malato, appare inerme (fisicamente ma anche dal punto di vista decisionale), mentre l’altra brandisce come un’arma la legge che permetterebbe, secondo i promotori della campagna, di compiere un omicidio legalizzato. Si carica dunque la situazione di ulteriore drammaticità (d’altronde si sta parlando di morte), aggiungendo la pesantezza dell’incolpare qualcuno (lo Stato?) di una decisione che è del singolo malato: la possibilità di usufruire di un diritto non implica assolutamente l’obbligo di usufruirne, al contrario l’assenza di leggi in tal senso impedisce il godimento di un diritto, quello ad una morte il più possibile serena, che dovrebbe essere sacrosanto e appannaggio di tutti.
Ne consegue che, agli occhi del pubblico di questa campagna, il malato perde la sua capacità decisionale e appare incapace di decidere per se stesso, in balia di chi non vede l’ora di disfarsene. E ciò non è vero per chi prende la decisione di andarsene perché riceve una diagnosi infausta. In quel caso, la decisione di “farsi uccidere” avviene in coscienza, e magari anche “in scienza”, ovvero supportati dalle informazioni e dai consigli di medici specialisti, che conoscono la patologia del paziente e possono dire la loro sulle opzioni di cura e sulle possibilità di sopravvivenza del singolo.
In questo senso la campagna di cui stiamo discutendo appare offensiva nei confronti del malato, perché lo spoglia della sua umanità, del suo raziocinio, dipingendolo come vittima inconsapevole di una legge che darebbe il diritto a terze persone di fare e disfare in materia di altrui sopravvivenza.
Quindi, quali armi può avere chi intende veicolare un messaggio opposto, ovvero la necessità di una legge che dia a chi soffre la possibilità di smettere di farlo, pur se non è in grado di agire per conto proprio? Siccome viviamo, volenti o nolenti, nell’era della comunicazione, la risposta (o comunque una delle risposte) è semplicemente: le parole. Una strategia potrebbe essere quella di studiare una nostra campagna di comunicazione, capace di usare le stesse armi per smuovere le coscienze, ma in direzione opposta: per convincere della necessità di legiferare in materia di fine vita soprattutto per tutelare coloro che non sono capaci di mettere fine da soli alla propria sofferenza.
Immagine da pxhere.com

Nata a Firenze il 17 novembre 1983 ha quasi sempre vissuto a Lastra a Signa (dopo una breve parentesi sandonninese). Ha studiato Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Firenze. Attualmente, da circa 5 anni, lavora presso il comitato regionale dell’Arci.