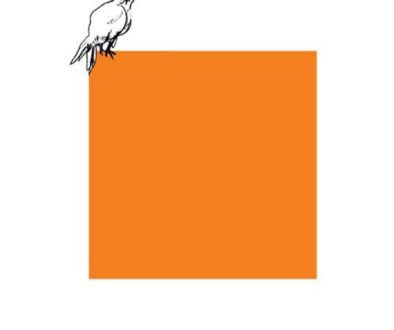I media contribuiscono alla diffusione e al radicamento del “potere”, sono il suo strumento, e oggi che i mezzi di comunicazione si sono moltiplicati a dismisura e sono diventati parte fondamentale, se non spesso addirittura esclusiva, del messaggio politico, hanno assunto il compito di de-strutturare la realtà, semplificandola e condensandola in più o meno micro-narrazioni funzionali alla perpetuazione del messaggio che si vuole mandare, dei “valori” che si vogliono imporre, del neoliberismo come unica opzione economica e ideologica, dell’insicurezza delle città invase dal nemico straniero.
La velocità delle informazioni non permette neanche una distanza da quel che leggiamo o guardiamo. Siamo assorbiti da immagini, da tweet, da likes, da post in un’iperproduttività e iperaccelerazione di informazioni, visive o verbali che siano:
“Come nuova forma di produzione, la comunicazione digitale abolisce in modo sistematico ogni distanza al fine di velocizzarsi. […] Nell’ipercoumincazione tutto si mescola con tutto. Anche i confini fra interno ed esterno si fanno sempre più permeabili. Oggi veniamo completamente esternalizzati in una ‘pura superficie di assorbimento e riassorbimento delle reti di influenza’”[1].
Il messaggio deve risultare immediato, comprensibile, sganciato dalla complessità del reale, per poter produrre effetti sulle masse, per potere direzionare queste ultime verso quel tipo di narrazione che stiamo costruendo. Oggi più che mai il dibattito politico si nutre di un linguaggio-spot, un linguaggio diretto, svuotato di analisi, indagine, approfondimento, complessità. È un linguaggio emotivo, che deve suscitare degli effetti, appunto, emotivi, in chi ascolta, senza portare all’esercizio del senso critico o della messa in discussione.
È così che narrazioni tossiche prendono il sopravvento sulla realtà dei fatti, sostituendosi ad essa. Si racconta una storia, una storia che, indipendentemente dal fatto che rispecchi o meno la realtà, debba risultare funzionale al messaggio che vogliamo mandare. E quel messaggio viene rimbalzato continuamente dalla cassa di risonanza divenuta enorme grazie al moltiplicarsi di strumenti mediatici che hanno il potere di far diffondere, pervasivamente, invasivamente, capillarmente, quel messaggio e di radicare in maniera ancor più profonda la narrazione. Narrazione che appare così incontrovertibilmente vera (proprio, o anche, a causa del suo ripetersi continuamente sugli schermi del cellulare, dei social network, della televisione…) da non necessitare un approfondimento di quello che stiamo ascoltando o leggendo, da non necessitare un’analisi che scavi oltre la cortina di un qualsivoglia semplice messaggio. Ci limitiamo (o per lo meno molti di noi) a reiterare quel messaggio fino a farlo diventare un dato di fatto, fino a renderlo reale, anche se spesso e volentieri è molto lontano dall’esserlo.
Si pensi, giusto per citare un episodio abbastanza recente, a quando le Ong sono state chiamate “taxi del mare”: da quel momento è calato il sospetto che le navi di soccorso abbiano dei rapporti di interesse con i trafficanti di esseri umani. A niente sono servite smentite da parte delle procure che attraverso inchieste hanno negato qualsiasi relazione tra Ong e scafisti. Ormai quel messaggio ha preso il volo e ci sarà sempre qualcuno che alzerà il dito contro le Ong gridando che fanno gli interessi dei trafficanti.
E qui non vogliamo entrare dentro l’immensa, tossica narrazione cucita intorno alla tematica dell’immigrazione e dell’accoglienza intessuta per tracciare dei confini identitari, etnici ed etici tra gli stranieri cattivi che vengono da fuori e i buoni cittadini autoctoni. Per citare un altro recente episodio, il 4 novembre, in occasione dell’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, la destra istituzionale (Fratelli d’Italia e Lega in primis) e non (Casa Pound) hanno costruito una narrazione ad hoc intorno a questa data: “«100 anni fa vincemmo la prima guerra mondiale. I nostri eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori. Oggi come ieri, non passa lo straniero». Così Giorgia Meloni, ha introdotto la campagna propagandistica “Nonpassalostraniero” (tutto attaccato, probabilmente per paura che qualche straniero invasore possa infilarsi negli spazi tra una parola e l’altra)”[2].
Come si legge in un ottimo articolo apparso su Jacobin Italia, si tratta di “marcare in senso pesantemente nazionalista, razzista e guerrafondaio l’anniversario della prima guerra mondiale, varcare coscientemente il confine tra commemorazione e celebrazione della carneficina del ’15-’18, fare un ulteriore passo in avanti nella ricostruzione di uno spazio di legittimità per il nazionalismo italiano, sepolto per decenni sotto la narrazione antifascista. L’appiattimento del ricordo della prima guerra mondiale sulla retorica della vittoria, della redenzione di Trento e Trieste e del sacrificio degli eroi contro lo straniero è funzionale alla riproposizione di un’unità nazionale posticcia, che nega conflitti e divergenze e mobilita il popolo a testuggine contro il nemico esterno, fornendo un provvidenziale scudo protettivo alle élite nazionali. […] La guerra dev’essere raccontata come difensiva, per poter dare spazio alla retorica dell’invasione. E l’appello all’unità nazionale contro il nemico esterno è il vero obiettivo di tutta l’operazione.[…] Un’unità nazionale organicista, dove spariscono interessi di classe e divergenze ideologiche, conflitti sociali e pluralità politica”[3].
Si crea un mito per mandare un messaggio. Si ricostruisce una narrazione che sia funzionale a quello che realmente ci interessa voglia arrivare nelle coscienze per creare consenso, per mobilitarle verso un tipo di pensiero, per annullarne il senso critico.
Ora, le narrazioni sono necessarie, servono a semplificare il reale, a renderlo accessibile, ma la narrazione non deve perdere il contatto, l’aggancio con la realtà. Dall’inizio dei tempi l’essere umano racconta storie per rendere viva e comprensiva la realtà che vive e lo fa attraverso strumenti visivi, plastici, discorsivi, simbolici, tecnologici. Anzi, potremmo dire che uno dei limiti della sinistra attuale è, anche, l’incapacità di creare narrazioni efficaci e in grado di fungere da alternativa alla narrazione xenofoba, nazionalista, sovranista della destra:
“Il tentativo della destra italiana di utilizzare il centenario della prima guerra mondiale per rilegittimare il nazionalismo è in atto, e ha trovato spazi e aperture non irrilevanti anche in un Partito democratico ormai perdutamente post-ideologico e astorico […] Difficile identificare ora un’alternativa in grado di contendere l’egemonia al nuovo nazionalismo. Nel campo politico ufficiale la sinistra sembra aver perso familiarità col mito, con la necessità di costruire narrazione identitarie che permettano alle persone un riconoscimento collettivo, con i meccanismi simbolici e discorsivi che creano solidarietà, attivazione e mobilitazione. […]Su questo, e su altri argomenti, sembra sempre più spesso che la battaglia della memoria venga combattuta da una parte sola”[4].
I miti e i simboli sono da sempre stati funzionali al racconto della realtà, a tessere radici, a innescare una memoria storica ed emotiva e a mantenerla viva facendone tesoro, nel bene e nel male, a radicare delle idee, a far circolare dei principi, a veicolare una certa visione del mondo, una Weltanschauung.
Secondo lo psicologo statunitense Jerome Bruner, ad esempio, è proprio la mancanza di costruire una mitologia ad aver mandato in crisi la società:
“La crisi della società è dovuta, secondo il suo parere, al fatto che non siamo più (e non siamo ancora tornati ad essere) una comunità mitologicamente istruita. Dopo la caduta dei grandi miti del passato, non ne abbiamo più costruiti degli altri, nonostante i numerosi tentativi e i ricorsi alle risorse dell’interiorità”.
Oggi potremmo in realtà dire che il meccanismo che regola le narrazioni di massa della società mediatica è del tutto simile a quello del mito. Così come i miti sulla fondazione e l’origine delle città, anche i miti, o meglio, più che di miti occorre parlare di narrazioni, propagandati dai mass media attuali sono funzionali, devono servire a qualcosa. Se i miti fondativi servivano a creare appartenenza, senso di identità e gloria (si pensi all’Eneide, ad esempio), oggi le narrazioni sono funzionali alla creazione di quelli che chiamiamo “valori” che, ad esempio, per una visione politica di destra, potrebbero essere identificati nella patria, nell’unità o nel “popolo” – definiti poi solo sulla base di una concezione nazionalista che non tiene conto della pluralità intrinseca – nella sicurezza e nella famiglia naturale.
“La narrazione nasce dalla creazione di un valore, il valore viene creato da un Destinante, il Destinante è sempre la società. Il Destinante è quindi il ruolo assunto dalla società per entrare a far parte della narrazione, di ogni narrazione. In quanto Destinante, la società si inscrive nella narrazione, rappresenta se stessa e trasforma così la narrazione in una rappresentazione sociale”[5].
La narrazione non dice come è la realtà, ma come dovrebbe o potrebbe essere se in essa si dispiegano quei valori che si vogliono radicare: “la narrazione è un modello molto potente perché favorisce l’immedesimazione, perché è un modello procedurale, perché è una sorta di “pacchetto” preconfezionato che contiene in sé un obiettivo (l’oggetto di valore), la condotta da adottare per raggiungere o per non raggiungere quell’obiettivo (il percorso narrativo) e la valutazione di tale condotta (in termini di sanzione o gratificazione)”[6].
Ma se è vero che i simboli e la costruzione di una mitologia sono stati fondamentali a dotare il mondo di un complesso di significati contingenti e anche trascendenti, da un punto di vista squisitamente politico, raccontare la realtà non significa capovolgerla, annientarla, cancellarla, camuffarla del tutto. Altrimenti il racconto del reale diventa solo un modo subdolo e ipocrita di orientamento e manipolazione del pensiero, diventa uno strumento di inculcamento e non di veicolazione, diventa la coperta che nasconde un reale del tutto diverso. Diventa occhio che rende cieca la realtà, e non un occhio che la rischiari, che vi getti una luce di comprensione, che riesca a manifestarla, anziché metterla a tacere dietro la mera finzione. La società finisce così per essere produttrice ma anche prodotto delle sue stesse narrazioni.
Le narrazioni servono a dare forma e senso al mondo che viviamo, a codificarlo, a “progettarlo” culturalmente, creando modelli, categorie e simboli per poter accedere alla sua conoscenze e alla sua interpretazione e per poterlo dotare di significato, altrimenti l’esperienza del mondo, dell’esistente, risulterebbe ingestibile, caotica, disordinata, terrificante, nel senso che saremmo disarmati di fronte all’inestricabile complessità del reale.
Ogni narrazione innesca un meccanismo di strutturazione della realtà senza il quale ci sentiremmo soverchiati da questa e da ogni tipo di esperienza. La realtà stessa ci impone, ci induce a darle dei significati, a tesserle intorno una trama affinché possa dispiegarsi a noi e rendersi più gestibile, più comprensibile, più manifesta. Il racconto, come accennato, è da sempre un mezzo convenzionale attraverso cui ci rappresentiamo la realtà dotandola di senso e fornendole un certo ordine, una determinata codificazione o interpretazione.
Ma se è vero che le costruzioni operate dalla scienza, dalle statistiche, dalla logica, dagli esperimenti, dagli studi, dalle indagini, vengono giudicate e validate (dotate cioè di un grado minore o maggiore di verità) in base al loro livello di verificazione o di falsificazione, il racconto, la narrazione, possono perdere del tutto il controllo rispetto a ciò che stanno raccontando, che stanno narrando. Sfuggono alle verifiche o alla falsificazione, per quanto comprovate possano essere. La versione o l’interpretazione del racconto non è regolata da verifiche empiriche o sperimentali, ma solo dalla sua necessità intrinseca di produrre, appunto, una narrazione del reale, al di là di quanto verosimile essa possa essere. Deve solo sembrarlo, verosimile. Deve apparire come vera, indipendentemente dal suo grado di verità. Deve produrre emotività, deve innescare qualcosa nel proprio interlocutore, senza indurlo a verificarla. Deve saper creare il suo “regime di verità”, per tornare a dirla con Foucault. Deve avere un certo potere di “plasmazione delle coscienze”, inducendole ad agire o a pensare in un certo modo, a formarsi una certa visione del mondo.
Ed è appunto quando la narrazione perde il suo legame con la realtà e diviene puro e vuoto slogan, messaggio senza reale contenuto, mera forma senza sostanza, involucro senza contenuto, apparenza, immagine, che allora perdiamo del tutto il contatto con ciò che realmente accade intorno a noi, fino a provarne distacco o straniamento. Siamo come spettatori inconsapevoli e incoscienti che guardano un film di fantasia o una fiction credendo che si tratti di un documentario.
“In questo modo la mimesis diventa una specie di elemento interpretativo, non copia la realtà ma ne fornisce una nuova lettura, è ‹‹un tipo di metafora della realtà››, dice Paul Ricoeur, e in quanto tale non è tenuta all’obbligo della necessaria corrispondenza con i fatti. L’uomo, narrando, dà forma all’esperienza, non la imita: crea la sua realtà in modo soggettivo, seguendo le regole strutturali del racconto e fornendone un’interpretazione che le possa dare voce, colore, forma e struttura in maniera metaforica e verosimile”[7].
Oggi siamo bombardati da micro narrazioni che ci raccontano un certo tipo di realtà e noi siamo così assuefatti a questo tipo di narrazioni da pensare che non ne esistano di alternative. Siamo come irretiti dentro un’unica enorme matassa di racconti da non sentire neanche il bisogno di andare più a fondo, oltre il racconto, oltre lo slogan, oltre l’immagine, oltre il messaggio, oltre la comunicazione, oltre il commento su un qualsiasi social media, oltre il post di qualche politico di turno, in un appiattimento ontologico in cui tutto sembra abbia lo stesso peso, lo stesso grado valoriale, che al massimo suscita un like o un dislike, senza produrre reazione e azioni vere, reali e non virtuali. È come se tutto rimanesse in superficie, sulla soglia, rimane la forma senza la necessità di trovare la sostanza.
Ma questa soglia non è quella che si prova di fronte a una trasformazione, giacché al di là della soglia inizia sempre un nuovo stato dell’essere, si spalanca l’ignoto ed è per questo che le soglie generano angoscia. Ma qui la soglia significa altro. Non è un passaggio a qualcosa d’altro, con la sua conseguente implicazione di un certo livello di dolore e negatività. Qui le soglie sono meri attraversamenti:
“Il passaggio ricco di soglie cede oggi all’attraversamento privo di soglie. Su Internet non siamo che turisti. Non siamo più l’homo doloris che abita le soglie. I turisti non fanno alcuna esperienza che implica trasformazione e dolore. Perciò restano uguali a se stessi. Essi viaggiano attraverso l’inferno dell’Uguale”[8].
-
Ivi, p.50. ↑
-
https://jacobinitalia.it/la-memoria-mutilata-del-4 novembre/↑
-
Ibidem. ↑
-
Ibidem. ↑
-
A. Perissinotto, Narrazioni di massa e rappresentazione sociale. ↑
-
Ibidem. ↑
-
http://www.assistentisociali.org/download/uploads/De-Lorenzo-M.-Racconto-e-costruzione-narrativa-dell-identita-in-Jerome-Bruner.pdf . ↑
-
B.C. Han, op. cit. ↑
Immagine da Wikimedia Commons

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.