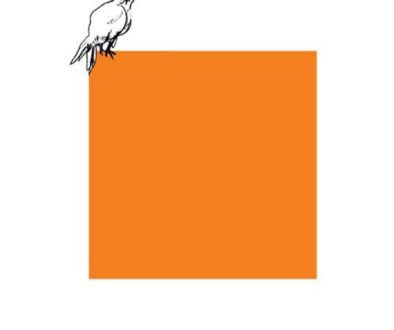Pubblicato la prima volta il 6 giugno 2014
“La bellezza è un enigma”
Fedor Dostoevskij
Giovedì 22 maggio 2014 di nuovo la bellezza è stata il tema di discussione che fanno parte degli incontri che ancora per qualche altro giovedì si terranno nella sala del Cenacolo di Santa Croce. Il titolo scelto dal relatore Gianluca Garelli, professore di Estetica alla facoltà di filosofia di Firenze, era “qualche considerazione su bellezza e trascendenza”. Anche Garelli, come Givone la volta precedente è d’accordo sul fatto che nel moderno processo di desacralizzazione anche la bellezza non passa indenne.
Quella relazione bello/vero o bello/buono che per molta tradizione filosofica e non, fin dall’antichità (si pensi anche solo alla nota formula kalos kai agatos presente già nell’epica classica di età omerica) sembrava imprescindibile non è più garantita né scontata, anzi. Furono i medievali a mettere in dubbio la legittimità nell’accogliere anche la bellezza tra i tratti fondamentali e caratterizzanti l’essere.
Holderlin nel 1800-1801 scrive quei versi molto noti tratti dalle strofe 6 e 7 dell’elegia Brot und Wein (Pane e vino). Già il titolo è emblematico, dato che pane e vino sono elementi sacri tanto al culto della religione greca – si pensi a Cerere, dea delle messi o a Dioniso, dio del vino – quanto a quello della religione cristiana – corpo e sangue di Cristo. Anche la scelta della forma elegiaca non è casuale, si tratta infatti di un tentativo di gettare uno sguardo al passato non privo di lancinante nostalgia. Si assiste a una sorta di continuità, da un lato e di discontinuità dall’altro. Continuità tra mondo classico greco e religione cristiana, come abbiamo detto e discontinuità tra la ricchezza di senso, di contenuti – divini soprattutto – di un passato irrimediabilmente lontano e la povertà, l’aridità, il vuoto di significato apparentemente incolmabile del mondo contemporaneo a Holderlin.
Riportiamo parzialmente alcuni versi:
“Perché non suggella più un Dio la fronte dell’uomo? (…) Tardi amico giungiamo. Vivono certo gli dei ma in un diverso mondo (…) La vita dopo è sogno di loro. Ma aiuta vagare. (…) Finché cresceranno eroi (…) verranno come un tuono (…) perché i poeti in epoca di privazione? (…) Per poco tempo l’uomo sopporta la pienezza divina”
nell’epoca nella quale Holderlin e l’amico cui è indirizzata l’elegia si muovono, un Dio non marchia più la testa dell’uomo.
Gli dei si sono rilegati a vivere astrattamente negli intermundia e lì vi si sono ritirati, indifferenti alla storia e al destino umani.
“Un ricettacolo fragile non sempre può contenerci”, ed è questa fragilità che impedisce all’uomo, ormai troppo misero, di essere all’altezza del ritorno del divino; “per poco tempo l’uomo sopporta la pienezza divina.”
Allora emerge il compito del poeta, il quale si dovrebbe incaricare di far risplendere la memoria di quei momenti di pienezza e ricchezza di senso, affinché la fragile e “insostenibile leggerezza dell’essere” non prenda il sopravvento, oscurando il mondo con la sua ombra e il suo vuoto, la sua squallida miseria, la sua terrena e insulsa opacità e far sì che l’uomo abbandonato da Dio al suo tragico destino ritrovi la forza di attendere il ritorno del sacro.
Quasi in risposta alla provocazione elegiaca di Holderlin, Hegel, non solo accoglie il senso d quest’ultima, ovvero che noi ormai “giungiamo tardi alla manifestazione del divino”, ma addirittura lo radicalizza, e lo fa nelle Lezioni di Estetica – appunti delle lezioni del professore di Jena, raccolti dai suoi allievi, in particolare da Heinrich Gustav Hotho – nel quale a un certo punto si legge:
“Questa è la nostra epoca. L’arte, dal lato della sua suprema destinazione, è e rimane per noi un passato (…) la sua forma ha cessato di essere il bisogno supremo dello spirito. E per quanto possiamo trovare eccellenti le immagini degli dei greci, e vedere degnamente e perfettamente raffigurati il Padreterno, Cristo, Maria, tuttavia questo non basta più a farci inginocchiare”
Certo, si potrebbe obiettare che ciò non è vero: che probabilmente qualcuno sente ancora l’impulso di inginocchiarsi di fronte a certe immagini di Maria, Gesù ecc… ma ciò su cui bisogna puntare l’accento è il fatto che Hegel qui non sta parlando per niente di “morte dell’arte”, come molti hanno frainteso. Secondo il filosofo tedesco l’arte sicuramente avrà un futuro, in cui potrà essere addirittura migliorata e perfezionata, ma non sarà più “ricettacolo” del divino, sarà abbandonata dall’elemento del sacro, non sarà più coincidente con la religione, con cui prima andava a braccetto – si parla di Bibia pauperum ad esempio – , ma sarà un’arte “semplicemente” estetica.
Le immagini artistiche continueremo ad ammirarle, ma non sarà la meraviglia e lo sbigottimento sacri a colmarci, bensì una bellezza puramente estetica che non è né sarà più capace di generare gesti di venerazione, un trasporto emotivamente religioso. Nell’osservazione hegeliana è presente un’estrema razionalità, il cui sviluppo storico è indirizzato sempre di più verso la fruizione meramente estetica dell’opera d’arte, o di una riflessione più concettuale su di essa.
Da Hegel ad oggi, ad esempio nell’ambito degli studi estetici, autori come Danto, hanno parlato di “abuso della bellezza”, come se per quest’ultima non ci fosse più posto, abuso che a mio avviso, forse emerge maggiormente nella nostra attualità, in cui assistiamo a un trionfo smisurato della tecnica e del progresso tecnologico/virtuale in cui sembra non ci sia più spazio per l’incanto e la meraviglia più intimamente profondi e carichi di senso.
Con questo ovviamente non significa che l’arte non ci sia più, ma si tratta di riconoscere che essa non è più la “manifestazione sensibile dello spirito”, dell’idea, il luogo di incarnazione del divino, il bello non è più il luogo in cui lo spirito si dà configurazione. Questo perché come abbiamo detto il processo di secolarizzazione “risucchia” anche l’arte. P. D’Angelo, in un libro del 2010, Estetica, scrive che la bellezza è un equivoco: parla di “significati non univoci” della bellezza, la quale dice cose molto diverse. Spesso si tende a dare un significato forte al termine bello laddove invece questo, a detta dell’autore, indica semplicemente un epiteto di apprezzamento. Nelle pagine del libro emerge l’idea che esprimere una valutazione in ambito estetico o morale riflette uno stato emotivo, senza possedere un valore assiologico, assoluto. Noi non siamo più in grado di spiegare in che senso parlare di bellezza significhi parlare di un attributo, una qualità della realtà e dell’essere.
Un ulteriore indizio del processo di de-sacralizzazione lo possiamo rintracciare, continua Garelli, in quella tendenza molto contemporanea a dare spiegazione del bello in chiave evoluzionistica: molti studi recenti infatti, avviati dagli ultimi decenni a questa parte, cercano di ricondurre il discorso sul bello al paradigma delle scienze forti e a modelli epistemologici quantificabili. Ad esempio si discute molto di un’ “estetica darwiniana”, un’estetica quindi legata alla teoria evoluzionistica di Darwin. L’idea alla base è che se vogliamo dare una spiegazione scientifica di cosa sia il bello bisogna dare una spiegazione sull’uomo e sulla storia della sua lotta per la sopravvivenza. Ma a parere del professore, certi valori, come quello appunto della bellezza se strettamente riducibili all’evoluzione non diventano che una metafora o si impoveriscono, dicendo ad esempio che la bellezza è identificabile soltanto come attrazione sessuale o molla innescante la perpetuazione della specie. Certo possiamo filologicamente ricostruire la storia della bellezza, ma tutti gli altri ambiti, come quello dell’arte, secondo una simile concezione assumerebbero soltanto un significato “metaforico”.
Un altro sviluppo recente è quello della neuro estetica: per molti studiosi è possibile immaginare che le scienze cognitive (che ricostruiscono le mappe neurali del nostro cervello) possano fornirci risposte precisi e fondate su come reagiamo a certe sollecitazioni; detto altrimenti: attraverso le neuroscienze è possibile costruire mappe cerebrali con cui verifichiamo che al cospetto di certe rappresentazioni artistiche, vi sono alcune zone del nostro cervello che si accendono come lampadine luminose la cui accensione diventa imput per individuare ciò che chiamiamo bello. Qui notiamo come il passo da questa considerazione alla realtà virtuale sia veramente minimo. Naturalmente quella della neuroestetica è una forma di “riduzionismo” importante, ma probabilmente non esaurisce quell’esperienza immediata e complessa che proviamo di fronte a ciò che ci appare bello, anche ciò che è inspiegabilmente bello. Mi sembra troppo ristrettivo e forse anche un po’svilente e triste ridurre tutte quelle emozioni, quello scombussolamento interiore, quel lancinante senso di inadeguatezza ed elevazione che proviamo di fronte a certe opere, sia artistiche che letterarie, o di fronte a qualche spettacolo della natura o dinnanzi a un bellissimo volto. Mi pare un po’ troppo avvilente pensare che tutto quello sciabordio in cui sembra naufragare dolcemente (tanto per parafrasare un po’ Leopardi, già che parliamo di bellezza!) il nostro io più profondo e intimo, sia solo il risultato meccanico di certe sinapsi che si accendono nel cervello. Sicuramente i neuroni ne sono toccati e partecipano in maniera dominante durante le nostre esperienze del bello ma vorrei credere che ci sia qualcosa di più, di più visceralmente misterioso nel segreto insondabile della bellezza e di quello che ci suscita. Forse ridurre tutto a automatici imput nervosi dissolve quella magica potenza del bello (di ciò che ci appare tale) che fa vibrare le corde più recondite del nostro essere, che ci fa sussultare e battere il cuore, che ci fa sentire vertiginosamente instabili su un crinale sospeso tra il cielo più alto e le profondità più abissali, che ci fa sentire teneramente a disagio e nello stesso tempo mai così sicuri di non aver mai desiderato altro che esser lì, in quella contemplazione totalizzante ed invadente di una bellezza che si riversa in noi come una cascata infinita, che ci travolge, ci assorbe completamente, ci rapisce trasportandoci in un altrove sconosciuto, che ci fa quasi pensare: ecco, ora posso anche morire felice, proprio perché mai mi sono sentito così vivo e così desiderante di esistere, ora, in questo luogo, in questo momento che si dilata all’infinito. Ma probabilmente si tratta solo di una mia speranza romantica, e può darsi che davvero tutto si riduca a vibrazioni di sinapsi e neuroni.
In ogni caso, comunque, già Kant aveva fatto una distinzione netta tra il giudizio di ragione o di conoscenza e quello di gusto, a cui non si può addurre la pretesa di verità. Il filosofo tedesco aveva intuito che se noi accompagniamo la bellezza alla teoria della conoscenza – nessi causali sul modello della meccanica, necessari e universali quindi – si perde l’esperienza immediata e autentica del giudizio estetico – di gusto – che prevede disaccordo e non perfetta armonia o necessità. Kant si preoccupava di preservare nel giudizio di gusto uno spazio che non esitava a definire di libertà. Se lo spazio della conoscenza (quello della teoria Newtoniana, del meccanicismo relazionale ecc..) è lo spazio della necessità, nella chiave di lettura del giudizio di gusto ne va invece di quella che è la libertà.
Tornando all’alternativa con cui abbiamo esordito, ovvero quella tra l’idea di Holderlin secondo cui attendiamo il ritorno del divino, e quella di Hegel, che beffardamente e provocatoriamente ci dice che ora non si può più aspettare questo fantomatico e utopico ritorno e che va ripensata totalmente la nostra contemporaneità, possiamo dire che esistono due vie per uscire da questa impasse, una regressiva e l’altra progressiva.
Nella prima via, quelle regressiva, si può immaginare di fermare il tempo. Come diceva Goethe: “fermarsi se è così bello”. Vi è una richiesta, un desiderio di arrestare l’attimo che fugge, cristallizzarlo in una sorta di eternità immobile da parte di una soggettività che aspira a riconquistare la sua “Elena” splendente – emblema della bellezza per eccellenza, anche il suo lato inquietante e oscuro, enigmatico o indecifrabile – , riportandola alla sua definizione classica, ricostruire il valore imperituro di quella bellezza perduta. Per fare questo però occorrerebbe fare un patto con il diavolo, dice Garelli, un compromesso con qualcosa che non può essere perdonato. Il tentativo di fermare il tempo ha alla sua radice l’idea che la bellezza sia matrice di qualcosa valido o dato per assodato una volta per tutte e che non ci resta che guardare nostalgicamente al passato come speranza per il futuro.
L’altra via, quella progressiva si può invece seguire prendendo come “guida”, paradossalmente, un autore come Marx. Paradossalmente perché costui è proprio il filosofo della struttura e della sovrastruttura, è per così dire iscritto al partito dei riduzionisti: per spiegare come funziona una certa epoca bisogna guardare ai meccanismi economici, laddove tutti i fenomeni culturali sono solo un prodotto secondario, una sovrastruttura del conflitto originario che avviene a livello della struttura economica di cui non sono che il riflesso, il rispecchiamento (detto in soldoni e semplificando molto). Eppure, un autore così razionale, nel saggio del 1859 “Per l’economia politica”ci sorprende. Qui infatti il filosofo de Il capitale dice che la relazione tra struttura e sovrastruttura si complica non appena andiamo a fare i conti con la bellezza:
“È forse possibile Achille quando esistono polvere da sparo o piombo? O in generale l’Iliade con il torchio e la macchina da stampa? Con il torchietto da stampa non finiscono necessariamente il canto, la leggenda, la Musa? Non scompaiono insomma, le condizioni necessarie per la poesia epica?”.
Oggi questo passo presente nell’introduzione del suddetto libro appare ancor più vero nella nostra epoca, in cui l’invasione sempre più pervasiva e rapida delle tecniche digitali non fa che allontanarci sempre di più dal canto, la saga, la Musa. Insomma, quello che qui sembra dirci Marx è che se la sovrastruttura fosse una conseguenza automatica ed immediata della struttura, come mai quelle opere della poesia epica, della tragedia, delle saghe ci sembrano ancora belle e capaci di destarci una meraviglia e un incanto incondizionati?
“La difficoltà tuttavia, non consiste nell’intendere che l’arte e l’epos greci siano legati a certe forme di sviluppo sociale. Consiste, invece, nel fatto che quell’arte e quell’epos ci assicurino godimento artistico e, in certo aspetto, valgano come norma e modello inarrivabile.”
Se è vero che la relazione tra struttura e sovrastruttura è necessaria, come mai la fruizione di una certa saga, di un epos ecc..continua a suscitarci tanto senso di bellezza? La risposta a tale questione la offre lo stesso Marx e va ascritta alla parola d’ordine, di nuovo, di libertà. Si potrà obiettare che questo è assurdo secondo la stessa logica marxista:
“come si fa a parlare di libertà? Non è forse vero che molte di queste opere belle sono state prodotte in epoche storiche in cui vigeva il peggior schiavismo, le ingiustizie più bieche, le diseguaglianze sociali più lampanti? Altro che libertà, e proprio tu, Marx, dovresti saperlo e rendertene conto meglio di chiunque altro!”
Eppure il filosofo ci dà spiegazione di questo apparente paradosso, di questa apparentemente inconciliabile discrasia tra un’epoca di ingiustizia e poca libertà e l’elogio del valore della bellezza considerata come qualcosa di autenticamente libero e destinato a durare per sempre nonostante i mutamenti storici o i progressi tecnici. Secondo il filosofo del Manifesto comunista si può parlare di libertà senza timore di contraddirsi proprio perché le opere classiche sono il prodotto di un lavoro non alienato.
Certo, è vero che nell’antica Grecia c’era la schiavitù, c’era ingiustizia sociale ed economica, c’era una relazione inquietante tra struttura e sovrastruttura, Marx non lo mette i dubbio, ma ritiene tuttavia che le opere sbocciate in quel periodo siano capaci di conservare un significato valido per l’avvenire perché lasciano trasparire la possibilità di un agire dell’essere umano che è totalmente e incondizionatamente libero, non vincolato ad esempio al rapporto lavoro-merce. Seguendo la via suggerita da Marx non c’è affatto bisogno di stabilire un patto col demonio rimanendo pietrificati nell’idea molto passivamente nostalgica e inerte del tipo “c’è stato un tempo in cui… E ora questo tempo non c’è più”, no, qui, quello che si propone è un prendere un aspetto di quell’epoca come stella polare da seguire e ripercorrere in nome di un fare che può orientare anche in avvenire un fare che agisca sotto il segno della libertà.
Nell’Ippia maggiore, Platone, aveva scritto “le cose belle sono difficili” ed aveva pienamente ragione, ma la possibilità di recuperare quella fratellanza tra bellezza e libertà potrebbe essere il passaggio fondamentale e inevitabile per fare qualche considerazione anche sul rapporto bellezza-trascendenza in un mondo sempre più secolarizzato e prosaico. È vero che oggi sembra che quando si pensa alla bellezza la si pensi in chiave di necessità: assistiamo a una bellezza sempre più canonizzata, omologata, conformista, consumistica, da vendere o a cui eguagliarci a tutti i costi, necessariamente. Propone modelli che sembrano dogmi indiscutibili che tagliano fuori coloro che se ne distinguono o se ne allontanano. Mentre la libertà, una bellezza genuinamente libera va cercata proprio dove non esistono simili canoni conformistici e omologanti.
Per chiarire il senso di queste ultime parole, Garelli richiama in aiuto Platone, in particolare il finale del Simposio. Qui, accade qualcosa proprio dopo che Socrate ha riportato il discorso della sacerdotessa Diotima, parlando della scala amoris nella quale l’attrazione per la bellezza può essere uno stadio ma non se è fine a sé stessa e ancorata all’attrazione per i corpi, il punto d’arrivo è astrarre dalla bellezza “di alcune cose”, dal bello particolare per elevarsi alla bellezza delle idee, del bello universale. Quello che accade, proprio quando Platone sembra aver raggiunto il suo scopo (la bellezza infinita del mondo ideale), è l’irruzione improvvisa di Alcibiade, che si lancia in una non esiterei a definire “dichiarazione d’amore a tutto tondo” per il maestro – e amante – Socrate, quell’amore che strazia l’anima, la annienta, la violenta, l’annebbia ma nello stesso tempo la anima con una forza da cui ci si lascia e ci si vuole lasciare vincere, a cui ci si abbandona perché annullandoci ci riaccende, facendoci precipitare nello stesso tempo ci eleva ad altezze altrimenti irraggiungibili, quell’amore “che strappa i capelli” direbbe De André.
Non è un caso che l’avverbio all’improvviso perché è proprio questo avverbio che più di tutti esprime il senso della bellezza. Essa è la dove non ci si aspetta, esplode, irrompe all’improvviso, come un baleno, un fulmine che abbaglia, che oscura tutto il resto con la sua luce o che tutto rischiara in quella sua unica luminosità. All’improvviso ci afferra e ci lascia ad essa appigliati, avvinghiati in un abbraccio dolce e dolente nello stesso tempo, che stringe fin quasi a soffocare e simultaneamente sprigiona da ogni poro del nostro essere un respiro totalmente liberatorio e appagato, avido di vita, bramoso di ancora, ancora bellezza: ogni piega del nostro corpo sembra supplicare di continuare ad esser lasciata riempire, di bere all’infinito, fin quasi ad annegare, dal vaso della bellezza. “riempimi, non finire di colmarmi, di possedermi, continua ad essere in me, lasciami entrare in te, siamo una stessa cosa”.
Sensazione immensa, improvvisa di sublime e terrore, di estasi e tremore, di pace assoluta e brividi incontrollabili. Questo è l’amore, l’amore per ciò che è bello, la bellezza è epifania, qualcosa che irrompe, phanei – appare – e quando irrompe ci sorprende, ci strappa dal nostro quotidiano e da noi stessi, dal torpore delle nostre vite “umane troppo umane” e ci fa salire in alto, ci mette le ali come direbbe sempre Platone. Così forse possiamo ritoccare quella trascendenza, quel senso del sacro che sembra irrimediabilmente inghiottito dalla moderna secolarizzazione in cui versiamo. Senza bisogno del diavolo, senza bisogno di uno sguardo anacronistico, ma solo lasciandoci sbigottire improvvisamente, solo recuperando quel senso di libertà che sta alla base di un agire che non è legato a una merce, a una necessità, a un prodotto, a un’imposizione, quell’agire che, inaspettatamente, all’improvviso, si rivela come un agire liberamente e incondizionatamente bello. Ed è proprio la libertà, per quanto svilita, umiliata, annaspante, a caratterizzare ciò che è più autenticamente umano.
“Niente è paragonabile. Esiste forse cosa / che non sia tutta sola con sé stessa e indicibile? / Invano diamo nomi, solo è facile accettare / e accordarci che forse qua un lampo, là uno sguardo / ci abbia sfiorato, come / se proprio in questo consistesse vivere / la nostra vita. Chi si oppone perde / la sua parte di mondo. E chi troppo comprende / manca il suo incontro con l’Eterno. A volte / in notti grandi come questa siamo / quasi fuor di pericolo, in leggere parti uguali / spartiti tra le stelle. Immensa moltitudine. “
Rainer Maria Rilke
Immagine da pixabay.com

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.