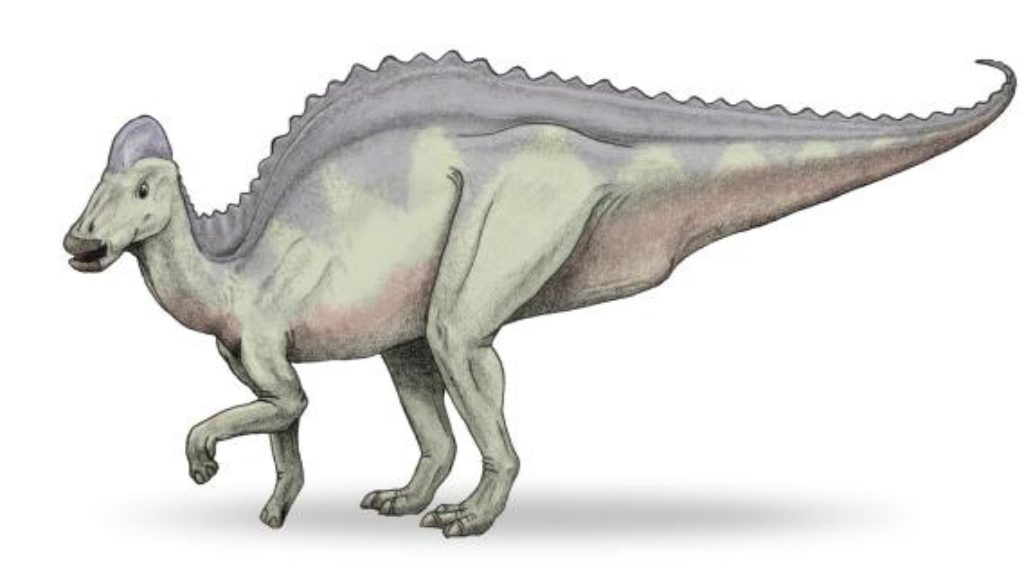Lo studio degli organismi estinti, anche di animali relativamente ben conosciuti come i dinosauri, è limitata dalla frammentarietà – e dalle condizioni di conservazione dei loro resti. Conosciamo la maggior parte degli animali estinti solo per i loro scheletri – il che significa che conosciamo una parte molto limitata degli organismi che uno scheletro non ce l’avevano – e contiamo su pochissimi fossili per quanto riguarda tutto ciò che non è calcificato. Il primo dinosauro fossile scoperto in Italia, Scipionyx samniticus, era particolarmente interessante non tanto per il dubbio primato, quanto per la presenza di residui degli organi interni; un po’ più frequenti sono impressioni di pelle e strutture epidermiche – che ci hanno permesso di scoprire che le piume erano abbastanza diffuse nei dinosauri – e in alcuni casi abbiamo delle impressioni che quanto meno ci permettono di avere un’idea dell’aspetto complessivo dell’animale, ed evitare rappresentazioni caricaturali.
A livello molecolare la situazione è persino peggiore: anche se, attraverso l’utilizzo di sequenze di DNA antico (o aDNA), è stato possibile ricostruire i rapporti di parentela di diversi mammiferi estinti con le specie attuali, è virtualmente impossibile ottenere DNA leggibile più vecchio di poche centinaia di migliaia di anni, il che lascia fuori la massima parte delle specie estinte, dinosauri compresi.
Eppure negli ultimi dieci anni è iniziata a fiorire una disciplina
che a prima vista sembrerebbe avere la stessa credibilità
dell’urbanistica unna o dell’ippica azteca teorizzate da Belbo e
colleghi nel Pendolo di Foucault: la paleontologia molecolare.
Per come tutti abbiamo studiato i processi di fossilizzazione,
con buona pace di Michael Crichton, sappiamo che l’organismo
originale, quando andiamo a recuperare e studiare il fossile, non è
più lì: anche le sue strutture calcificate (ossa, denti, gusci)
sono state gradualmente sostituite da sedimento, e il fossile in sé
non è altro che un calco, peraltro parziale, di ciò che era
l’organismo. Ci verrebbe da pensare che se andiamo a studiare un
fossile, la sua struttura molecolare non può differire troppo da
quella della roccia che lo ingloba, e l’idea di utilizzare tecniche
molecolari a supporto della descrizione morfologica sembra risibile.
Eppure non è del tutto così. Per quanto, sì, il grosso del
fossile a livello molecolare non si distingua dalla roccia che lo
contiene, con un certo stupore abbiamo scoperto che in effetti alcune
molecole organiche sono in grado di conservarsi per un tempo
sorprendentemente lungo.
Un caso paradigmatico è quello dell’enigmatica Dickinsonia.
Dickinsonia appartiene alla fauna di Ediacara, vissuta circa
700 milioni di anni fa – circa cento milioni prima che
comparissero, almeno nella documentazione fossile, degli organismi
sicuramente riconducibili ai phyla animali odierni. Nel mezzo,
niente. Gli studiosi si sono chiesti per letterali decenni quale
fosse la parentela tra questi organismi simili a materassini
gonfiabili segmentati e gli animali come li conosciamo oggi, con
alcuni, legati ad una visione forse un po’ troppo ordinata della
vita sulla terra, che tendevano ad interpretarli come antenati di
spugne, coralli e meduse, ed altri, fan di un’evoluzione creativa e
caotica, che ipotizzavano si fosse trattato di un tentativo di
sviluppare una pluricellularità finito in un vicolo cieco,
indipendente da quello che ha condotto agli animali odierni.
Il
mistero di Dickinsonia è stato risolto solo di recente,
quando Bobrovskyi
e colleghi hanno caratterizzato le molecole organiche
associate ad un fossile di Dickinsonia. Ora, dopo 700 milioni
di anni non ci possiamo aspettare rimanga molto: proteine, acidi
nucleici, le catene di carbonio più grandi sono degradate in maniera
irreversibile. Pure, qualcosa era rimasto: delle molecole di un
colesteroide.
I colesteroidi, nonostante la complessiva
demonizzazione di cui sono oggetto, nascono come molecole di
fondamentale importanza: si tratta di lipidi piuttosto piccoli, che
si intercalano ai più lunghi lipidi di membrana nella membrana
cellulare, evitando che si avvicinino troppo e che a basse
temperature finiscano per “congelarsi”, rendendo impossibile il
funzionamento della membrana, e quindi la vita della cellula. E i
colesteroidi hanno un’altra particolarità: esistono solo negli
animali – in altri gruppi di organismi la stessa funzione è svolta
da altre molecole. Per questo, la presenza di un residuo di
colesteroidi associato a fossili di Dickinsonia prova in
maniera definitiva che questi organismi, per strani che siano, si
collocano nella linea evolutiva che ha condotto agli animali odierni.
Come accennato, altre molecole reggono molto meno bene al passare del
tempo, e vengono degradate in tempi piuttosto brevi. Per questo, ha
destato un certo scalpore – e un certo scetticismo – uno studio
recentemente pubblicato da Bailleul
e colleghi, che hanno esaminato delle sezioni istologiche
del cranio di giovani Hypacrosaurus (un comune dinosauro a
becco d’anatra) utilizzando tecniche volte ad evidenziare la
presenza di alcune molecole organiche relativamente resistenti
associate a tessuto osseo e cartilagine.
Il fatto che in
definitiva un osso fossile non sia completamente rimpiazzato
da materiale inorganico non ci sorprende più particolarmente, e
quindi il fatto che la cartilagine del cranio di Hypacrosaurus
reagisca a coloranti specifici per la cartilagine, anche se in
maniera più tenue che quella di un emù odierno, non ci stupisce più
di tanto, e corrisponde a quanto rilevato in altri fossili. Una
simile reazione si è ottenuta per quanto riguarda sonde che
evidenziano la presenza di collagene, una comune proteina strutturale
particolarmente importante nella cartilagine; il collagene è
decisamente resistente, e non ci sorprende troppo trovarlo in fossili
del tardo Cretaceo – anche se in effetti si tratta di un tempo più
che rimarchevole. Ma nei loro esperimenti, Bailleul e colleghi si
sono resi conto di qualcosa di ancora più curioso, e decisamente più
inaspettato: delle cellule – per la precisione, dei condrociti, le
cellule che vanno a formare la cartilagine.
I condrociti di
Hypacrosaurus non sono particolarmente differenti da quelli di
un emù, né da quelli di qualsiasi altro vertebrato – e non si
vede perché dovrebbero. Non è questa la loro particolarità. La
particolarità è che, al loro interno, delle sonde specifiche hanno
messo in evidenza la presenza di materiale genetico condensato. Sì,
esattamente, lo ridico perché nemmeno io ci sto credendo – e con
me moltissima gente: le cellule fossilizzate di un dinosauro vissuto
settanta milioni di anni fa contengono dei residui di DNA. La cosa
sembra assurda, ma gli autori, in maniera piuttosto convincente,
sottolineano che un’eventuale contaminazione microbica è da
escludere, dato che avrebbe condotto ad un segnale diffuso, e non ad
ammassi di DNA concentrati all’interno delle cellule, nella
posizione in cui doveva essere presente il nucleo.
Ora, prima di pensare a scenari in stile Jurassic Park,
facciamo un respiro profondo e consideriamo cosa Bailleul e colleghi
hanno realmente osservato: una flebile fluorescenza
proveniente da materiale che contiene delle sequenze di DNA lunghe
almeno sei paia di basi. Sei paia di basi sono pochissimo: qualsiasi
ricostruzione filogenetica basata su aDNA non può utilizzare
sequenze più brevi di 30-40 paia di basi, che già sono pochissimo
informative, e possono condurre ad errori grossolani a seconda di
come valutiamo – o sopravvalutiamo – le differenze fra di loro.
Cercare di dire qualcosa sulla genetica di un organismo partendo da
una sequenza di sei paia di basi equivale a cercare di ricostruire la
trama dei fratelli Karamazov partendo dall’articolo “i”. Non
sappiamo realmente quanto siano lunghe le sequenze di DNA trovate da
Bailleul e collaboratori, ma considerato il tasso di degradazione
estremamente rapido che hanno gli acidi nucleici, non possiamo farci
troppe illusioni al riguardo.
Sappiamo, per contro, che il DNA
nei fossili di Hypacrosaurus è sopravvissuto in condizioni
particolarmente buone perché era dentro i condrociti (che a loro
volta sono immersi in una matrice estremamente compatta, entro la
quale acqua e microrganismi fanno molta fatica a penetrare) e
verosimilmente perché, per un fortunato caso legato alle condizioni
in cui questi dinosauri si sono fossilizzati, si è complessato con
proteine che ne hanno aumentato la stabilità. Il DNA quindi è
presente, ma è molto corto, presumibilmente troppo per essere
leggibile, e verosimilmente anche irraggiungibile, essendo inserito
saldamente in una matrice molto compatta – e a questo punto quasi
completamente mineralizzata – in associazione con residui proteici.
Le fortunate cause che hanno permesso a questo materiale genetico di
arrivare fino a noi sono anche quelle che ci impediranno di leggerlo.
Dunque la storia del DNA nelle cellule di Hypacrosaurus finisce
qua? Beh, no. Il DNA è illeggibile, ma dove è presente del DNA,
anche malridotto, anche in condizioni penose, ma identificabile come
tale, verosimilmente ci saranno delle proteine, che sono molto più
resistenti alla degradazione. Certamente, anch’esse saranno
rovinate, ma meno del DNA, e noi abbiamo la possibilità di leggere
anche loro. In particolare, sappiamo che il collagene è presente, e
questa proteina è già stata utilizzata con un certo successo per
studi filogenetici dove
l’aDNA non era più recuperabile.
Ora, non
possiamo farci troppe speranze sulla leggibilità del collagene – o
di altre proteine – nei fossili di dinosauro: verosimilmente, il
materiale che ancora conserva proteine abbastanza ben conservate da
contenere un minimo di informazione filogenetica è molto scarso. Ma
la presenza di DNA identificabile come tale può suggerirci quale
materiale sia più promettente, e il progredire delle tecniche
molecolari potrebbe a breve rendere possibile lo sviluppo di studi
filogenetici su materiale fossile.
Con buona pace di John
Hammond e del suo creatore, non riusciremo mai a clonare un dinosauro
– ma forse riusciremo ad avere un’idea più chiara, e suffragata
da più tipi di evidenza, delle sue relazioni di parentela con altri
organismi.
Immagine di Debivort (dettaglio) da Wikimedia Commons

Joachim Langeneck, assegnista di ricerca in biologia presso l’Università di Pisa, nasce a Torino il 29/11/1989. La sua ricerca si concentra principalmente sullo studio di processi evolutivi negli invertebrati marini, con sporadiche incursioni nell’ambito dell’etica della scienza, in particolare a livello divulgativo.