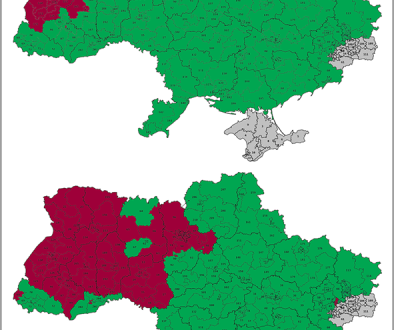Si
è detto che lo scambio
tra tattica e strategia è
forse la proposta centrale di Assembly, o
comunque la più interessante, ma che apre ad una serie di
cortocircuiti fondamentali.
Una prima criticità riguarda la
stessa distinzione, di matrice leninista, tra “tattica” e
“strategia”, utile solo se usata pragmaticamente
riconoscendone la natura tutto sommato arbitraria. Va da se che,
infatti, da un lato la tattica di breve periodo riflette l’indirizzo
politico strategico, un’idea
che portata all’estremo la riduce a poco più che una questione di
declinazione di contesto della strategia, in cui sono già date le
soluzioni possibili, e al settarismo nel suo significato più puro, e
che d’altro canto la
strategia
è pure ineluttabilmente determinata
dall’insieme delle scelte tattiche del passato.
Il triste stato della attuale sinistra partitica italiana è un
esempio abbastanza lampante dell’incancrenirsi non affrontato di
quest’ultimo problema.
Una
seconda criticità della proposta negriana è rivelata
paradossalmente proprio dal lodevole modo in cui Hardt e Negri, lungo
tutto Assembly, affrontano
il problema della sovranità,
nelle sue diverse declinazioni. Schmitt, la cui definizione di
sovranità è spesso condensata nella massima «sovrano è chi
decide dello stato di eccezione», è citato più volte dal duo
autoriale, che però non sembra coglierne le implicazioni per la
dicotomia tattica/strategia e per la sua proposta di spostare la
tattica sulla leadership. Se il “tattico” è in un certo
senso un’eccezione, chi
decide cosa rientri nel tattico e come affrontare le questioni
emergenti si troverebbe ipso facto
in quella posizione di sovranità
che non si vorrebbe riconoscergli. In definitiva, il mero spostare
competenze quindi, se può avere un valore positivo a livello di
cultura politica e di connessione con la realtà, non riduce il
rischio che il peso ed i compiti della leadership si gonfino con il
passare del tempo, e che si formino rapporti
di autorità antidemocratici
tra questa e la base. Negri non sfugge dalla classica
sottovalutazione fondamentale della complessità dei rapporti umani,
che vengono pensati – nonostante tutto – subalterni e
determinabili da soluzioni organizzative più o meno ingegnose, che,
come attraversa l’intera storia della sinistra dal liberalismo
settecentesco al socialismo utopico ai marxismi, attraversa anche
Assembly, con una
linea di frattura che mette in pericolo l’intera costruzione.
D’altronde, nonostante offra spunti notevoli, che gli avrebbero
forse consentito di andare oltre, il duo autoriale, in questo che è
un testo prettamente sull’organizzazione, rimane prigioniero di una
“teoria del partito”
che, senza partito, rimane paradossalmente da cima a fondo legata
alla storia del leninismo novecentesco.
Hardt
e Negri in sostanza aggiornano e rendono nuovamente presentabile la
solita metafisica dell’organizzazione
come soggetto di una fondamentale rottura con lo stato di cose
presente che costituisce
il vero dogma di tutte le sinistre radicali dell’età contemporanea.
L’addolcimento di alcuni aspetti “avanguardistici” e l’entusiasmo
per qualunque cosa sia grassroots non
nascondono questa sotterranea tentazione organizzativistica, che si
rivela fino nella fraseologia scelta dagli autori. Hardt e Negri
hanno ragione a rifiutare il paradigma della cosiddetta “autonomia
del politico”, e a criticarne gli ierofanti, a favore di una
riflessione (e un’azione politica) invece radicata saldamente nei
limiti e nelle contraddizioni
dell’”economico” e delle condizioni materiali.
Purtroppo il posto della composizione sociale e delle
condizioni materiali è enfatizzato, ma subito si torna ad una
filosofia della storia impregnata di ottimismo volontaristico di
stampo illuminista: la transizione ad un certo punto (vicino) lascia
spazio al consumarsi dei tempi ed al sedimentarsi delle cose, in
questo caso nel magma di una sorta di rivoluzione
permanente postmoderna,
l’organizzazione è il sostituto funzionale e il metro di paragone
della consapevolezza, il soggetto che sussume la massa fa la storia.
Una ricetta già sentita, di per sé legittima, ma di cui andrebbero
perlomeno tematizzate le debolezze.
Debolezze che, agli estremi
opposti, rischiano di condurre (e hanno condotto) da un lato
all’attendismo e alla mera
gestione del presente
e d’altro canto all’entusiasmo
cieco per qualunque cosa mobiliti “contro”;
sempre svalutando proprio quella materialità che si voleva posta
alla base di qualunque ragionamento. Con il rischio – data
quest’ultima prospettiva, poco evitabile e poco evitato – di finire
ad applaudire pure sanfedisti, torce e forconi.
Le
tematizzazioni storiche che muovono il ragionamento degli autori se
possibile evidenziano ulteriormente la matrice da cui muovono le
proposte pratiche. Sintetizzando, per il Negri di Assembly
lo squallore del presente
sarebbe addebitabile in pieno al riformismo,
tanto nella sua variante socialdemocratica di “riformismo
riformista” quanto nella sua del tutto presunta variante sovietica
di riformismo rivoluzionario, interessante ossimoro che rivela ancora
una volta il nucleo dell’intero ragionamento: il feticcio di un
leninismo più leninista
di Lenin,
che si ha come il sospetto che finisca per occupare quello che
dovrebbe essere lo spazio della politica.
D’altronde anche il
disprezzo e l’incomprensione per la cultura politica della sinistra
socialdemocratica è una vera e propria tradizione della sinistra
radicale o comunista novecentesca, che se in passato ha portato a
tragedie e lutti inutili ed evitabili oggi spiega in buona parte la
sensazione diffusa che la
sinistra esista non si sa bene a quale scopo,
persegua con zelo puritano una fumosa politica della divisione in
quattro del capello e sia paralizzata dalla propria incapacità di
scendere a compromessi; oppure, al contrario, tanti facili entusiasmi
e altrettanto facili disillusioni.
Una
nota, solamente di passaggio per evitare di essere ingenerosi, sulla
storia.
Assembly,
nel dare le coordinate storiche e storico-filosofiche della
contemporaneità non può non rifarsi alla categoria di
“neoliberalismo”,
che d’altronde ormai vive – nella cultura critica occidentale –
di vita propria. In questo si rifà alla Brief
History di
Harvey e, più indietro nella catena filologica, alla Nascita
della biopolitica di
Foucault, come d’altra parte fanno migliaia di altre pubblicazioni di
impianto critico o radicale di varia qualità, da Crouch in giù. Due
testi, quello harveyano e quello foucaultiano, ovviamente validi e
utili, ma che non possono non dare un’immagine solo parziale
dell’oggetto di cui trattano, e che spesso finiscono per sostituire
in toto una lettura diretta, attenta e contestualizzante degli autori
e dei materiali che si vorrebbero criticare.
Ciò causa
fatalmente anche in Assembly
una serie di cortocircuiti, dalla banalità di ripetere più volte
una grafia sbagliata del nome di Walter Eucken o della Mont Pelerin
Society,
alle molte parentesi bizzarre e storicamente un po’ goffe che
commentano di tutto un poco – dall’Impero asburgico a Lutero, alla
più seria questione di una ricostruzione storica deformante che
enfatizza troppo discontinuità e fattori estrinseci, e forse azzoppa
il ragionamento complessivo.
A
differenza di ciò che la selva sterminata di testi che abbiamo
evocato va ripetendo con più o meno convinzione, il mainstream
politico-economico postbellico non era infatti nello spirito
“keynesiano” quanto crede qualche nostalgico – e questo d’altra
parte era già stato sottolineato da economisti come Minsky o
Robinson – e anzi, con il suo bellicismo insensato e la sua folle
corsa ai consumi privati, ha rappresentato forse il più grande
ostacolo alla transizione verso il mondo di abbondanza e pace che
Keynes aveva immaginato. E d’altronde non è morto solamente per
l’impatto del thatcherismo o della reaganomics,
come distrutto in una sorta di radicale rivoluzione al contrario,
così come d’altronde le politiche economiche precedenti non sono
state affatto del tutto soppiantate dalle idee austriache o
friburghesi, la cui ortodossia è rimasta riserva marginale di pochi
dottrinari.
Non è questione di negare la discontinuità dei
tardi ’70 e degli ’80, che pure c’è stata, quanto di osservarle più
dal lato storico-politico che dal lato storico-intellettuale, come
storia di una sintesi
contraddittoria e deformante
– lontana da Keynes ma lontana pure da Eucken (magari scritto
correttamente) o Hayek – tra
dispositivi di governo e ricette economiche vecchie e nuove
piuttosto che di una rottura radicale a favore delle seconde; come
reazione di classe spinta da precise condizioni materiali economiche
e politiche, processi storici che dimostrano da sempre di avere poco
rispetto per la purezza degli ideali, piuttosto che da crudele furore
ideologico. Le eterogenesi dei fini e le deformazioni dell’esistente
non sono d’altra parte più semplici (e popolari) delle rotture
radicali?
E d’altra parte non è stata la perfidia menscevica cui Negri sembra ricondurre un po’ tutti i mali a spianare la strada al brave new world che conosciamo, quanto l’incapacità della sinistra europea dell’ultimo trentennio di Ventesimo secolo di concepire un superamento in avanti di un consensus ormai anacronistico e di una situazione di trinceramento paralizzante simile a quella di inizio secolo che aveva ben descritto Polanyi: il Winter of discontent britannico ha lasciato spazio alla reazione thatcheriana non per un’immaginaria malvagità dei dirigenti socialisti o per la presunta impossibilità del riformismo, quanto per prosaica mancanza di idee, di immaginazione, di capacità politica e del coraggio necessario a fare – in un momento decisivo – un passo ulteriore nella transizione verso un modello produttivo differente. Anche a costo di sganciarsi dagli storici riferimenti sociali; disancoramento che poi è ovviamente avvenuto lo stesso, ma in termini inutilmente distruttivi. Certo, e va detto, la storia successiva di quella sinistra in tutto il mondo industrializzato parla di un essere risucchiati che è caratteristica delle cose leggere e vuote.
Torniamo, in conclusione, ad Assembly ed al posto della filosofia nell’opera di Hardt e Negri, in quella che abbiamo chiamato la storia di un allontanamento da Marx. Si è detto, il punto di partenza naturale di Negri è il marxismo filosofico che in Occidente si è contrapposto in vari modi al dogmatismo del marxismo economico-scientifico sovietico. Il marxismo a cui può essere, con qualche cautela, applicata l’etichetta riduttiva di “Occidentale”. Correnti di pensiero radicale esplicitamente non “Western” forniscono utili spunti, dimostrando ancora una volta la vitalità del filone postcoloniale. Purtroppo, invece, l’interrogativo sulla possibilità di un pensiero filosofico-politico ed economico in grado di rivitalizzare la fonte del marxismo occidentale, dopo la crisi del sistema sovietico, va lasciato aperto, nonostante vada riconosciuto che l’avventura intellettuale dei nostri due autori sia stato un tentativo coraggioso di farvi fronte, anche approdando ad altri lidi.
Ciò
che di Assembly
convince
meno è in definitiva proprio la scarsa
volontà di convincere
che traspare ad ogni pagina del libro, dalla scarsità di
argomentazioni e addirittura dalla forma apodittica da manifesto
politico (che pure è il paradigma del testo persuasivo), rendendo
quest’ultima opera un testo in fin dei conti più adatto a chi ha
seguito il filo del ragionamento di Michael Hardt e Antonio Negri da
di Impero in
poi, o a chi è già convinto.
Una sorta – come la abbiamo
già definita – di opera definitiva, fatta per mettere un punto o
tirare le fila di un discorso tra pochi intimi. Se per approfondire,
o per andare definitivamente oltre, non è dato sapere.
In
luogo di una conclusione. Hardt e Negri citano in uno dei primi
capitoli la nefasta decisione Citizens
United v. FEC della
Corte Suprema degli Stati Uniti, che nel 2010 ha a tutti gli effetti
cancellato ogni limite alle donazioni private destinate alla
comunicazione politica e alle campagne elettorali. In ogni elezione,
da Cittadini
Uniti
in poi, la sinistra dovrà competere non solo contro la più o meno
equivalente militanza avversaria, non solo contro quanto
dell’impressionante potere di ricchezze esorbitanti – che si
traduce in decine di think
tank
di destra, in campagne martellanti per programmi e candidati
estremisti, in informazione faziosa – già inquinava la politica
statunitense, ma contro l’intera potenza di queste ultime, mobilitate
contro qualsivoglia impediamento ad un ulteriore accumulazione.
A
parere di chi scrive, esempi come questi ci mostrano quanto sia
importante, in condizioni difficili come le attuali, lavorare
per conservare un minimo di agibilità politica,
se necessario sacrificando o mettendo tra parentesi purezze
ideologiche e storie ormai polverose – e le formule organizzative e
identitarie che quelle storie hanno sedimentato.
Non si tratta
di convertirsi a qualsivoglia riformismo o di cospargersi il capo di
cenere, ma di salvaguardare uno spazio politico, ponendo nel contempo
le basi per un nuovo accumulo di forze sociali. Conservare la fiamma
della filosofia
politica
è a questo scopo fondamentale, ma è davvero utile solo a patto che
la ragione sappia anche tornare con i piedi per terra e riconoscere i
limiti che le si contrappongono.
Michael Hardt e Antonio Negri, Assemby, Oxford University Press, Oxford 2017
Immagine Internet Archive Book Images da flickr.com

Nato a Bozen/Bolzano, vivo fuori Provincia Autonoma da un decennio, ultimamente a Torino. Laureato in Storia all’Università di Pisa, attualmente studio Antropologia Culturale ed Etnologia all’Università degli Studi di Torino. Mi interesso di epistemologia delle scienze sociali, filosofia politica e del diritto, antropologia culturale e storia contemporanea. Nel tempo libero coltivo la mia passione per l’animazione, i fumetti ed il vino.