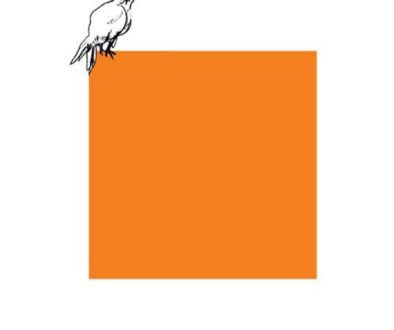Pubblicato per la prima volta il 19 febbraio 2015
“La pienezza dell’amore del prossimo è semplicemente l’essere capaci di domandargli: “Qual è il tuo tormento?”
(Simone Weil)
È il teologo e filosofo gesuita Armido Rizzi a concludere il ciclo “Eros, philia, agape” organizzato dalla fondazione Niels Stensen di Firenze.
Lo studioso di teologia esordisce prendendo spunto dall’occasione offerta dalla data del 14 febbraio, il giorno degli innamorati. Non tutti sanno infatti che San Valentino, morto appunto il 14 febbraio del 1273, diventò il protettore degli innamorati perché celebrò l’unione di un pagano e una cristiana. Unione che dunque va al di là della dimensione dell’innamoramento, dato che è segno di un congiungimento che lega, in tempi ancora non troppo maturi, due anime così diverse, come a dire che l’amore può superare e dovrebbe superare qualsiasi barriera, sia essa religiosa, etnica o sessuale.
Terminata la breve parentesi su San Valentino, Rizzi dichiara che il suo intervento andrà a soffermarsi principalmente sulla Parabola del buon Samaritano, che compare nel vangelo di Luca (10, 25, 37) e che affronta il dialogo tra Gesù e un dottore della legge. Quest’ultimo chiede a Gesù che cosa debba fare per meritare la vita eterna e il Nazareno gli risponde domandando a sua volta che cosa ci sia scritto nella Legge. A questo punto il dottore, ben preparato, afferma quanto effettivamente scritto nella Legge: “Amerai il signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente e tutta la forza e amerai il prossimo tuo come te stesso”. E Gesù: “Hai risposto bene, fai questo e vivrai”. Ma, chiede ancora il dottore: “chi è il mio prossimo?”.
Così il Nazareno racconta la parabola del buon samaritano: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».
Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
Rizzi fa innanzitutto una non scontata e assolutamente non banale osservazione filosofica sul termine anthropos che compare nel testo greco e che viene tradizionalmente tradotto con uomo. Ebbene è un errore tradurlo in tal modo, dato che in greco anthropos significa persona umana, in generale, sia essa uomo o donna. Se si avesse voluto specificare che il mezzo morto fosse stato un uomo il testo greco avrebbe adoperato il termine aner che indica il maschio senza rigor di dubbio. La scelta di usare anthropos fa cadere l’accento sul fatto che l’individuo in cui incappa il Samaritano fosse una persona umana e quindi avrebbe potuto essere sì un uomo, ma anche una donna; o che in ogni caso non fosse tanto importante la sua identità sessuale quanto piuttosto che si trattasse di un essere umano, di un prossimo.
Un’altra interessante osservazione riguarda proprio la domanda del dottore della legge, che chiede chi sia il prossimo. Il prossimo sono i familiari, parenti, persone del tuo stesso sangue. Ma allora i non prossimi? Ecco, per Rizzi è importante capire che il prossimo non è soltanto colui che ti è vicino perché vincolato con te da un rapporto di amicizia o di DNA, ma è anche il non-prossimo e anzi, forse lo è ancor di più. Questa parabola esprime proprio l’amore per il prossimo non-prossimo, la persona in cui inciampiamo, in cui incappiamo, la persona sconosciuta, straniera, non legata a noi da alcun tipo di particolare affetto o sentimento cui dobbiamo andare incontro, accoglierla, divenire prossimi ad essa. Dobbiamo diventare il suo prossimo.
Sintomatico che sia i sacerdoti che il levita (quindi un esperto del culto, un uomo della Legge, per così dire) passino oltre il moribondo, come a dire che non basta essere portatori del culto e conoscitori della Legge se poi nelle azioni si fa l’esatto contrario rispetto a quel che dice anche il messaggio di Dio, oltre ad essere un dovere morale e civile aiutare l’altro, chiunque egli sia. Solo il buon samaritano ne ha compassione, che in greco ha una portata quasi fisica in questo verso, dato che il verbo usato è splanchnizou che significa letteralmente “avere viscere (splanchna) di compassione”. Quindi non è presa in considerazione solo la dimensione emotiva, ma viscerale, corporea del moto di compassione che anima l’azione del samaritano.
Inoltre il provar compassione, prosegue Rizzi, non riguarda soltanto la sfera umana, ma persino divina. È un sentimento che appartiene all’uomo, ma anche a Dio, tanto che il verbo “avere viscere di compassione”, nelle sue diverse declinazioni, viene usato in altri tre casi riferendosi proprio all’ente divino:
nel Benedictus di Luca;
Sempre nel Vangelo di Luca, 27, 11, 17, quando Gesù vedendo la vedova di Nain che va al funerale del figlio e si mette a piangere, splanchnisteis, viene mosso a viscerale compassione, che si fa addirittura attiva dato che il messia le resuscita il figlio;
Nella parabola del figliol prodigo – capitolo 15 del Vangelo di Luca – quando, dopo che il figlio che, partito per vivere da solo e arricchirsi e avendo sperperato tutta la fortuna, pentito (e impoveritosi) torna dal padre, questi gli va incontro e lo abbraccia “con viscere di compassione”. In questo ultimo esempio è chiaro che quel padre è metafora vivente e incarnata del Dio padre.
Questi tre esempi dimostrano, secondo Rizzi, che la compassione è uno slancio d’amore che comprende tanto la sfera umana quanto quella strettamente teologica/religiosa, in quanto investe anche Dio (o comunque Gesù, che per i credenti è Dio che si è fatto uomo), non immune da sentimenti considerati prettamente umani. Compassione che, nel secondo caso, porta al dono della vita (la resurrezione del figlio della vedova) e nel terzo al perdono del figlio degenere.
Tornando al comandamento “più grande (o dell’amore)” – Amerai il signore Dio tuo con tutto il cuore, la tua anima, la tua mente e la tua forza – il teologo tiene a sottolineare come in origine non sia stato scritto dagli evangelisti, bensì fu ripreso dal Deuteronomio – il testo più grande del Vecchio Testamento – in cui la formula, nel capitolo 6, al verso 5, si “limitava” a dire “Amerai il signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.” Nel Levitico invece compariva l’altra parte del comandamento “dell’amore”: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. E, precisa Rizzi, 15 versetti dopo, tale comandamento è completato dalla specificazione riguardo a chi sia il prossimo che comprende anche lo straniero.
Il comandamento più grande non è una sorta di pronostico per innamorarsi di Dio, ma un vero e proprio imperativo, che nella versione greca (sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento) è espresso sempre col termine agape. È un imperativo categorico umano, dichiara il teologo.
Ma, continua, che cos’è l’amore, e che cos’è il cuore di cui si sta parlando qui? Al v. 6 dello stesso capitolo, nel Deuteronomio, si legge: “Questi precetti che oggi ti do ti siano scritti nel cuore”.
Il cuore biblico non è ciò che intendiamo prevalentemente oggi ma è inteso come parola di Dio. Nel Vecchio Testamento il termine cuore compare all’incirca 850 volte e nella stragrande maggioranza dei casi (circa 750) ha valenza di sede dell’obbedienza alla volontà di Dio, che si è espressa in tutti i comandamenti, i quali trovano tutti la loro piena condensazione in quell’unico vero comandamento, declinato positivamente, dell’amare Dio, che soggiace a tutti gli altri e che tutti comprende e implica.
Amare Dio significa obbedire attivamente alla sua volontà, spiega Rizzi, non significa pertanto e semplicemente astenersi dal commettere il male, bensì fare attivamente del bene, perché si fa del male anche quando ci asteniamo dal fare quel bene che dovremmo fare, anche il Levita e i sacerdoti che passano oltre il moribondo commettono del male, perché non fanno del bene. Dunque quando si tratta del cuore inteso nell’accezione biblica, esso sta a indicare la sede dove cala il comando di Dio. Si tratta quindi di un amore dovuto, che ha cioè, un senso e una portata di necessità. Amare il prossimo – che abbiamo specificato essere anche il non-prossimo, l’altro in generale – vuol dire agire in un certo modo, fare necessariamente così, andare verso l’altro a aiutarlo in quelle che sono le sue necessità, i suoi bisogni.
E questo è un dovere che non riguarda soltanto i cristiani o i credenti in generale ma ciascuno di noi, sia su piccola che su vasta scala, soprattutto nei tempi in cui viviamo, in cui all’altare di un nuovo Dio, il denaro, vengono sacrificate le necessità vitali di tanti esseri umani e non umani. In tempi in cui l’altro diventa mezzo/strumento e non fine, in cui lo straniero è infinitamente lontano dall’essere considerato prossimo se non addirittura neanche umano, privato di ogni valore, spogliato persino della sua identità, di ogni suo diritto, della sua umanità. Amare il prossimo significa amarlo attivamente, non chiudendogli le porte in faccia o girandosi da un’altra parte quando reclama il nostro aiuto.
E questa non è carità intesa nel senso comune del termine, ma dovere, basilare norma del vivere civile, rispetto (che è ben diverso dalla tolleranza o dall’elemosina) della sua umanità e del suo diritto alla vita e alla libertà.
Rizzi arriva a delineare poi la distinzione tra due cuori e due amori: il primo è l’eros, con cui il teologo intende gli amori comuni, intesi in senso ampio e che si trovano soprattutto nella filosofia greca. Basti pensare al Simposio di Platone in cui dal livello più “basso” dell’amore per il singolo corpo della persona amata, si arriva all’amore per la sua anima e infine, quand’anche quest’ultima si rivela insufficiente, ci si eleva fino all’amore celeste, quando si è tratti, calamitati dal divino e si arriva ad amare non il singolo ma l’universale. Questo è l’amore erotico in cui però, prosegue Rizzi, l’amore, l’amato, anche quando è al suo gradino più alto, rimane comunque puramente oggetto. Anche in Aristotele, che riprende il tema platonico, Dio, che è pensiero di pensiero, rimane comunque oggetto d’amore, infatti “panta kinei ta panta os erotheros”, ovvero muove tutte le cose perché le trae a sé in quanto oggetto d’amore, tutto tende a lui in quanto oggetto d’amore. Anche i versi biblici e le preghiere nel tratteggiare Dio con connotazioni del tipo: “Creatore del cielo e della terra”, “Generato e non creato”; “della stessa sostanza del padre” ecc. riprendono in qualche modo, seppur con le dovute differenze, la filosofia greca.
Quindi, ricapitolando, quest’ultima parla di eros principalmente nei termini di attrazione verso un fine ultimo, non solo e non tanto nei termini dell’innamoramento, che, semmai, è solo la molla iniziale (vedi Platone) che fa scattare il percorso graduale verso l’alto, verso un amore più completo e divino. In Aristotele addirittura la dimensione erotica, nel senso del raggiungimento teleologico, cioè la realizzazione della propria essenza, l’essere o diventare ciò che si è, che è il fine cui tendiamo naturalmente, non comprende solo la sfera umana ma quella di tutti gli esseri, anche gli animali e persino le piante, perché anch’essi hanno quel fine immanente cui tendono naturalmente.
Il secondo tipo di amore preso successivamente in considerazione da Rizzi è ben diverso. Questo è l’agape che per il relatore è l’amare Dio con tutto il cuore, cuore che come abbiamo detto non è dimora dei soli affetti, ma custodia della parola di Dio, risposta al comandamento divino dell’amare il prossimo (che comprende il non-prossimo, ribadiamolo) come se stessi. Amare Dio non significa desiderarlo ma attuare concretamente la sua volontà, aprirgli il cuore e dirgli di sì, lasciare che la sua parola penetri in esso, sgorghi come flusso di acqua inesauribile che faccia germogliare, in quella terra fertile di un cuore colmo, traboccante di amore con la A maiuscola, dei fiori e dei frutti da spargere ogni attimo sul cammino che incrocia l’altro da sé. Su ogni passo che l’altro compie verso di me devo gettare il mio fiore, o anzi e meglio, il mio fiore deve accompagnare ogni passo che io devo compiere, in ogni istante verso l’altro e regalarglielo quel fiore, posare un petalo sul suo volto, nel suo cuore, nella sua anima, cospargere di petali la sua strada.
E questo cuore non deve appartenere solo all’uomo di fede, ma anche al laico, perché questo cuore è la coscienza etica, è principio etico, non strettamente o solamente religioso. In questo cuore si instaura l’agape che, sebbene sia prevalentemente usato nella sua accezione teologica, è l’amore comandato, un amore disinteressato ma che deve agire, deve amare, non può non farlo perché non sarebbe amore.
E agape ed eros sono sì irriducibili ma non incompatibili, si possono coniugare, conciliare, non escludersi a vicenda. L’agape può diventare il fondamento imprescindibile – per Rizzi – che sottostà all’eros. Si arriva ad amare il prossimo con lo stesso amore con cui si può amare il/la proprio/a partner. Innamorarsi degli altri, del prossimo, ma con un amore che non chiede e che vuole solo dare, che si sente di dover dare. E il prossimo, come scrisse il Cardinal Martini – caro amico di Rizzi – in una delle sua pastorali – Farsi prossimo, per l’appunto – “divento io stesso nell’atto in cui davanti a un uomo, anche a un forestiero o al nemico, decido di fare un passo che mi avvicina, che mi approssima a lui.” Il termine greco è ghegonai, che significa diventare: io divento prossimo a te e tu a me, ci avviciniamo spinti dalla forza di agape e diventiamo ognuno il prossimo dell’altro.
Concludendo, Rizzi sottolinea nuovamente come quindi la parabola del buon samaritano insegni che cos’è l’amore, che non è semplice affetto o passione ma apertura a quell’agape che entra in noi per farci diventare prossimi a chi è in necessità. È la chiamata muta dell’altro a cui dobbiamo rispondere, così che il mio dovere trasformi il bisogno dell’altro in suo diritto. I suoi bisogni diventano diritti. Il teologo ci saluta con un’ultima profonda e preziosa citazione che, tolto l’afflato religioso del caso, nasconde un messaggio che dovrebbe valere per ciascuno di noi, credente o laico che sia:
“L’uomo cerca Dio volgendo lo sguardo verso il cielo per soddisfare il suo desiderio di oltrepassare i propri limiti. Ma Dio gli dice di rivolgere lo sguardo verso i suoi fratelli, perché solo lì potrà trovarlo.”
Immagine: E. M. Boglino, Il buon samaritano, 1928 (dettaglio) da Wikimedia Commons

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.