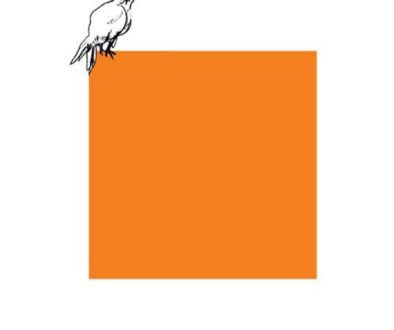Nell’ultimo periodo è raro trovare un giorno in cui i giornali e i telegiornali non ci parlino di migranti, in particolare della rotta mediterranea.
Il dibattito sui salvataggi dei migranti in mare da parte delle navi di alcune organizzazioni umanitarie ha ormai polarizzato l’opinione pubblica, ed da mesi occupa le copertine dei giornali e dei telegiornali.
A lato delle polemiche attorno alla vicenda, veniamo “bombardati” ogni giorno di immagini drammatiche di naufragi e salvataggi; immagini crude, che turbano e che mostrano una realtà con cui altrimenti difficilmente ci troveremo a scontrarci.
L’ultimo caso è la foto del giornalista-fotografo Juan Medina che rappresenta il soccorso di Josepha, (avvenuto grazie alla nave Open Arms il 18 luglio 2018) unica sopravvissuta del suo gommone. Il giornalista si è già occupato in passato di fotografare i salvataggi/le tragedie in mare dei migranti, in particolare di quelli della rotta verso la Spagna e le Canarie, riuscendo ad unire arte e denuncia sociale.
E le immagini dei naufragi del mediterraneo sono solo le ultime di una lunga serie di grandi tragedie, più o meno politiche, che ci accompagnano da quando è nata la fotografia: dagli orrori dell’olocausto alla guerra in Siria, dalle fucilazioni della comune di Parigi ai profughi palestinesi, i mezzi di comunicazione visuali hanno reso visibile la violenza e la sofferenza a milioni di persone in tutto il mondo. E questa consapevolezza ha portato negli anni numerosi fotografi, registi e giornalisti a interrogarsi sull’eticità della violenza delle immagini.
Nonostante la questione sia ormai discussa da decenni, il dibattito attuale deve tenere conto anche di nuovi elementi, in quanto con l’arrivo dei social network si è duplicata la diffusione di immagini tragiche, rendendo ancora più fruibile, immediata e diffusa la visione di contenuti crudi e violenti.
Se da una parte queste immagini ci rendono partecipi di una realtà distante ma tragica, dall’altra l’utilizzo di immagini estremamente forti può sconfinare nella cosiddetta pornografia del dolore.
Questo termine viene soprattutto utilizzato soprattutto nell’ambito del fundraising, e indica tutte quelle fotografie e video che utilizzano le sofferenze delle persone ritratte a scopi di raccolta fondi. L’esempio che solitamente viene portato avanti è quello delle campagne di Save The Children, che dal 2013 accompagna le sue campagne a video di bambini in fin di vita, rafforzando il cliché e gli stereotipi del bambino africano.
A proposito di immagini crude che vedono protagonisti bambini, già dal 1990 la carta di Treviso, promossa dal Telefono Azzurro e successivamente integrata nel “testo unico dei doveri del giornalista”, si è raccomandata di porre estrema attenzione all’utilizzo di immagini di bambini in difficoltà al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona. In questo caso si parlava di protezione dei minori. Ma esistono altre carte e altri codici di condotta elaborati negli anni dai professionisti per regolare il rischio di pornografia del dolore; ad esempio a livello internazionale la NPPA (national press photographers association) ha dichiarato nel suo codice etico che è necessario: “trattare tutti i soggetti con rispetto e dignità; dare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili e la compassione per le vittime di reati o di tragedia; inserirsi in momenti privati di dolore solo quando il pubblico necessita di quella testimonianza”1.
Chi sostiene la necessità di limitare al massimo le immagini troppo violente inoltre sottolinea come la sovraesposizione a immagini di violenza può portare l’individuo ad abituarsi ad esse: “La fotografia spesso riesce direttamente a ottenere proprio ciò che dovrebbe scongiurare: la normalizzazione dell’atrocità […] Il far vedere comincia a prendere il posto del far fare” (Zelizer in Linfield pag. 60). Quest’assuefazione ben si combina con la disumanizzazione dei profughi incoraggiata dagli imprenditori della paura e dalle manipolazioni politiche.
Ma la polemica principale è legata alla questione della dignità del soggetto ritratto. Chi viene fotografato/filmato durante un momento di dolore o di trauma spesso non comprende del tutto la portata e la diffusione che quelle immagini possono avere. Il mostrare immagini crude per denuncia sociale o per raccontare la sofferenza può trascendere la “dignità” umana della persona intervistata?
Se da una parte c’è il rischio di ledere la privacy e la dignità del soggetto o dei soggetti ritratti, dall’altra il racconto giornalistico/artistico fatto attraverso il video e la fotografia può divenire un atto politico importante e necessario, che permette di aiutare i singoli individui a costruirsi gli elementi per maturare uno spirito critico nei confronti degli orrori generati dall’uomo. Basti pensare all’influenza sull’opinione pubblica della foto di Nick Út “Napalm Girl” sulla guerra del Vietnam, o più recentemente del video che ritrae il piccolo Omran (dell’Aleppo Media Centre) dopo un bombardamento di Aleppo e della foto di Alyan Kurdi, un migrante di appena 3 anni morto su una spiaggia turca nel 2015.
In questo modo la macchina fotografica, la videocamera si presentano come strumenti di “globalizzazione delle coscienze”2, che costringono a prendere posizione su argomenti distanti nello spazio e nel tempo. Esse ci costringono a vedere le sofferenze altrui, e aiuta a empatizzare con gente che non conosciamo, e che non conosceremo mai. Questo poiché «Ogni immagine di barbarie – di miseria, umiliazione, terrore, sterminio – contiene il suo contrario, anche se spesso in modo inconsapevole. Ogni immagine di sofferenza non solo dice “È così” ma anche, implicitamente, “Così non deve essere”; non solo “questo accade” ma anche, implicitamente, “questo non deve più accadere”. La documentazione della sofferenza è un documento di protesta: ci mostra quello che accade quando distruggiamo il mondo.3» .
In questo senso i media diventano testimoni di diritti negati e costringono l’opinione pubblica a fare i conti con la propria coscienza; in alcuni casi questa presa di consapevolezza può portare la persone ad attivarsi per migliorare la situazione. In un certo senso quest’idea è stata confermata dalle tanto criticate campagne di Save the Children, che hanno “dimostrato” come la pornografia del dolore in fin dei conti “vende”, in quanto le immagini crude riescono a far smuovere un numero considerevole di persone, e a portarle a reagire (nel loro caso ad aumentare le donazioni).
Nel caso della foto del soccorso di Josepha, l’espressione della giovane ci sbatte in faccia la tragicità di quello che sta accadendo nel Mediterraneo, ed è sicuramente un’efficace risposta alla campagna d’odio portata avanti da una politica che punta più sui respingimenti e la paura che su un’effettiva risoluzione delle problematiche legate all’accoglienza e al contrasto al traffico di esseri umani. Il problema sta quindi nel capire se nella disperata ricerca di controbattere efficacemente alle politiche disumanizzanti dilaganti si rischia di cercare l’empatia a tutti i costi, ignorando il rapporto tra fotografo e persona fotografata e sconfinando nella pornografia del dolore. Noi sappiamo pochissimo su chi sia Josepha, cosa pensa, in cosa crede, come ha vissuto e cosa l’ha spinta a scappare dal Camerun. Conosciamo solo, o pensiamo di conoscere, un istante della sua vita, il suo sguardo spaventato, il suo volto traumatizzato. Non sappiamo se è cosciente di essere diventata un caso mediatico, un simbolo, una prova tangibile di quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Sappiamo solo che la sua sorte è stata il risultato di scelte non solo personali ma soprattutto politiche; sappiamo che molte persone non hanno avuto la sua stessa “fortuna”. E grazie a quest’immagine sappiamo dare un volto umano a quello che sta succedendo a Sud del nostro paese.
Non sempre però il “vedere” un’immagine di forte impatto si traduce in automatico in un’azione positiva: la fotografia, i video non mostrano realtà oggettive, ma immagini interpretabili. Nonostante una foto o un video dovrebbero essere rappresentazioni fedeli della realtà, queste sono sempre influenzate dall’interpretazione del fotografo/regista e dalle molteplici traduzioni degli osservatori. E l’ostruzionismo irrazionale di chi non vuole vedere come esseri umani dei soggetti che vedono come “alterità” impedisce lo scaturire di solidarietà.
Torniamo a Josepha: in una sua foto pubblicata a distanza di giorni dal salvataggio ha fatto scalpore la presenza delle unghie smaltate e di un paio di gioielli. In questo caso lo smalto e i braccialetti sono un esempio brillante di come qualunque immagine che si distanzi dallo “stereotipo” della vittima sofferente (come invece sono i bambini delle campagne di Save the Children) si scontra con l’immagine che abbiamo della persona vulnerabile. Josepha è solo l’ultimo di tantissimi esempi di immagini sviate: i famosi profughi con lo smartphone e il wifi, i migranti nei gommoni che sono “troppo ben messi” e tutti uomini giovani (troppi pochi bambini e troppe poche donne per avere pietà), o i rifugiati che osano farsi un bagno in piscina (e magari sorridono!) non corrispondendo all’immagine della “vittima”, e di conseguenza non sono degni della nostra compassione. Infatti, se la persona che vediamo in video o in foto non corrisponde alla nostra immagine mentale di sofferenza, l’efficacia emotiva di questi media s’incrina. In questo modo viene a meno la partecipazione empatica dell’osservatore, che non si identifica più con la persone/le persone raffigurate. È anche grazie a questo meccanismo che si arriva ad insinuare il sospetto su ogni minimo dettaglio della foto, e si decide chi è legittimato a essere degno di compassione e chi no, su chi è veramente vittima o meno.
Ogni elemento che testimoni la non-sofferenza del soggetto raffigurato diventa fondamentale in quanto consente di non sentirsi moralmente compromessi, di poter rifiutare di aiutare la persona raffigurata e essere comunque dalla parte del giusto.
Senza lo status di “vittima”, senza la possibilità di comprendere l’altro la persona ritratta perde il nostro interesse, è un soggetto senza caratteristiche che possono sollecitare in noi qualche emozione; d’altronde “un uomo che non è altro che un uomo sembra aver perso le qualità che spingevano gli altri a trattarlo come un proprio simile”4.
Pubblicato per la prima volta il 28 luglio 2018
Immagine da www.wallpaperflare.com
1 Punto 4 del codice etico: https://nppa.org/code-ethics
2 Susie Linfield – “La luce crudele”, Contrasto editore, 2013
3 Ivi pag. 47
4 Hanna Arendt “Le origini del totalitarismo” pag. 418

Nata a Treviso nel 1987, ha successivamente vissuto tra Bologna, Bucarest e Firenze. Femminista appassionata di musica, si interessa di politica, sociologia, antropologia e gender studies.