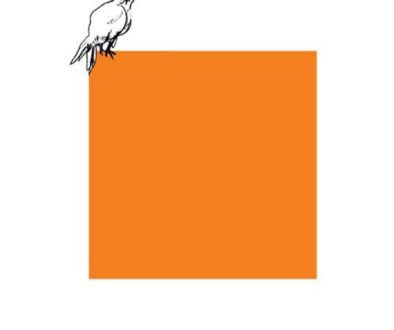La globalizzazione nasce dal mare. No, non si tratta di dipingere una botticelliana immagine di una rediviva Afrodite che emerge in tutta la sua eterea bellezza dalle schiume dell’acqua, ma dell’insolita tesi di Peter Sloterdijk, filosofo e saggista tedesco nato nel 1947.
Nel suo interessante Il mondo dentro il capitale, il filosofo e professore di filosofia ed estetica all’università di Kalshute ricostruisce il fenomeno della globalizzazione partendo dai primi viaggi che da Colombo ai vari Magellano, passando per i conquistadores e i missionari, hanno calcato le rotte marittime e oceaniche verso la scoperta (e la manipolazione-sottomissione) di nuove terre e nuovi popoli.
“La globalizzazione terrestre diviene una questione per cartografi e un’avventura per marinai […] Nella modernità non sono più i metafisici, bensì i geografi e i navigatori e disegnare la nuova immagine del mondo”, si legge nelle pagine del saggio. Sloterdijk sottolinea come a partire dall’epoca moderna non sia più il cielo, che per gli antichi era stato sinonimo di trascendenza, di volta ultima sotto cui proteggersi e rifugiarsi per evadere da una dimensione terrena irrimediabilmente finita e mortale, in cui il tempo scorre inesorabilmente e irreversibilmente, su cui si fa esercizio di “anticipazione della propria morte”, bensì la Terra a fungere da “volta ultima”, ad assumere il ruolo che prima apparteneva al cielo.
Prima pensare significava farlo a partire da quest’ultimo, era “un pensatore colui che trascende e osserva dall’alto”, a svantaggio di quel basso dove le uniche cose sperimentabili sono dissoluzione e finitudine. Dalla modernità in poi basso ed alto si capovolgono, il cielo si svuota e la terra si riempie. Non si guarda più in alto ma in basso, si compie il periplo della terra per sondarne e rilevarne in maniera sempre più tecnicamente e scientificamente adeguata lo spazio.
È sulla terra che si fa ritorno, il movimento non è più ascendente ma discendente, come scrive Von Humboldt, che nel suo Kosmos, monumentale opera pubblicata in cinque volumi, non sceglie la Terra come punto di partenza da cui osservare il resto dell’universo, bensì un qualsiasi punto dello spazio esterno da cui avvicinarsi pian piano alla Terra stessa, “come un visitatore che proviene da una stella sconosciuta”: “l’osservazione della natura deve essere generale, vasta, libera, non limitata […] Una descrizione fisica del mondo, un quadro del mondo non ha inizio con ciò che è tellurico, bensì con ciò che colma gli spazi celesti […] Dalle regioni nelle quali riconosciamo soltanto la supremazia delle leggi della gravitazione scendiamo, quindi, verso il nostro pianeta.”
Agli uomini, persa l’accessibilità a un firmamento che si è svuotato del suo significato metafisico, resta dunque la consapevolezza “della propria posizione in uno spazio nel quale essi debbono tornare a sé stessi da qualsiasi luogo lontano […]. Per l’uomo moderno sono andati perduti la trascendenza essenziale e il sogno di una patria nel sopramondo; viceversa, viene alla luce l’autoreferenza del soggetto pensante e abitante come condizione necessaria per il ritorno da ciò che è esterno a ciò che gli è proprio”.
Ma nello spazio rotondo della sfera terrestre tuttii punti appaiono omogenei e diviengono perciò necessari degli strumenti che possano fornire informazioni sulla propria localizzazione: da qui nasce quella che Sloterdijk chiama “meraviglia tipografica” che stabilisce il protocollo, tramite costanti aggiornamenti delle carte in seguito a scoperte, conquiste, toponomastiche, annessioni, con cui gli europei, nella loro avanzata per terra e mare si creano una posizione in quell’esterno che diventa luogo di progetti e proiezione e da cui poi fare ritorno.
Come scrive Heidegger “l’essenza della modernità è la conquista del mondo risolto in immagine”, laddove l’immagine non è la raffigurazione del mondo ma questo concepito come immagine, “ciò in cui l’uomo si orienta e quindi come ciò che egli vuole porre innanzi a sé, rappresentarsi […] L’essere dell’ente è cercato e rintracciato nell’essere-rappresentato dell’ente”.
Ecco che allora la parola chiave dell’epoca moderna diviene “scoperte”, ovvero quell’insieme di pratiche attraverso cui l’ignoto diventa noto, l’irrapresentato si trasforma in rappresentato: “l’epoca delle scoperte comprende le campagne di globalizzazione terrestre condotte dai pionieri che volevano mettere delle immagini al posto di quelle che sino ad ora erano non-immagini, che volevano sostituire le chimere con registrazioni”. Con queste spedizioni verso l’esterno è l’esterno stesso che viene “addomesticato” e ricondotto a unità di misura identificabile, rappresentabile.
La verità non è più quella di un Dio trascendente, di un cielo incomprensibile e irraggiungibile dalle menti umane senza l’ausilio di una grazia divina, ma “sembra passare all’epoca della sua rilevabilità artificiale”, grazie all’impulso tecnico sempre più specializzato e la ricerca diviene un mero “furto ai danni del nascondimento”, un portare al noto ciò che era ignoto, un cancellare progressivamente quelle macchie bianche che nelle prime cartine e nei primi mappamondi stavano ad indicare le zone della terra non ancora scoperte e non ancora, di conseguenza, battezzate. Secondo il filosofo tedesco, dunque, non si può comprendere ciò che viene chiamato globalizzazione (e che i mass media fanno passare come fenomeno tutto nuovo e contemporaneo) se non lo si intende come “passaggio dalla meditativa speculazione sulla sfera alla prassi del suo rilevamento […] Fintanto che gli esseri pensanti al cospetto del cielo aperto meditavano sul cosmo in quanto volta – incommensurabile ma chiusa – restavano al riparo dal pericolo di raggelarsi nell’esposizione dell’esteriorità. Da quando hanno fatto il giro del pianeta, dell’astro errante che fa fa supporto per flore, faune, culture, si è spalancato su di loro un abisso, attraverso il quale guardano in un Esterno sconfinato quando rivolgono lo sguardo in alto. Un secondo abisso si apre nelle culture straniere che dimostrano che altrove può essere tutto diverso”.
Si assiste a una de-ontologizzazione degli spazi, una perdita di centro e, di più, di periferia, uno sfumarsi progressivo dei contorni ultimi da cui ci sentivamo protetti. La circumnavigazione del globo, la scoperta di nuove terre e nuove genti “porta l’Esterno ovunque, risucchia nello spazio del traffico le città aperte ai commerci e, alla fine, anche i più introversi villaggi, e questo spazio oblitera tutte le particolarità locali con i suoi denominatori comuni – denaro e geometria. Nessun luogo è più centro del mondo, ognuno di essi viene fagocitato in questa rete che cancella le ontologie locali e autoctone, che disintegra i focolari, “cancella l’antica poesia della domesticità”, tramutandoli in indifferenti stazioni e porti inseriti in un traffico anonimo e sconfinato. La Terra non è più madre né grembo entro cui rintanarsi al riparo dell’esterno, ma è bacino da scoprire, utilizzare, su cui guadagnare, “è l’immagine di un corpo a cui manca il margine protettivo”. Il primato è quello del fuori, in cui gli europei si sono addentrati in veste di scopritori, navigatori, mercanti e turisti e in cui il traffico diviene unità di misura del mondo. È stato il viaggio di Colombo a inaugurare “l’emancipazione dell’Occidente, smentendo il primato mitico-metafisico dell’Oriente”, per dirla con Rosenstock- Hussey, “l’oceano che Cristoforo Colombo ha attraversato ha trasformato l’Europa in Occidente”.
È da questa tendenza oceanica che prende le mosse il fenomeno della globalizzazione. D’un tratto quell’elemento odiato e temuto che era il mare (anche nell’Apocalisse di Giovanni si legge che dopo la venuta del Messia il mare non ci sarà più), diviene il mezzo attraverso cui compiere viaggi e fare scoperte, oltre al fatto che si spalanca in tutta la sua immensità, tanto da far risultare il termini “Terra” e “continente” ridicoli, se si pensa che i tre quarti della superficie del nostro pianeta sono fatti di acqua. L’oceano diviene il nuovo aldilà, un aldilà non più come un lassù celeste bensì come un laggiù terreno. I mari del mondo, da elementi estranianti e inaffidabili divengono i flussi di capitali e merci, sono ciò su cui si costruiscono i “seaborn empires delle nazioni europee come potenze mondiali”.
È l’avventura oceanica a creare nuovi attori che si lanciano in una corsa (anzi, una traversata) verso opportunità in mercati lontani, è da qui che si sviluppa la natura speculativa delle globalizzazione e da qui il sistema capitalistico. La scoperta e la presa di possesso di nuove terre forniva per mandanti, principi, borghesi di spedizioni oltremare l’auspicio di futuri guadagni, fatti per mezzo di transizioni commerciali. Il globo terrestre, divenuto navigabile e percorribile in tutti i suoi angoli più remoti rappresenta “l’immagine della fonte di denaro che dal futuro si riversa sul presente […] Il globo moderno ebbe la sua fortuna come orologio delle possibilità per una società di imprenditori impegnati in paesi lontani e in individui disposti a correre rischi, che sulle coste di altri mondi avvistano oggi le ricchezze di domani.” Il termine scoperta diventa sinonimo di investimento, che a sua volta è l’unione del commercio con il rischio.
La figura moderna dell’imprenditore è la diretta conseguenza di una nuova figura di individuo che vuole cercare da sé la sua fortuna e il suo futuro (non considerandosi più come semplice pedina nelle mani di Dio) muovendosi entro un gioco di possibilità e di rischi, di cui il viaggio verso terre sconosciute o inesplorate rappresenta la più appetitosa garanzia. Proprio la fortuna, l’ontologia della chance – e con essa l’uomo che è disposto a correre i rischi e ammalato di concorrenza – fa la sua comparsa come dea madre della globalizzazione e come figlia legittima della modernità: “su tutte quante le cose sta il cielo caso”, scriveva Nietzsche. Correre rischi, che però non sono lasciati alla totale imprevedibilità, ma divengono rischi calcolabili e calcolati su una scacchiera globale diviene il fondamento pragmatico della cultura moderna dell’attacco e dell’ambizione sfrenata: “grazie al fatto che l’esterno è allo stesso tempo anche il futuro e che il futuro post mundum novum inventum (dopo la scoperta del nuovo mondo) può venire presentato come lo spazio da cui provengono il bottino e il capitale, i primi navigatori e gli eccentrici mercanti- imprenditori scatenano quella tempesta di investimenti all’Esterno da cui poi si sarebbe sviluppata, nel corso di mezzo secolo, l’attuale ecumene capitalistico informatica. A partire dall’epoca di Colombo globalizzazione significa […] sottomissione del globo alla forma delle rendite.”
Il denaro si getta come merce sul mare aperto dei mercati, il capitale si imbarca sulle navi e tra queste la più razionale sarà quella che con maggiori probabilità farà ritorno . Il globo diviene il tavolo da gioco su cui gli investitori e gli avventurieri fanno le loro puntate, “mettono mano al mappamondo per superare i propri concorrenti nel vendere, speculare e guadagnare a distanza”, anzi, non semplicemente a distanza, non semplicemente guardando lontano ma sempre più lontano – da qui il motto imperiale Plus oultre sotto il segno del quale la flotta di Carlo V imperversava sugli oceani. In questa corsa verso terre sempre più lontane e sogni concreti di proficui guadagni, sono i termini nuovo, novità a costituire le parole d’ordine che fino ad oggi, insieme al successo, rimangano kantiane massime categoriche: “da quando l’Uomo Nuovo è stato catturato con una grande azione di richiamo dal mercato, le novità tecniche, le novità di procedura e le novità di design, costituiscono la più forte attrazione per tutti coloro che sono eternamente condannati a domandarsi: che fare per essere al top? Chi innova deve essere certo che la massima del suo agire possa costituire in ogni momento il principio di una legislazione universale”. Questo Uomo Nuovo deve però rompere con i suoi legami ctoni, con le sue concezioni di tipo conservatore-tellurico e realizzarsi come soggetto fluido, entro un elemento che è tale, deve mettere piede in coperta, immergersi nell’aldilà oceanico, dove la traversata sostituisce l’ascensione, per poter accedere verso quei mondi e le loro ricchezze la cui solo supposta esistenza costituisce anche la premessa e la promessa di una loro prossima presa di possesso, dove il possesso stesso diviene legge.
La terra diventa risorsa disponibile al primo che la conquista, abitata o disabitata che sia, si offre a colui che la scopre che ne diviene il legittimo (dal suo punto di vista) padrone e detentore. Nel loro puro prendere gli attori dell’espansione si sottraggono alle pretese di scambio equo e nelle loro azioni di appropriazione vedono anche gli eventuali abitanti delle nuove terre come oggetti del loro nuovo possesso, oggetti da eliminare, sfruttare, convertire e studiare. Gli efferati genocidi, lo sterminio di intere popolazioni autoctone rispondono a questa legge del possesso – o per dirla con Melville , al “Possesso che è tutta la legge”, secondo cui ciò che “non ha proprietario” può essere preso e trasformato in una chance da cui trarre profitto o che semplicemente deve essere spazzato via perché d’ intralcio ai propri piani di dominazione. Purtroppo ancora oggi tutto ruota intorno al profitto, al dio denaro emerso dal mare, dalle traversate che da avventure cariche di sogni si sono trasformate in semplici traffici di merci e di capitali, da utopie i non-luoghi lontani, favoleggiati e fantasticati, hanno assunto solo il ruolo di solidi e concreti Eldoradi, forzieri da cui trarre tesori a proprio piacimento, da cui andare e tornare come proiettili lanciati a velocità impazzita, velocità sempre più incontrollabili, in questo traffico di terra, mare, cielo, che oggi è diventato soprattutto traffico mediatico o di rete, in cui le distanze si sono annientate, le particolarità cancellate, le vicinanze annullate in una prossimità sempre più anonima e alienata. Si è tutti vicini ma sempre più distanti.
E il mare, come l’oceano sono soltanto altre strade su cui trafficare e far trafficare di tutto e di più, non è più quello magico di Ulisse, né quello di Melville, che nel suo capolavoro Moby Dick, faceva dire a Ismael nelle prime indimenticabili pagine (chi non conosce l’epico esordio “Call me Ismael”?): “Ogni volta che nell’anima mi scende un novembre umido e piovoso, […], ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un forte principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente il cappello per terra alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare.”
Pubblicato per la prima volta il 26 maggio 2013

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.