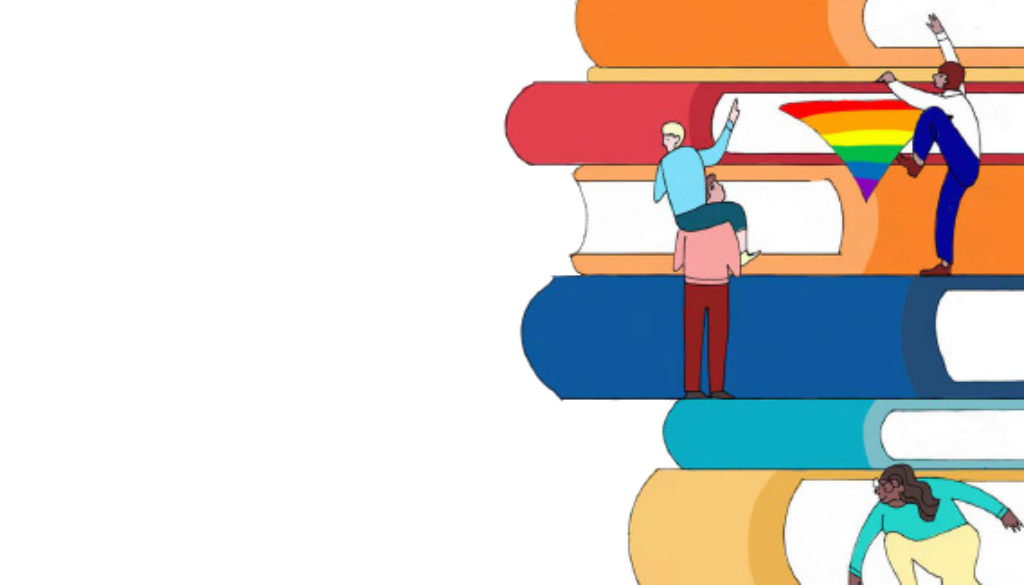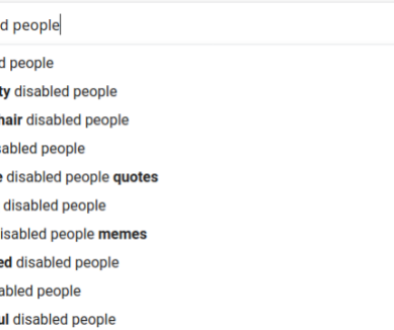Il 17 e il 18 gennaio presso il Centro Congressi Le Benedettine a Pisa, l’Università di Pisa e il Comitato Unico di Garanzia hanno organizzato il seminario intitolato Le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
Moltissimi e moltissime i relatori e le relatrici, a cominciare dal Comitato Scientifico Organizzativo presieduto da Elettra Stradella, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa. Non potendo soffermarsi su ogni intervento del congresso, ci concentreremo sulla seconda sessione del 17 gennaio, che ha affrontato la tematica della discriminazione da una prospettiva giurisdizionale e legislativa. Della prima sessione, maggiormente teorica, mi piacerebbe soltanto accennare all’efficacia di un concetto utilizzato da Brunella Casalini, professoressa associata di filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze e Presidente del Cug della stessa Università, che ha parlato di temporalità queer riferendosi alla precarietà dei ricercatori, che, secondo una lettura, tra gli altri, di Lee Edelman, possono essere considerati, proprio per la loro precarietà, la loro indeterminatezza, dei soggetti queer. In una fase di neoliberalizzazione delle università sempre più pervasiva e selvaggia, i giovani precari possono esser visti come soggetti queer in quanto la loro incertezza lavorativa li relega in uno spazio limbico, in un’eterna adolescenza, in uno spazio negativo senza reale inizio né direzione, la cui precarietà e “improduttività” all’interno dell’accademia o dell’università si lega indissolubilmente ai fattori di svantaggio e di precarietà, sociale, economica, esistenziale del mondo esterno. Sono soggetti fuori sincrono. Ma è proprio a partire dal ripensamento delle molteplici temporalità – che si connettono inevitabilmente alle diseguaglianze sociali ed economiche –, dalla ridefinizione di una “cromobiopolitica” che si può mettere in discussione la cronopolitica neoliberale tipica delle università e delle accademie e volta al disciplinamento dei soggetti come prodotti numerabili, perfettamente quantificabili entro un paradigma riproduttivo e di trasmissibilità del prestigio. Le teorie queer, grazie al loro carattere anti eteronormativo e anti-normativo tout court possono offrire spunti per le accademie e le università, per ripensare gli spazi – soprattutto quelli collocati sul confine tra pubblico e privato – i tempi e le finalità del sapere accademico. Adottando una prospettiva queer, si potrebbe porre un argine all’esclusione e alla marginalizzazione di interi campi di sapere che inevitabilmente sfociano anche in una marginalità e in un’esclusione di determinati soggetti, di determinati corpi. I soggetti portatori di diversità rispetto all’ordine sociale, culturale e simbolico binario ed eteronormativo parlano fuori dal coro, segnalano un problema, “esprimono una sofferenza che gli altri non percepiscono, vivono una negatività silenziosa, che noi, chiusi nel privilegio dello spazio rassicurante tracciato intorno a noi, non abbiamo bisogno di conoscere, o che abbiamo bisogno di continuare ad ignorare”. I corpi portatori di “diversità” gridano la propria negatività, la propria invisibile sofferenza ed “è solo nella misura in cui riusciremo a interrogare questa negatività, questi sentimenti negativi che alcuni corpi denunciano, che alcuni corpi manifestano di provare nello spazio accademico (disagio e malcontento che ha una radice sociale), potremmo cambiare la natura dell’università in modo da renderla capace di produrre un sapere realmente emancipativo”. Come si legge nel programma della conferenza “si tratta di ripensare totalmente un’istituzione, quale l’università, che continua a scontare le sue origini androcentriche, affinché sia possibile l’ingresso al suo interno, a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, di persone portatrici di diversità che possono dare vita a nuove forme di convivenza e a nuove prospettive di ricerca e studio” (B. Casalini).
Ma arriviamo alla seconda sessione, moderata da Gaetana Morgante, che ha visto un excursus sulle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere (mostrando discipline, norme e prassi), prendendo in considerazione sia la discriminazione in ambito giuslavoristico (ancora il quadro italiano è segnato da un tasso di discriminazione piuttosto significativo, sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro con i suoi criteri di selezione fortemente connotati che le condizioni stesse di lavoro, fino ad arrivare agli eventuali licenziamenti su basi discriminatorie in ragione dell’identità di genere e/o dell’orientamento sessuale), penalistico, amministrativo, pubblicistico, fino ad arrivare alla questione dei percorsi di riconoscimento di genere e di transizione di sesso e al modo in cui essa viene disciplinata dalla legislazione.Essendo il tema poco dibattuto e, probabilmente poco conosciuto (e non potendo riportare tutti gli interventi succedutisi durante l’iter della sessione) proverò a riportare un intervento inerente a quest’ultima questione. Innanzitutto occorre premettere che in Italia non abbiamo una normativa specifica di riferimento sulle identità di genere e dunque sulle persone transgender. Sebbene, come vedremo, esista una legge di riferimento in materia di rettificazione del sesso, parecchio desueta (risale al 1982), manca una normativa specifica che tuteli contro le discriminazioni in ragione dell’identità di genere e dunque delle persone transessuali, come invece, ad esempio, esiste una normativa antidiscriminatoria specifica per la cosiddetta “razza” e l’origine etnica, come ha ben spiegato Anna Lorenzetti, ricercatrice di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo. In assenza di una normativa specifica si fa perciò ancora riferimento al Codice delle Pari Opportunità, d.lgs 198/2006, che disciplina le discriminazione di genere sui luoghi di lavoro e che, tra le altre cose, ha avuto il merito di distinguere tra discriminazioni dirette e discriminazioni indirette (ma sempre riguardanti le donne lavoratrici e non le identità di genere plurali), oltre a introdurre il collegato lavoro (che ha esteso le garanzie di tutela contro i fattori di discriminazione in ambito lavorativo).
Bisogna anche sottolineare che i casi di discriminazione a danno delle persone trans si sono tutti risolti negativamente, come ha mostrato Lorenzetti, senza cioè riconoscere l’avvenuta discriminazione, e, anche quando questa appariva decisamente fondata, motivata e argomentata, durante i ricorsi non è mai stato chiamato in causa il diritto antidiscriminatorio, mentre semplicemente si sono chiamati in causa apparati normativi di natura disciplinare e deontologica (ad esempio nei casi riguardanti discriminazioni da parte delle forze dell’ordine), rispetto ai quali si è parlato di una mera violazione dei propri doveri ma non di atti specificamente e pesantemente discriminatori nonché particolarmente lesivi della dignità della persona.
Pur mancando casi diretti di condanna bisogna però ricordare che il già citato Codice delle Pari Opportunità sarebbe in ipotesi applicabile anche in caso di discriminazioni ai danni delle persone trans in nome di un’interpretazione compatibile – e forse anche dovuta – di una direttiva che il codice aveva implementato, che faceva riferimento diretto alla necessità di considerare la discriminazione fondata sul genere anche per quei casi di discriminazione in ragione del cambiamento di sesso o delle condizioni di chi è in fase di transizione. Tuttavia in ambito lavorativo non pare vi siano o vi siano state pronunce in merito.
Anche in ambito di accesso a beni e servizi si assiste a un vuoto normativo allucinante per quanto riguarda le discriminazioni in ragione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale; il nostro legislatore si è infatti ben guardato dall’ampliare i confini dell’ambito oggettivo del decreto legislativo di riferimento e pertanto dobbiamo attenerci a normative di natura generica come il codice del consumo o il codice civile.Una normativa specifica sarebbe invece di necessaria cogenza, dato che le prassi restituiscono un quadro di profonda problematicità discriminatoria, di gravi stigmatizzazioni e discriminazioni in ragione dell’identità di genere. Si possono citare variegate sfere in cui la discriminazione a danno delle persone trans appare più diffusa e palese. Si pensi all’ambito degli affitti (spesso si assiste al rifiuto di affittare a persone trans o di aumentare i prezzi alle donne trans in quanto percepite, secondo una lettura totalmente stereotipata, come prostitute), all’ambito turistico, all’ambito assicurativo (che non è stato colmato, soprattutto per quanto riguarda i casi di omogenitorialità), all’ambito sanitario (in cui ad esempio c’è un automatismo, per le persone omosessuali che fanno delle analisi, sulla questione del test dell’Hiv, mostrando così una significativa lettura stereotipata), per non parlare dell’ambito della scuola e dell’ambito sportivo che è forse il concentrato delle stigmatizzazioni stereotipiche e delle prassi discriminatorie, in nome di una forte “ideologia” basata sulla virilità e “l’identità maschia”, seppure anche in questa dimensione non manchino esempi positivi che vedono presenze di sportivi e sportive transessuali in sport come il tennis e recentemente la pallavvolo.
Anche il settore della detenzione è particolarmente esposto alle discriminazioni ai danni delle persone transessuali, soprattutto nei confronti delle donne trans, il più delle volte recluse nei reparti maschili, in balia di potenziali e probabili sex offenders. In ambito sanitario assistiamo però anche a una buona pratica: è stata messa a tema dall’Istituto Superiore di Sanità la peculiarità della salute delle persone trans, facendo degli studi su alcune patologie ricorrenti su quei corpi che hanno attuato una transizione di genere e che non possono, non devono, essere elusi. Altra pratica virtuosa, appartenente al mondo dell’università, è l’introduzione del doppio libretto: accanto alla tradizionale documentazione di immatricolazione universitaria riportante i dati anagrafici se ne affianca un’altra con il nome scelto dal/dalla studente/ssa.
Arrivando al tema specifico dell’identità di genere dal punto di vista della legge in materia di rettificazione del sesso, Chiara Angiolini, ricercatrice post-doc all’Università di Trento e collaboratrice dell’Université Paris Sorbonne, ha preso in esame gli argomenti utilizzati da dottrina e giurisprudenza sottoponendo a critica la non obiettività di definizioni quali sesso e genere – e della relativa appartenenza– , sulle quali non vi è un condiviso consenso.Questo, come si legge nel programma “conduce a rilevare il carattere convenzionale e non oggettivo dei criteri usati, e ad affrontare il tema dei soggetti che sono legittimati a stabilirli nel contesto giuridico, ai fini dell’applicazione della legge sulla rettificazione”. Anzitutto alcune premesse.
Per identità di genere ci si riferisce, come sopra accennato, al “senso psicologico del sentirsi maschio o femmina (o nessuno dei due) e, laddove il sesso biologico, ovvero quello che risponde alle caratteristiche genetiche, non trova corrispondenza nell’identità di genere, la persona può essere indicata come transgender o Gng (gender non conforming)”.Entrambi i termini sottolineano la “deviazione” rispetto alla norma socio-culturalmente radicata, al paradigma che prescrive il binarismo di genere, ovvero l’esistenza di due soli sessi biologici (maschio e femmina), perfettamente distinti e che dà per scontato che ogni persona dovrà rimanere incasellata nel sesso biologico che le viene assegnato alla nascita. Conseguentemente a questo principio normativo non solo si snoda tutta una serie di stereotipi legati al sesso e al genere cui ciascuno di noi dovrebbe conformarsi/performarsi (Judith Butler parla proprio di performance per adeguarsi all’idea, o meglio, all’ideale del maschile e a quello del femminile) ma diviene regime di verità, principio performante e performativo, anche l’obbligatorietà dell’orientamento eterosessuale, rispetto al quale qualsiasi altro orientamento viene visto come deviato, a-normale, non-conforme.
Per quanto, come sottolineato da Angiolini, non vi è ancora un consenso del tutto omogeneo sulla definizione, nell’ambito delle scienze psicologiche e sociali, si è abbastanza concordi (per lo meno dalla seconda metà del secolo scorso, ovvero quando il termine è entrato in uso) nel considerare il genere, differentemente dal sesso (che come abbiamo detto viene usato per indicare il corredo cromosomico, l’appartenenza a una categoria biologica e genetica), “l’identità e il ruolo di un soggetto in relazione alle categorie di «maschile» e «femminile». […] Il concetto di genere sposta il riferimento sul piano dell’esperienza psicologica, culturale e inevitabilmente politica delle categorie di maschile e femminile. Il genere è dunque una rappresentazione sociale che indica le credenze culturali e le aspettative sociali sull’uomo e sulla donna e, di conseguenza, ha un carattere acquisito e non innato”.
Per rendersi conto dell’anacronismo e dell’aderenza mentale e pragmatica al binarismo di genere e all’eteronormatività obbligatoria, basti notare come la varianza o non conformità di genere, fino a poco tempo fa rientrasse nel DSM, che originariamente rappresentava l’acronimo di Disturbi dello Sviluppo Sessuale (Disorders of Sex Developement) e che illustrava la descrizione medica di alcuni tipi di variazioni delle caratteristiche sessuali considerate dal punto di vista medico come vere e proprie patologie.
Se già il linguaggio appare dunque viziato dall’interiorizzazione dell’ordine normativo fondato sul binarismo di genere e sull’eteronormatività obbligatoria (tant’è che si parla di devianza, di non conformità, sulla base convenzionale e data per scontato che il conforme, il riferimento basico, siano la dicotomia maschile-femminile e l’orientamento eterosessuale) fa un po’paura pensare che fino al 2013, nel DSM, il maggiore strumento diagnostico e di classificazione dei disordini mentali, il transessualismo rientrasse nell’elenco dei disturbi mentali come “disturbo dell’identità di genere”.
Nel 2013 invece, con la pubblicazione della quinta edizione del DSM (DSM-V) il transessualismo non rientra più nell’elenco delle malattie mentali dato che non viene più contrassegnato come “disturbo dell’identità di genere” ma si fa solo riferimento alla Disforia di genere che, come si legge nel DSM-V, denota “l’incongruenza tra il proprio genere così come è esperito o espresso e il genere assegnato”.Come abbiamo già accennato, il linguaggio è di per sé inquinato e condizionato dall’ordine normativo esistente e dai sistemi di pensiero che ancora oggi affondano le proprie radici nel sistema sociale, politico, economico e mentale dei soggetti.
Le nostre espressioni contengono implicitamente un confronto rispetto a quello che è percepito come il modello, il termine di paragone, la base rispetto a cui definirsi e rispetto a cui disconoscersi, rispetto a cui “tirarsi fuori”, facendo largo uso della particella “non” e il concetto di alterità e diversità rispetto a quello che è considerato l’essere, definendo cioè ciò che sono non in maniera affermativa ma spesso, almeno inizialmente, alle prime scoperte del sé e della propria identità sessuale e di genere, in negativo, contrapponendosi a quella che appare essere la norma e la normalità (“non sono eterosessuale”; “non mi sento né maschio né femmina” etc.).
Il linguaggio è dunque già portatore di normatività, assorbendo e riproducendo un modello rispetto al quale ci definiamo e, in caso, ci distinguiamo, ci distanziamo, ma, pur in questa distinzione e in questa presa di distanza ribadendo ancora una volta l’esistenza (fin tanto che non siamo disposti, politicamente, culturalmente, socialmente e psicologicamente, ad allargare potenzialmente all’infinito la norma per accogliere e lasciar entrare qualsivoglia pluralità) di un paradigma di “rettitudine”, di sanità e “normalità” rappresentato dall’aderenza al sesso biologico assegnato alla nascita (distinto nelle categorie binarie di sesso maschile e sesso femminile) e all’orientamento eterosessuale, stigmatizzando così come devianza, come non conformità, come a-normalità qualsiasi differenza, qualsiasi pluralità e alterità rispetto a questo paradigma normativo, a questo modello prestabilito, imposto e interiorizzato psichicamente e percettivamente, l’espressione “disforia di genere” appare comunque un po’ più adeguata rispetto alla precedente “disturbo dell’identità di Genere”, in quanto coglie “una componente emozionale negativa ed eversiva nei confronti del proprio sesso biologico: non esiste una patologia associata all’identità di genere in sé, ma solo la possibilità di provare disagio verso il proprio genere in quanto si avverte una non corrispondenza tra questo e il sesso anatomico”.
In effetti parlare di sensazione di disagio (termine molto più neutro rispetto a quello di disturbo) all’interno di un corpo che non si sente corrispondere alla propria identità sembra molto più appropriato rispetto al termine, fortemente connotato come deviante rispetto a un modello imposto e percepito come naturale, disturbo mentale o disturbo dello sviluppo sessuale.
Le persone non Cisgender, ovvero le persone che nutrono questo disagio rispetto al sesso biologico, che non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita e che desiderano mutare i propri caratteri somatici per adeguarli alla propria identità di genere possono (ma non tutte lo desiderano, riuscendo a trovare un’armonia con il proprio corto e sanando, anche, spesso, in conseguenza di numerosi trattamenti ormonali e/o estetici, il conflitto tra la componente psichica e le condizioni anatomiche) ricorrere alla cosiddetta chirurgia alternativa di genere che prevede una serie di interventi “sulle caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie con lo scopo di adeguare l’aspetto fisico di un individuo alla sua identità di genere”.
La chirurgia affermativa del genere può essere parte integrante del trattamento necessario per alleviare la disforia di genere e può includere mastectomia, isterectomia, metoidioplastica, falloplastica, aumento del seno, vaginoplastica, femminilizzazione del viso e/o altre operazioni chirurgiche. Si parla di FTM (female to male) per le persone a cui è stato assegnato alla nascita il sesso femminile e che vogliono cambiare la propria identità di genere in direzione di un corpo e/o un’identità maschile. Si parla, nel caso contrario, di MTF (da sesso maschile a un’identità di genere e/o a un corpo femminile).
Spesso, nel linguaggio comune si usa il termine transgender, o, più spesso ancora transessuale, per riferirsi a entrambe le persone, usando per altro (testate giornalistiche comprese), troppe volte, gli articoli sbagliati, ledendo così, anche dal punto di vista linguistico e verbale, l’identità della persona.
La seconda parte dell’articolo cliccando qui.
Immagine di copertina liberamente ripresa da www.unipi.it

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.