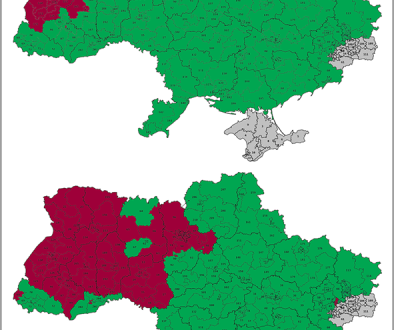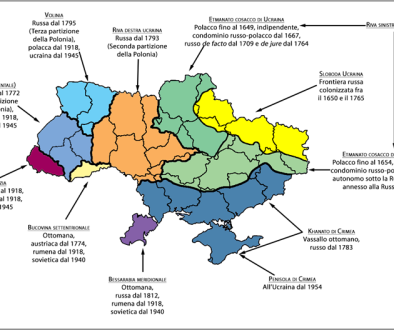Pubblicato per la prima volta il 10 ottobre 2018
Oggi la qualità di questa circolazione di opinioni tanto nella vita reale, quanto in quella virtuale della rete, sembra limitarsi a slogan e retorica privi di contenuti complessi, che danno l’impressione di assistere a una costante campagna elettorale, improntata a edificare ed esaltare sempre di più la figura del leader di turno, così come la qualità del dibattito pubblico, della discussione politica (sui vecchi e nuovi media) sembra limitarsi all’affondamento dell’avversario politico, alla denigrazione dell’altro, al discredito dell’interlocutore o all’attacco feroce di intere categorie, di blocchi di individui umani che compongono la nostra società o che magari giungono da altre sponde. E la rete non fa che potenziare e rendere visibile questa deficienza della discussione pubblica.
Quello che, secondo chi scrive, sembra accadere tendenzialmente sul web non è un dibattito virtuoso in cui vengono esposti, spiegati, confrontati in maniera civile, due o più punti di vista contrapposti, ma è una gara a chi urla più forte contro il capro espiatorio di turno. Spesso gruppi sferrano attacchi pesantissimi dalle proprie pagine contro altri esseri umani che neanche possono rispondere delle ignobili offese (come i migranti o i rom ad esempio), persone che fanno banda per aggredire e mettere alla pubblica berlina persone che neanche sono state causa di provocazione (come accadde alla ragazza che durante una manifestazione aveva sfoggiato un cartello contro i fascisti e si è trovata contro un’abominevole scia di insulti e offese meschine e vigliacche e sessiste, di una violenza inusitata). Non sono, per lo più, dispute quelle a cui assistiamo sul web, perché mancano i contenuti, gli elementi, le argomentazioni, le opinioni politiche dotate di senso critico e che rivelano un pregresso ragionamento, ma offese, insulti, slogan.
Perciò questa pluralità di idee, di parole, questa libertà democratica che Gheno e Mastroianni esaltano resta vera in linea teorica, ma calata nella realtà diventa una permissibilità autorizzata a essere crudeli, a demolire l’altro o un gruppo di altri; diventa accessibilità senza controllo (o comunque pochi controlli) a ogni tipo di linguaggio, di invettiva, di falsità, di mistificazione, di aggressione verbale e psicologica. Diventa legittimazione, in nome di una libertà di opinioni, in nome di una democraticità infinita dell’espressione, a dire qualsiasi cosa anche nel caso sia nociva della dignità altrui o sia particolarmente razzista, violenta, istigante odio sociale e oggi, più che mai, razziale. Non che prima fossimo tutti dei santi, anzi.
Non è che, parafrasando il grande Umberto Eco, “I social media ci rendono tutti più imbecilli”, ma semmai, i social media danno maggiore visibilità a tutti gli imbecilli che sempre sono esistiti e che sempre esisteranno e che non sono stati creati dai social media. Quella libertà di espressione sul web, però, dà pieno potere di parola a tutta l’imbecillità e l’ignoranza, aggressività umane e questo andrebbe arginato, soprattutto in quanto potenzialmente lesive di altri esseri umani, individui singoli o collettività che siano.
Quello che oggi è venuto a cadere, come hanno chiarito Gheno e Mastroianni, è una sorta di filtro che prima era costituito da professionisti, mediatori, giornalisti, intellettuali che selezionavano le notizie e che conducevano un dibattito più sano e civile. I social media invece possiedono questa straordinaria capacità di immettere nel sistema contenuti continui, infiniti, incessantemente, senza che ci sia alcun filtro a valutarli, selezionarli, distinguere i contenuti dotati di verità da quelli palesemente falsi. Questo provoca perciò una proliferazione di notizie false che circolano sulla rete e che vengono “ripostate” e diffuse fin quasi a diventare virali.
Dall’altro lato, insieme alla perdita del filtro, abbiamo anche la fine del “modello broadcast” come spiega Mastroianni, ovvero la fine del modello della comunicazione di massa che mira ad ottenere il consenso della maggiore fetta di pubblico. Valutando quanta popolarità, quanto consenso ha ottenuto il mio discorso, quanta fetta di pubblico esso è riuscito a sedurre, quanto share ha fatto, io ottengo un risultato, che se soddisfacente, mi fa mettere da parte quella fetta di pubblico minoritaria che il mio discorso non è riuscito a raggiungere e sedurre. Sui social media però quella fetta residuale di pubblico, quella minoranza non è più silenziosa perché chiunque sulla rete può immettere contenuti, che sia una voce minoritaria rispetto a quella maggioritaria. Sulla rete il pubblico, maggioritario o minoritario che sia, diventa pubblico agente e autorizzato a immettere continui nuovi contenuti, i quali, senza che ci sia un minimo di filtro, possono essere di qualsiasi tipo.
Se dunque la libertà di espressione è stata una grande conquista delle società democratiche, quello che oggi manca e costringe a mettere in discussione questa stessa libertà e pluralità di voci, è un’educazione al pensiero critico e al linguaggio. All’uso delle parole. Mancano strumenti cognitivi che ci insegnino a utilizzare dei mezzi che danno piena e totale, incondizionata e non controllata libertà alle nostre parole. Dobbiamo essere educati a diventare responsabili. O meglio, ad acquisire la consapevolezza di avere una grande responsabilità ogni volta che immettiamo un contenuto che si espone al pubblico, che diventa accessibile a chiunque lo legga. Dobbiamo imparare a gestire questa enorme responsabilità, senza sottovalutare il potere delle parole.
Quello che a parere di chi scrive è particolarmente grave è che coloro che rivestono un ruolo politico, che più di tutti potrebbero contribuire a dotarci di più adeguati strumenti e ad educarci a essere responsabili delle proprie parole così come delle proprie azioni, rischiano invece di fornire il peggiore esempio. Non è infatti solo il normale e privato cittadino a fare uso e abuso di parole di odio o miranti alla demolizione del nemico o del capro espiatorio, a diffondere informazioni false e strumentali, ma è anche una buona rappresentanza della politica che si serve di un linguaggio sprezzante, denigratorio, aggressivo, violento e mistificatorio.
Anziché educare ed elevare i cittadini a un tipo di comunicazione civile, alta, rispettosa dell’altro, aperta al dialogo e al confronto, si abbassa al livello ferino degli istinti più animaleschi di ciascuno di noi, e anzi, spinge le persone verso questo tipo di bassezza, in un circolo vizioso da cui sembra impossibile uscire. Non è un caso che il nostro governo faccia ampio uso di metafore che spingono alla ricerca di un nemico da eliminare, che siano i “poteri oscuri” dei mercati o dell’Unione Europea o dei tecnici presenti al MEF o che siano gli stranieri che devono smettere di “godersi la pacchia”, per non parlare dell’immagine della famosa ruspa. Ogni espressione incita all’odio verso qualcuno, che sia reale e concreto o che si tratti di un’entità astratta come nel caso dei poteri forti, del “sistema”, dei poteri oscuri e occulti.
Come ricorda Gianrico Carofiglio nel suo Con parole precise, nel 1651 Thomas Hobbes propose addirittura l’abolizione dell’“uso metaforico delle parole” dal linguaggio politico. La proposta naturalmente non venne mai accolta, sia perché l’uso delle metafore è qualcosa di quasi atavico nel linguaggio politico – proviene da una storia antica che va da Platone a Machiavelli fino ad arrivare allo “Stato-macchina” della modernità e allo “Stato guardiano notturno” del teorico del libertarismo Robert Nozick degli anni settanta del Novecento, sia perché lo stesso Hobbes ha impostato tutta il suo sistema filosofico contrattualista, tutta la sua riflessione politico-filosofica su una grande metafora biblica di imperitura efficacia, ovvero quella del potente Leviatano. Inoltre “la metafora è una forma del pensiero. Essa rappresenta il modo in cui funziona la nostra mente nel momento in cui tenta di allargare il suo campo di conoscenza”[1]. Il nostro stesso modo di ragionare, di pensare e dunque di parlare “è disseminato di metafore. […] Il nostro è un linguaggio metaforico”[2]. Pertanto il problema non consiste nell’uso delle metafore in sé, ma sta nel fare della metafora uno “strumento di manipolazione e ottundimento dell’intelligenza individuale e collettiva”[3] o “un mezzo di trasformazione del reale”[4]. In questo caso le metafore diventano un mezzo potente con cui si tesse una narrazione, un racconto fittizio che si sostituisce, come dicevamo in partenza, alla realtà.
Anche la narrazione fa parte della attitudini umane. Tutti noi vogliamo raccontare, perché solo raccontando i fatti interiori o esteriori che viviamo, acquistano valore di realtà, solo se vengono raccontati essi cominciano a esistere. Esistere per noi e per gli altri. La parola dona essenza ontologica, dona realtà ed esistenza. Per questo tutti, a diversi gradi, sentiamo l’urgenza di dire ciò che viviamo, di raccontare a noi stessi o, più che altro, a qualcuno, ciò che ci è accaduto, dentro o fuori di noi, per fare esistere quel fatto, quell’avvenimento. Abbiamo bisogno di essere chiamati, di essere raccontati, abbiamo bisogno di raccontare e di raccontarci affinché possiamo avvertire il sentimento dell’esistere, affinché spossiamo sentire, avvertire di essere, di esistere e, il più delle volte, di esistere per altri.
“La nostra capacità di affrontare il mondo e la vita è funzione della nostra capacità di raccontarli – a noi stessi e agli altri – e dunque di dare loro significato e direzione. Questo vale in moltissimi ambiti, ma esiste un fondamentale territorio dell’agire umano in cui il racconto – la narrazione […] – svolge una funzione cruciale e spesso fraintesa. Si tratta del territorio della politica. La qualità della politica, in tutte le epoche e oggi più che in passato, dipende dalle parole che si scelgono per interpretarla, dalle storie che si scelgono per raccontarla e soprattutto dal valore e dalla forza metaforica di queste storie. Se usata come un ponte tra esperienza percettiva, emozione, pensiero e linguaggio, la metafora è forse il più potente meccanismo di elaborazione e di arricchimento cognitivo di cui disponiamo. […] Ma proprio la sua capacità di ricalcare il modo in cui si formano molti nostri pensieri e molte emozioni fa della metafora anche un insidioso, potentissimo mezzo di manipolazione”[5].
Se dunque il bisogno di raccontare è insito alla natura umana e considerando che ogni sistema politico si serve della narrazione per comunicare in maniera efficace le proprie azioni, il proprio messaggio politico, i propri intenti programmatici, progetti di cambiamento e visione globale della realtà su cui si vuole incidere per poter provare a costruire una migliore società seguendo un orizzonte e di ideali che siano il più possibile lungimiranti, quello che risulta meno naturale è quando la sola narrazione diventa l’unica (non)azione della politica.
In tal modo la politica si fa mera e costante propaganda, senza un reale progetto di miglioramento del reale, senza una significativa e strutturata visione della società che si vorrebbe andare a realizzare e che soprattutto mistifica, per trovare sempre più consensi, la realtà stessa dei dati, dei fatti, dei numeri, delle statistiche e delle parole autorevoli e verificabili di esperti che, insieme ai “buonisti”, vengono perennemente posti sotto attacco da un governo, come quello attuale, che ha fatto un vanto, un merito dell’ignoranza e del pressappochismo contro “lo snobismo” degli intellettuali. Tutta la complessità di tematiche importanti del nostro tempo viene ridotta a mero slogan emozionale, che si rivolge esclusivamente alla pancia delle persone e non alla loro testa.
Anziché essere elevate da un più nobile discorso politico, anziché essere educate a un linguaggio che innanzitutto rispetti la dignità di ogni interlocutore, anziché essere dotate di strumenti cognitivi per poter scandagliare la complessità del reale nelle sue sfaccettature e per potersi adoperare in ragionamenti dotati di senso logico e analitico, anziché essere aiutate nello sviluppo di una coscienza critica e capace di acquisire maggior consapevolezza rispetto a ciò che accade e a coloro che ci circondano, anziché essere messe in condizione di fruire di una narrazione che pur avvalendosi di ideali e di una visione socio-politica mirante alla trasformazione dello stato di cose reali non cessi di aderire ad esse, per poter intervenire su queste in modo efficace, le persone vengono lasciate in balia delle reazioni più ferine e istintuali che si riversano, talvolta, o anzi, sempre più spesso in maniera drammaticamente violenta su altri esseri umani, credendo di trovare piena legittimazione nel messaggio e nel discorso politici dell’attuale governo (o comunque di alcuni dei suoi membri).
Non possiamo entrare in questo aspetto, perché esulerebbe dal ragionamento più prettamente concentrato (o che per lo meno prova a esser tale) sulla comunicazione, ma quello che preme sottolineare è che quando la narrazione smette di aderire alla realtà dei fatti e costruisce una propria verità, questa verità assurge a unica possibile inglobando qualsiasi discorso falso, fittizio, non verificabile che sia rispecchiante di questa pseudo verità, di questa narrazione mistificante e costruita a tavolino soprattutto per interessi consensuali e per dare una certa immagine della società e del paese che possa legittimare alcuni interventi particolarmente feroci, securitari, disciplinanti e discriminatori.
Creare una propria verità fingendo di aderire alla “verità dei fatti” è molto pericoloso. Un fatto non è né vero né falso. Un fatto accade semplicemente. Quello che può essere vero o falso è il racconto che facciamo di quel fatto, la narrazione che ne diamo e sempre di più sembra che politici e normali cittadini stiano perdendo contatto con la realtà dei fatti, con i dati reali. Ciascuno di noi dovrebbe diventare una sorta di controllore delle proprie e delle altrui parole e mettere a revisione la narrazione martellante cui veniamo sottoposti, valutare se essa aderisca e sia coerente con i dati e i fatti reali. Sottoporla a critica serrata per non lasciarci aggiogare da una non verità, da un discorso fittizio e non testimone di verità.
“Se l’uso fraudolento della lingua è una pratica antica, oggi potenziata dai mezzi di comunicazione di massa, negli ultimi anni si è soprattutto registrata una progressiva perdita di aderenza delle parole ai concetti e alle cose. Consumate con usi impropri, eccessivi o anche solo inconsapevoli, le nostre parole vanno perdendo significato e contatto con la realtà che, dunque, divengono incapaci di modificare. In una simile situazione è necessario estendere a tutti i cittadini quel «dovere morale» che Karl Popper attribuiva agli intellettuali. […] Ciascuno di noi dovrebbe prestare una cura disciplinata della parola, non solo nell’esercizio attivo della lingua – quando parliamo, quando scriviamo – ma ancor più in quello (apparentemente) passivo: quando ascoltiamo, quando leggiamo. Anche perché solo le parole che rispettino i concetti, le cose, i fatti, possono rispettare la verità”[6].
Secondo il già citato John Searle, le società sono costruite e si reggono “su una premessa linguistica: sul fatto, cioè, che formulare un’affermazione comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Non osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la fiducia in un linguaggio condiviso”[7]. Ciascuno di noi, ma soprattutto chi riveste un ruolo pubblico (come un politico, un magistrato, un insegnante, uno scrittore, uno scienziato), ha il dovere di usare responsabilmente le parole “per dire, in forme e contesti diversi, la verità”[8].
Se perciò, come ha detto Vera Gheno, citando la poesia di John Donne, “nessun uomo è un’isola” e ha un bisogno innato di comunicare per intessere relazioni, per connettersi con altre isole, tanto per rimanere in tema di metafore, creare arcipelaghi, se il desiderio di raccontare è un afflato umano bello e atavico, dobbiamo imparare a educare la nostra lingua, il nostro linguaggio, le nostre parole, che sono lo specchio dei nostri pensieri. E quindi prima di tutto, dobbiamo essere educati, o educarci a pensare. Leggere, studiare, informarsi, provare ad educare il nostro pensiero alla problematizzazione, alla messa in discussione, alla criticità, alla verificabilità e al rispetto delle opinioni altrui quando non sono lesive della dignità di altri esseri umani.
Solo un pensiero bello può essere detto e scritto da una lingua altrettanto bella. E solo una lingua bella è specchio di un bel pensiero. “Scrivere bene” (e, aggiungerei, parlare bene) “ha un’attinenza diretta con la qualità del ragionamento e del pensiero. Implica chiarezza di idee da parte di chi scrive e provoca in chi legge una percezione di onestà. Come sosteneva Calvino, «cercare di pensare e d’esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l’unico atteggiamento onesto e utile»”[9].
Gheno cita un aneddoto presente nel libro di Mastroianni nel quale una suora che insegnava al filosofo quando andava alle elementari chiede ai suoi alunni se preferiscano i muri puliti o quelli sporchi. In coro i bambini rispondono che amano di più i muri puliti. “c’è un posto dove esistono i muri puliti”, dichiara a quel punto la suora, “questo posto sono i regimi”. La democrazia è fatta di scritte sui muri. Semmai sta a noi ripulire le scritte che minacciano il buon vivere comune. Ma nessuno, in democrazia, può impedire a un altro di imbrattare il muro e scriverci qualcosa, a meno, ripetiamolo, non sia lesiva nei confronti di altri (e su questo mancano ancora troppi controlli e sanzioni).
Bisogna però essere all’altezza della democrazia, dice Mastroianni, essere all’altezza di questo grande privilegio di libertà che ci è dato. Bisogna lavorare per diventare comunicatori migliori, curare il nostro pensiero e i nostri mezzi per esprimerlo, curare le nostre parole, sceglierle accuratamente e dopo averci meditato. Citando Spiderman, un grande potere richiede una grande responsabilità. La libertà di pensiero e la libertà di parola sono due poteri immensi nelle nostre mani. Impariamo ad esserne responsabili.
Come ha scritto Primo Levi “Abbiamo una grande responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno”[10].

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.