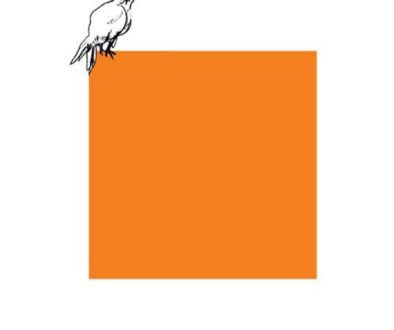Pubblicato per la prima volta il 26 giugno 2015
Da sempre i confini hanno segnato una demarcazione tra un territorio e un altro, tra il “mio” e il “tuo”. Tra ciò che è amico e ciò che rappresenta un nemico o una minaccia. Si sono fatte guerre per la difesa dei confini, per allargarli o restringerli. Li abbiamo incisi sulle cartine, sulle prime mappe, li abbiamo ridisegnati a tavolino, li abbiamo esasperati costruendo muri. Ma il confine non designa solo un limite territoriale, bensì mentale e ideologico. Entro i confini si radica e si potenzia la nostra identità. Entro i confini del mio paese è inscritta la mia storia. Entro i confini del mio corpo avverto di essere io e non un altro.
E l’identità, l’appartenenza, il sentirsi radicati alla propria terra, alla propria storia, alla storia dei nostri nonni, dei nostri padri, del nostro popolo non è negativo di per sé, anzi, contribuisce a dare un senso al nostro essere, al nostro esserci, per dirla con Heidegger. L’identità però, non deve diventare una prigione. E il confine non deve diventare barriera, muraglia insormontabile. L’identità può svilupparsi entro i confini di ciò che è considerato “il proprio” – il proprio paese, la propria lingua, la propria storia, personale ma anche collettiva del proprio popolo, la propria famiglia, la propria cultura, il proprio corpo, il proprio pensiero, la propria weltanschauung, le proprie tradizioni ecc. – ma allo stesso tempo la vera identità si sviluppa solo attraverso l’apertura all’altro e non ovattandosi e ripiegandosi su sé stessa, dato che così facendo si atrofizza e si appiattisce.
Filosoficamente parlando molti pensatori, fin dall’antichità, hanno riflettuto sulla questione dell’alterità e sono arrivati a scoprirla persino all’interno di noi stessi. Hanno intuito che l’estraneo fa parte di ciò che crediamo più nostro, l’improprio è già da fin sempre parte del proprio, il due è fin dall’origine implicato nell’uno, nel momento stesso in cui lo si pensa. La differenza è fin da sempre compresa nell’identità, nel momento stesso in cui provo pensarla. Già dire “io è uguale ad io” è ammettere una separazione. Pensare l’uno significa già renderlo due, perché lo pongo come oggetto. Per questo sia Platone nel Parmenide che Plotino ammettono che il principio unico non lo si può neanche nominare, altrimenti perderebbe la sua unicità e si sdoppierebbe. Lo si può “pensare” solo in forma negativa, dicendo cosa non è, affermando, ad esempio, che non è molteplice. Anche la fenomenologia ha intuito la forma di uno scarto, di una distanza che si va a insinuare proprio tra me e ciò che riteniamo più proprio, il corpo.
Husserl lo ha spiegato bene attraverso le pagine memorabili di Idee II dedicate al tatto, in quanto l’esperienza della mano sinistra che tocca la destra attesta la duplicità intrinseca al nostro corpo, che è soggetto, organo della percezione, senziente ma anche cosa fisica, materia percepita, oggetto sentito, toccato, visto. Quando tocco un tavolo la mia mano avverte la durezza del legno, il suo essere liscio, tutte le qualità appartenenti al tavolo che ha dunque come oggetto. Ma nello stesso tempo avverte su di sé sensazioni di caldo, o di freddo, e quindi diventa oggetto a sé stessa e non solo soggetto di percezione. Le mie mani che si toccano raddoppiano e rendono più complessa questa duplice esperienza in cui senziente e sentito diventano un intreccio, si avvolgono e si confondono senza però poter mai essere l’uno e l’altro simultaneamente: se pongo attenzione alla mano che tocca non posso nello stesso identico istante avvertire le sensazioni specifiche che avverte l’altra mano e viceversa, se pongo attenzione a quelle la mano che tocca sembra quasi essere la mano di qualcun altro. Eppure son entrambe mie. Toccato e toccante vivono entro uno stesso corpo che però si sdoppia, spalanca, accoglie e vive la differenza entro di sé facendosi da un lato corpo-oggetto, Kӧrper come lo chiama Husserl, cioè il corpo nella sua materialità e nella sua estensione di cosa fisica, oggetto tra gli oggetti e in quanto tale, oggetto di percezione per altri “io”, per altri soggetti, i quali a loro volta sono per me prima di tutto, degli altri corpi; dall’altro è invece corpo vivente e vissuto , corpo vivo, Leib.
I miei limiti, il “fin là” dei miei confini, degli angoli del mio corpo spalancano fin da subito un oltre che penetra entro di essi, che dunque si sfaldano, si sfrangiano, si espandono senza riuscire a contenere se non ospitandolo, questo stesso oltre che fin da sempre appartiene al “mio” corpo, e di conseguenza al mio essere:
“Già il “fin là” del corpo che mi è via via divenuto proprio, già queste mani che vedo e che tocco l’un l’altra, già questo corpo che tocca e che è toccato, sono proprio perciò caduti sempre “oltre” se stessi. In ciascuno di quei gesti, in ciascuna di quelle incerte tattiche d’appropriazione, la garanzia del “fin là” è sempre la promessa e la minaccia di un “oltre”, è sempre la trasgressione della soglia che il “fin là” sembrava avere attestato saldamente. Impossibile tracciare una soglia senza disegnare anche l’altro lato della soglia. Mi tocco, sono io che mi tocco e insieme sono io che sono toccato. E così, proprio in questo sfiorarsi delle mie mani, io mi sono già posto a distanza da me stesso. Il mio corpo è il mio corpo in modo tutt’altro che immediato e privo di distanza. Già la massima prossimità del tatto racchiude un ostacolo, una differenza. E a ben vedere è quell’ostacolo, quella differenza, che aprendosi si lascia valicare, che ribadendosi ci consente di riattraversarla, e di ripetere come una lenta e incerta litania che è la struttura stessa della nostra esperienza corporea: questo è il mio corpo, questo sono io. Il “mio” passa e ripassa per il “non-mio”. Senza differenza, nessuna identità”
(F. Leoni).
Tutto questa divagazione è utile per capire che persino noi stessi non siamo così ben definiti, neanche all’interno di quelli che consideriamo i nostri confini più saldi, sicuri, più propri appunto:
“Nel dire il “proprio”, la “proprietà”, ho già detto l’improprio come costitutivo del proprio, l’inappropriabile come segreto di ogni appropriazione. La differenza tra “io” e “il mio” corpo è questa differenza istitutiva di una vita che si rapporta a sé attraverso un vuoto centrale, un cedimento strutturale all’improprietà. Senza un’ombra che è quella della non-coincidenza, della dispersione, e in questo senso della morte, nessuna coincidenza di me vivente col mio corpo vissuto, cioè nessuna vita.”
(F. Leoni)
Proust, in una celebre espressione, ripresa da Deleuze, diceva “je est un autre”. Freud ha edificato gran parte della sua psicanalisi sul problema dell’altro dentro di sé, dell’inconscio come inquilino perturbante, sul fatto che “l’io non è padrone nemmeno a casa sua”. Jung, allievo eretico di Sigmund Freud, ha parlato usando termini che riecheggiano Dostoevskij, di “sottorreanei dell’anima”; di un’“ombra che segue sempre ognuno di noi”.
Insomma, l’identità non è mai così salda, l’altro lo ospitiamo già a casa nostra. E allora è solo cominciando a riconoscere l’altro in noi che possiamo accogliere l’altro da noi. Solo facendo i conti con la differenza, che fa parte prima di tutto di noi stessi, possiamo prendere atto di ciò che veramente siamo. E ammettendo questa differenza potremmo aprirci a tutte le altre differenze che provengono oltre i confini che ci siamo costruiti e confrontandoci con esse, dialogando con esse, mescolandoci con esse renderemo anche più forte la nostra stessa identità. Senza però che essa sfoci in pericolosi nazionalismi, autoritarismi, fascismi, prigioni mentali che anziché accogliere l’altro lo separano nettamente. L’identità che non si confronta resta cieca e vuota, l’identità che cela l’altro a sé stessa e che si chiude all’altro non cresce, non si fortifica, ma si annulla, si veste di voto identitarismo fasullo perché autoreferenziale, egocentrico, solipsistico. Perché si è trincerata in confini che la demarcano irrimediabilmente dal rapporto col mondo e con gli altri, da altre opinioni e punti di vista, da altre vite, altre culture, altre esistenze. Io non esisto senza l’altro. Le mie idee non sono davvero mie se non le metto a confronto con altre idee che magari sono opposte alle mie, ma nello stesso tempo le rendono davvero mie. Io sono così perché mi sento differente da qualcun altro, ma se questo qualcun altro non ci fosse cosa ne sarebbe di quel che chiamo “io”?
Paradossalmente, è proprio ciò che è altro da me che definisce i confini di ciò che considero mio, di ciò che chiamo io, per differenziarlo da ciò che non è me, per differenziarmi dal tu. Però tu sei fondamentale. Così come lo è il noi, che definisce un gruppo, una collettività, un popolo ecc., ma a sua volta non deve diventare un noi separato dal resto del mondo, ma un noi pronto ad accogliere i loro e i voi. Non deve sfociare nella minaccia sempre incombente di quel noi che sancisce la purezza e la superiorità della propria razza che schiaccia e annienta quelle ritenute inferiori. Il noi di un’ideologia che diventa pensiero unico e soffoca i pensieri alternativi. Non deve diventare il noi di un popolo che si erge a popolo eletto a scapito delle minoranze. Non deve diventare il noi che innalza barriere a coloro che arrivano, il noi che si difende dalla minaccia del migrante, del diverso, del clandestino.
I confini devono farsi permeabili e non farsi frontiere in cui vi è scritto: vietato l’accesso. I confini servono a conservare la bellezza e l’unicità di ciascun paese e di ciascuna storia che appunto è unica e insostituibile. Ma sono fatti anche per essere scavalcati, oltrepassati, aprendosi a tutto il nuovo oltre di essi., aprendosi alle altre storia, alle altre bellezze, alle altre narrazioni, agli altri volti e agli altri costumi. La storia, così come la cultura e la bellezza, sono nate per incrociarsi, per toccarsi, per contaminarsi laddove è possibile, per arricchirsi vicendevolmente, pur mantenendo ciascuna la propria specificità, il proprio segno particolare.
Tra l’altro è contraddittorio pensare che difendiamo tanto il “nostro” dagli altri che “lo minacciano” e non ci rendiamo conto che semmai è stato e continua ad essere il processo inarrestabile della globalizzazione a cancellare qualsiasi specificità, qualsiasi identità, qualsiasi unicità. Innalziamo confini sempre più rigidi per separarci dall’”aggressione” del diverso e non ci rendiamo conto che la globalizzazione ha già de-territorializzato e cancellato quasi tutti questi confini e non grazie a un processo, positivo di vero e reale interculturalismo, di reale integrazione, ma perché ha teso ad anonimizzare tutto, a conformare tutto rendendo ogni angolo di mondo quasi omogeneo a un altro. Ad annullare le differenze, appunto. E nello stesso tempo, quindi, anche le identità. Solo riconoscendo e guardando alla differenza come un tesoro, un valore, una fonte di ricchezza potremmo davvero mescolarci, senza smarrire ciò che siamo. solo aprendo i confini a chi arriva, col suo carico di storia, di cultura, di diversità preziosa, e non nascondendoci dietro di essi per paura di questa diversità, potremmo crescere come popolo e come singoli individui.
Come ha scritto in un bell’articolo di Repubblica del 23 giugno, Massimo Recalcati,
“Se la vita, non sa scavalcare il regime ristretto della propria identità, se non sa muoversi dal proprio bisogno di appartenenza verso una contaminazione con l’alterità dell’Altro, fatalmente stagna, appassisce, non può che ripetere sterilmente sé stessa. […] La vita, come insegna del resto anche Spinoza, può conservarsi solo espandendosi, oltrepassando il confine che gli è stato necessario ala sua istituzione. […] La vita che si ammala è quella che resta troppo attaccata a sé stessa, che resta vittima della tendenza omeostatica alla propria conservazione, è la vita che ingessa, cementifica, rafforza unilateralmente il proprio confine narcisistico. Se il confine serve a rendere la vita propria, questo confine, per non diventare soffocante, deve, come si esprimeva Bion, diventare <poroso>, permeabile, luogo di transito. Se invece il confine assume la forma della barriera, della dogana inflessibile, se diviene presidio, luogo impossibile da valicare atrofizza e non espande la vita. Venendo meno l’ossigeno indispensabile dell’alterità, la vita si ammala e declina. La necessità del confine va quindi unità con la necessità del movimento e del transito al di là del confine.”
Immagine Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (dettaglio) da Wikimedia Commons

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.