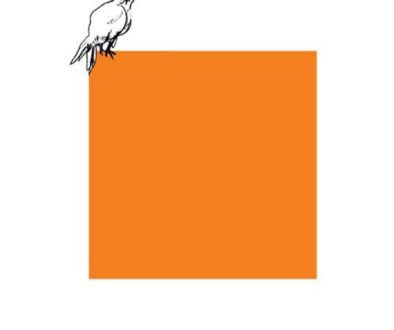Pubblicato per la prima volta il 25 luglio 2018
Mendicanti, venditori ambulanti, clochard, rom e sinti, migranti, bancarelle abusive, “tossici”, centri sociali, murales e graffiti, manifesti abusivi… sono queste le vittime contro cui si scagliano i poteri istituzionali, l’ideologia del decoro e del bello, della purificazione che maschera il suo intento politico di “eliminazione” dell’alterità non conforme e non normata, dell’alterità inutile, che non produce né spende.
Un paradigma immunitario e stigmatizzante che si auto-giustifica e che viene accettato (addirittura conclamato e richiesto) e interiorizzato per soddisfare il bisogno di protezione dei cittadini dalla sporcizia, dall’informe, dall’indecoroso, dalla potenziale pericolosità di soggetti non uniformati, di protezione dalla loro inciviltà. Si dichiara guerra alla povertà sradicandola dalla vista dei cittadini e dei turisti “per bene” e confinandola nelle aree periferiche, ai margini delle città. In questa operazione che punta a medicalizzare la società e lo spazio urbano dai danni arrecati dai “parassiti” che la deturpano con la loro mera presenza non vi è nessuno scopo di addentrarsi dentro la complessità del reale, né di scavare e provare ad affrontare il problema politico e sociale della marginalità sociale, del disagio sociale, della povertà e dell’indigenza di alcuni soggetti; non si vuole certo trovare soluzioni o per lo meno tentare di affrontare la complessa questione dell’integrazione, del sostegno, dell’assistenza sociale agli ultimi della società, ai più fragili e deboli, ai più disagiati, a chi è costretto a rovistare nei cassonetti alla ricerca di un pezzo di pane o, per scelta o necessità dorme per strada.
Il problema non è far fronte al perché, il per come queste persone finiscano ai margini della società, o diventino il margine stesso, gli outsiders,che, per dirla con Deleuze e Guattari, più che stare ai bordi sono essi stessi il bordo, e il come provare a trovare soluzioni politiche e sociali a determinate condizioni di emarginazione, no, il problema è l’immagine che essi danno della città, è la loro presenza fisica che infastidisce, è il loro degrado visivo, la loro sporcizia, non quel che si nasconde dietro. La loro esistenza turba in quanto è visibile.
“Le soggettività che vanno a costituire le cosiddette marginalità sociali sono parte di un sistema sociale ed economico che tuttavia le rifiuta, poiché cerca di espellere ciò che non riesce a integrare, ciò che non è speculare a una certa condotta disciplinare […]. La percezione del degrado diventa dunque problema per un ceto medio preoccupato del comportamento di coloro che non sono integrati nel sistema […]. Foucault sosteneva che la nostra è una società di normalizzazione, in cui se da un lato il diritto viene organizzato intorno alla sovranità, il potere si esercita anche attraverso una meccanica delle coercizioni delle discipline, e che laddove questi due aspetti si incontrano, viene operata una medicalizzazione generale del comportamento, delle condotte, dei discorsi e dei desideri”[1].
Si tratta perciò di risolvere il problema estetico agendo a un livello percettivo e non sociale, limitandosi, di fatto, a espellere, respingere al di fuori dai centri cittadini (ma anche dai quartieri popolari che si vanno gentrificando), confinandole ai bordi, nelle periferie tutte quelle soggettività scomode, tutte quelle soggettività emanatrici di “degrado” e immagine vivente di disformità e indisciplina. La stigmatizzazione stessa dei soggetti marginalizzati e la loro esclusione sociale è “motivata con la non corrispondenza degli stili di vita alle norme morali e civili della città ideale nordeuropea: pulita, silenziosa, agiata. I mendicanti, i rovistatori di cassonetti, i venditori ambulanti turbano l’occhio del passante, poiché essi sono la dimostrazione del sogno biopolitico infranto. L’ideologia del decoro diventa strumento per stigmatizzarli in quanto trasgressori della norma […]. Essi non solo rovistano nella spazzatura, ma sono spazzatura. Di questo li si accusa implicitamente, di essere il rifiuto improduttivo della società”[2].
I cittadini per bene possono allora dormire sonni tranquilli, protetti dai sindaci che si fanno immortalare accanto a una montagna di oggetti requisiti dai venditori ambulanti, dagli angeli del bello che cancellano le scritte sui muri (spesso senza rendersi conto di cancellare una memoria collettiva, un segno che si è fatto voce di una comunità, un segno che è diventato simbolo di una storia da raccontare e da tenere viva), dai decreti – come il decreto del 2017 sulle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, ma meglio noto come decreto Minniti – che, in nome della sicurezza, prendono misure e provvedimenti particolarmente restrittivi delle libertà personali e di movimento o che finiscono di applicare il Daspo urbano non solo durante le manifestazioni sportive, ma per qualsiasi comportamento considerato “non ammissibile”.
Dichiarazioni dello stato di emergenza, militari davanti ai monumenti, provvedimenti locali che eliminano le panchine dai giardini pubblici per evitare che ci vada a dormire il clochard di turno, che tolgono esercizi “etnici” di somministrazione di alimenti o bevande dai centri storici, che vietano di “bivaccare” nelle piazze, attaccando così uno dei pochi spazi all’aperto di convivialità, socialità e aggregazione degli studenti. Sono solo alcune delle misure adottate per garantire la tutela e la protezione dei cittadini e del territorio urbano. Spesso gli stessi luoghi di “appartenenza” della comunità, di ritrovo, o luoghi storici, dall’alto valore storico, culturale e anche simbolico, vengono svenduti, espropriati alle comunità, a volte addirittura affittati a grandi lobby e multinazionali, come accadde nel caso di Ponte Vecchio a Firenze.
E in una città-vetrina, una città mercificata, aziendalizzata non c’è spazio per le fasce deboli, che devono esser tolte dalla vista, devono esistere altrove, lontani dai luoghi in cui circola denaro e flusso di persone che spendono. In nome del decoro e della sicurezza, parole chiave delle città neoliberali, si è imposto uno strano diritto, lo ius excludendi alios, come lo ha denominato Agostini, ovvero il diritto di escludere l’altro. Questo lo si vede a tutti i livelli, sia a livello urbano che, facendo forse un salto un po’ troppo ampio, a livello europeo, con la creazione di confini, barriere, fili spinati, ministri che lasciano navi cariche di persone, già martoriate dal viaggio e dalle vicende di vita personali, nel limbo del mare, “terra” di nessuno finché qualcuno non si decida a farsi carico di queste persone o di almeno una parte di esse. “Di fatto […] la prevenzione sociale più che generare politiche sociali inclusive ha prodotto azioni di controllo del territorio tendenzialmente escludenti, repressive, fondate sulla paura e legittimate sempre da essa. Secondo Pitch: «Puntare sulla sicurezza ha voluto dire non solo legittimare ma fomentare la paura e utilizzarla in funzione di consenso»”[3].
Si cavalca il sentimento della paura, il senso comune, la non corrispondenza tra percezione e fatticità dei dati reali, come rivela ad esempio la relazione annuale di Boeri che mette in evidenza i (pre)giudizi che nutrono gli italiani su temi come l’aumento o la diminuzione dei reati o quello dell’immigrazione, mostrando il divario che sussiste tra la loro percezione e i dati reali: ad esempio “l’84% degli italiani, stando all’ultima rilevazione Ipsos Mori, pensa che il numero di omicidi sia cresciuto o certamente non diminuito. Il dato oggettivo rappresenta una diversa realtà; mostra infatti che gli omicidi nello stesso periodo si sono ridotti del 39 %. […] Ciò di cui parliamo qui sono propriamente delle “distorsioni” (bias), e sono grandemente diffusi […], proprio perché hanno a che fare con i nostri processi cognitivi. Riguardano principalmente temi “caldi” mediaticamente, come il suicidio, i rischi per la salute, le credenze religiose, la corruzione, l’immigrazione e altri, perché in questi casi l’esposizione mediatica rende più vivido il ricordo e quindi più veloce la sua disponibilità alla memoria che a sua volta ci porta, inconsciamente, a sovrastimarne il peso nella nostra personale ricostruzione del fenomeno. È importante sottolineare questa differenza tra “errori” e “distorsioni”, perché, a differenza dei primi, queste ultime tendono a essere sistematiche, vanno tutte nella stessa direzione; […] E se queste distorsioni sono sistematiche, vuol dire che sono prevedibili e quindi utilizzabili, sfruttabili, cavalcabili. Un esempio istruttivo del disallineamento che si può produrre tra dati reali e percezioni distorte e dell’utilizzo politico che di quest’ultime può essere fatto, ci è stato dato nei giorni scorsi dalla polemica tra il presidente dell’Inps, Tito Boeri e il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Boeri afferma nella sua relazione annuale che alla luce dei dati sulla struttura del nostro mercato del lavoro e delle dinamiche demografiche, il sistema pensionistico italiano rischia di andare in crisi senza l’apporto di nuovi lavoratori immigrati. Salvini gli risponde accusandolo di vivere su Marte. I dati di Boeri sono oggettivi e corretti, ma secondo la percezione dei cittadini e non solo di quelli che votano Salvini, di immigrati ce ne sono già anche troppi: gli ultimi dati Eurispes ci dicono che la maggioranza degli italiani pensa che siano tra il 16 e il 25% della popolazione totale, mentre in realtà sono l’8 per cento”[4].
Dunque è proprio giocando sulle distorsioni della percezione, del senso comune, del pregiudizio delle persone e cavalcando le loro paure che si innesca l’ingranaggio mistificatorio della realtà, mistificazione che si porta dietro la costruzione di nuovi nemici, di alterità pericolose che minacciano il benessere dei cittadini “legittimi” e attentano al decoro e alla civiltà delle loro città. In questo modo le propagande populiste hanno così presa, perché esasperano gli istinti delle persone, fanno della loro emotività il proprio programma politico, stigmatizzando soggetti non inseriti nel sistema perché non funzionali ad esso e additandoli come la causa dei problemi degli italiani e dei “loro” spazi, di vita, di lavoro, privati e pubblici. Tuttavia, anche misure come quelle relative alla sbandierata protezione dei cittadini e alla tutela estetica e purificatoria del territorio nascondono spesso un intento politico ben più profondo della mera lotta al disordine pubblico e al degrado, che spesso, più che tutelare i cittadini dalla minaccia del non-conforme, cercano di preservare o incentivare possibilità di afflussi di denaro nei propri centri cittadini:
“Lo spettro della devianza e della paura del diverso è agitato come strumento per imporre una normazione fittiziamente neutrale […]. La necessità di colpire quei soggetti deviati perché stigmatizzati come pericolo per la pace sociale non di rado sottende a una tutela degli investitori immobiliari e dei flussi economici e turistici. La trasformazione dei centri storici in quartieri-vetrina privi di abitanti ma perfetti per il turismo e lo shopping, sono parte di un progetto di trasformazione della città, che è supportato e agevolato da queste misure e dal «sistema dei media […] interessato all’immediato riscontro che deriva dal cavalcare ondate di panico» (Pitch 2013, p. 13). Il tentativo delle élite di dare al mondo una sua giusta forma, di decidere quali soggettività sono considerate accettabili, rappresentabili e di conseguenza quali non lo sono, sembra essere una conseguenza strutturale dell’organizzazione sociale nella società capitalista”[5].
Nelle città neo-liberali lo stato sociale diventa lo “stato penale” (come lo hanno definito i compagni del Cpa), che adotta misure e decreti di controllo sul territorio sempre più escludenti, militareschi e invasivi. È già a partire dagli anni Novanta che comincia a emergere l’idea della necessità, da parte degli organi di governo delle città, di affrontare il sempre più dilagante e pervasivo sentimento di insicurezza e paura attraverso logiche e politiche locali che andassero a colpire le “inciviltà urbane”.
Negli anni 2000 questa mania del controllo e della tutela dei cittadini – o meglio della loro percezione, perché spesso il sentimento e la percezione di insicurezza non corrisponde alla realtà dei fatti – viene ancor più esasperata: “Nella seconda metà degli anni 2000 in diversi paesi europei vengono proposti nuovi decreti che limitano i comportanti considerati «incivili» nelle città, delimitano spesso questi regolamenti esclusivamente alle zone turistiche e ai centri storici. […] A partire dal 2008 anche in Italia la normativa in materia di sicurezza cambia sensibilmente[6] dando ai sindaci nuovi poteri come ufficiali del governo a cui vengono delegate le «politiche integrate di sicurezza»”[7].
Come ha sottolineato Foucault a caratterizzare la “società disciplinare” sono procedure di controllo, correzione, sorveglianza che, insieme a pratiche discorsive, vanno a performare le soggettività, a creare norme cui queste devono corrispondere e che esse interiorizzano, incasellate in strutture orientate alle necessità del mercato e volte alla normalizzazione della devianza, dell’ab-norme. Ad essere interiorizzati e reiterati dalla maggior parte della popolazione (e che quindi non richiedono neanche una particolare imposizione o coercizione da parte del potere) sono quei dispositivi di cui ha parlato anche Agamben, ovvero “qualunque cosa abbia la capacità di catturare, orientare, determinare, modellare e controllare le condotte, i discorsi e le opinioni degli esseri viventi”[8].
La biopolitica “investendo i processi di insieme che sono specifici della vita, come la nascita, la morte, la produzione e così via”[9] ha trovato come ulteriore ambito di intervento quello della relazione tra umani e ambiente, habitat: “nella città è facile ritrovare tutta una serie di meccanismi disciplinari: suddivisione della popolazione, sottomissione degli individui alla visibilità, normalizzazione dei comportamenti. Si ha una specie di controllo poliziesco spontaneo esercitato anche attraverso la stessa posizione spaziale della città”[10]. Eppure, nonostante il tentativo da parte del potere biopolitico di assorbire, immunizzare, medicalizzare la devianza, la non-conformità, l’a-normale, l’informe inteso nel senso batailliano del termine (che ne fa un vero e proprio manifesto destrutturante, “una parola che serve a declassare”[11] la forma ideale, l’eidos, per svelare gli aspetti più bassi e appunto, informi, del reale), continua a permanere nella società, a permanere come residuo, come scarto, come incarnazione del fallimento del sogno biopolitico.
In questo esercizio di un potere disciplinare e regolatore di norme e correttore di comportamenti, lo stato, dacché si propone come garante della sicurezza dei cittadini e dell’ordine, è obbligato a intervenire in qualsiasi ambito, così che spesso lo stato assume i connotati dello stato d’eccezione, seguendo l’accezione e l’articolazione che Giorgio Agamben ha fornito di questo concetto. “Lo stato democratico si trasforma così in uno «stato di eccezione», inteso come superamento della soglia oltre la quale vengono meno le tradizionali differenze tra democrazia, assolutismo e dittatura”[12].
In questo controllo dall’alto di ciò che è spazio pubblico e in questo autoritarismo verticale nelle scelte che riguardano la vita in comune, e nell’interiorizzazione sempre meno critica e consapevole di norme, discipline e dispositivi, assistiamo a una massiccia erosione della partecipazione pubblica alle decisioni che riguardano gli spazi, l’ambiente, il territorio che viviamo. Le decisioni calano dall’alto e per lo più assistiamo con un senso di semi-impotenza al consumo di suolo, alla privatizzazione e all’espropriazione di luoghi pubblici, alla loro “brandizzazione”, alla loro mercificazione, alla loro militarizzazione, allo svuotamento e all’abbandono dei centri storici, all’espulsione delle soggettività “illegittime” dai centri storici e da molti degli stessi quartieri popolari da cui provengono con conseguente gentrificazione di questi ultimi, all’impatto ambientale e sociale che determinate scelte infrastrutturali comportano.
Come ha spiegato Riccardo Chesta, l’Italia si muove infatti in controtendenza rispetto ad altri paesi europei (come ad esempio la Francia, la Germania, la Spagna o i paesi del nord Europa) che applicano, nelle scelte riguardanti il territorio, un principio di decisionalità partecipativa, una “democrazia della prossimità” che mira al coinvolgimento di vari attori, dalle istituzioni, alle amministrazioni e ai vari enti e associazioni locali, fino alla cittadinanza, considerata anch’essa come portatrice di interessi e di un proprio ruolo, una propria voce in un ambito, come quello della gestione degli spazi urbani, che la riguarda da vicino. Ad esempio in Francia la “Loi Barnier” (legge n° 95-101 del 1995) introduce nella sua legislazione, come si legge al titolo primo, disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e delle associazioni in materia di ambiente, che instaurano la “Commission Nationale du Débat Public”, strumento fondamentale di confronto e dialogo con i territori e le varie comunità coinvolte nella proposta di interventi relativi alla gestione del territorio, alla realizzazione di piani infrastrutturali e all’impatto ambientale e socio-economico che questi possono avere.
In Italia invece, dal 2001 si procede in parte nella direzione opposta al modello della “democrazia di prossimità”, al modello partecipativo, bensì in quella della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure con cui vengono presentati i progetti relativi alla gestione territoriale, su cui non vige più neanche l’obbligo di valutazione ambientale. Le grandi opere, i grandi interventi infrastrutturali vengono presentati, venduti a stampa e opinione pubblica come grandi opere di ammodernamento, di innovazione, facendo così passare chiunque, anche dall’alto di un parere esperto in materia, si ponga contro questi progetti, come un conservatore, un demolitore che non riesce a guardare al futuro e al progresso.
È questa cultura egemonica modernista e presentata come ineluttabile, che per altro non tiene conto né dell’impatto ambientale né di quello sociale, che accompagna tutte le grandi opere, intorno alle quali si crea, il più delle volte, conflittualità sociale, come si può ben evincere dalla lotta che porta avanti il movimento No Tav contro l’alta velocità Torino-Lione o dal movimento di protesta nato contro l’Expo di Milano nel 2015. Movimenti come quello no Tav sono sacche di resistenza di fronte all’usurpazione del territorio; sono focolai di rivendicazione di un’appartenenza al territorio, di difesa e tutela dell’ambiente.
Come ha ben spiegato Lorenzo Zamponi, per lo più si tratta di forme di resistenza e di reazione a politiche neo-liberali auto-organizzate e sviluppatesi in maniera spontanea, quasi istintiva che portano avanti un tipo di azione concreta, diretta, immediatamente visibile e di immediato impatto. Non hanno un’organizzazione partitica e strutturata ma le loro azioni sul territorio sono tangibili, evidenti, fanno politica pur non associandosi – per lo meno a livello esplicito – a nessun partito e spesso non palesando, almeno inizialmente, una ideologia politica, benché abbiano una chiara visione politica. Portano avanti azioni sociali dirette – spesso chiamate mutualismo, solidarietà attiva, welfare alternativo – che non hanno al centro una rivendicazione specifica ma puntano a costruire direttamente nella realtà, con la propria azione, un modello diverso.
Il cambiamento sta nell’azione stessa di questi movimenti: nell’occupazione di case popolari, nelle azioni di ripristino dell’acqua e di corrente a chi non ha potuto pagare le bollette, nell’occupazione di fabbriche, nella campagne di rivendicazione agricola, nelle esperienze di autogestione, nella riqualificazione dei luoghi pubblici, nella creazione di tende e mense popolari, di atelier per artigiani disoccupati, di consultori, di sportelli di assistenza per i migranti, di biblioteche popolari, nell’occupazione di terreni lasciati in stato di abbandono per creare orti popolari e mille altre azioni che incidono immediatamente sulla realtà, che generano una parte del cambiamento.
In un momento storico che ha subito e continua a subire gli effetti della crisi economica, della crisi sociale, della crisi culturale e della crisi della rappresentanza politica; in un momento storico in cui i legami e le relazioni sociali si stanno sempre più frammentando, in cui è sempre più accentuata la disgregazione sociale, è aumentato l’impoverimento e con esso il senso di solitudine, disagio, diffidenza, umiliazione, mancanza di fiducia nella politica e nell’idea stessa di partecipazione, di perdita del senso di collettività e di “essere in comune”; insomma, in questo panorama poco confortante, esistono dei processi dal basso che Zamponi chiama processi di “rimaterializzazione”, nel senso di costruzione di qualcosa di concreto, che impatta, pragmaticamente sulla realtà, e di “riterritorializzazione”, con cui si “occupa” un territorio, anche una sua piccola parte, per produrre qualcosa che può essere di aiuto alla comunità o ad alcune delle sue fasce più deboli, con lo scopo di ritrovare e gestire il territorio in maniera alternativa, diventando punto di riferimento per il proprio quartiere e per la propria comunità.
Se gli effetti positivi di simili movimenti e azioni dal basso che riconfigurano al loro interno spazi di solidarietà e mutualismo sono molti – tra cui anche quello di favorire un processo di ripoliticizzazione sia degli spazi in cui intervengono che dei soggetti coinvolti nell’azione sociale, a cui pian piano, proprio attraverso l’agire in comune verso una determinata direzione e in nome di determinati ideali di giustizia sociale, può essere trasmessa una certa visione politica senza che ciò venga percepito come un modo per reclutare o ideologizzare – non mancano però anche delle potenziali derive negative. Tra queste vi è il rischio che questi soggetti diventino attori inconsapevoli del fenomeno di gentrificazione: il recupero dello spazio abbandonato e autogestito, ad esempio, potrebbe imporre di alzare i prezzi o di indurre a una graduale omologazione ai meccanismi che regolano e muovono il mercato. C’è insomma il rischio di spoliticizzazione e di essere risucchiati nella logica dell’aziendalizzazione, del business e del profitto.
Ad ogni modo, queste spinte dal basso sono parte di un processo di soggettivazione, intesa nel senso foucaultiano di costituzione del soggetto come “effetto del potere […] come elemento di raccordo del potere”[13], ovvero non solo come prodotto del potere ma anche come risposta e reazione alle tecnologie del potere: “è possibile affermare che – alla comprovata tecnicizzazione della vita politica pubblica, ai linguaggi esclusivi della burocrazia e dell’amministrazione, al potere centralizzato […] – si oppone una potenza diffusa […] che ricostruisce la propria identità fuori dai binarismi secolari […] contro le strutture dell’ordine costituito. Citando Maffesoli «Rendendo asettica la vita quotidiana, preparano il terreno all’effervescenza sociale»”[14].
Immagine di T. Moreillon (dettaglio) da flickr.com
-
C. Pisanello, In nome del decoro. Dispositivi estetici e politiche securitarie, Ombre Corte, Verona 2017, p. 44 ↑
-
Ivi, p. 60 ↑
-
Ivi, p. 41 ↑
-
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml?uuid=AEQa67IF ↑
-
C. Pisanello, op. cit., pp. 54-55 ↑
-
Si tratta del decreto legge 92/2008, poi convertito in legge 125/2008 ↑
-
C. Pisanello, op. cit., p. 41 ↑
-
G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, p. 21 ↑
-
M. Foucault, Archivio Foucault 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, Feltrinelli, Milano 1997, p. 209 ↑
-
Ivi, p. 217 ↑
-
G. Bataille, Documents, Dedalo, Bari 1974, p. 195 ↑
-
C. Pisanello, op cit., p. 54 ↑
-
M. Foucault, Bisogna difendere la società, Feltrinelli, Milano 2009, p. 33 ↑
-
C. Pisanello, op. cit., p. 29 ↑

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.