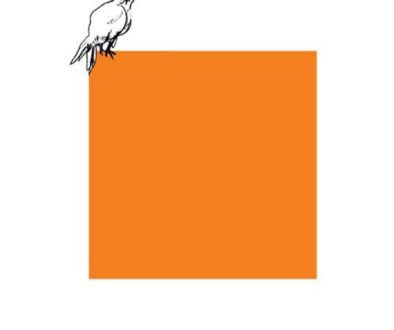Scienza/politica: crisi di un’economia
Rimane da chiedersi perché questo genere di testi sia così frequentato, perché praticamente venga scelto così facilmente da quelli che vogliono farsi sentire e perché continui a incontrare un riscontro così diffuso, anche di pubblico. La prima risposta sta certamente nella sua forma stessa, una forma di rapida – rapidissima, per chi sottoscrive e basta – formulazione e a scarsa autorialità, che pone chi lancia il messaggio al riparo da feedback negativi che possano costringere a loro volta a perdere tempo formulando risposte articolate (un dato da tenere in considerazione nell’attuale panorama socioeconomico), ma che al tempo stesso consente un massimo di concentrazione di “capitale morale”, e quindi di persuasività. È in sostanza un buon investimento, massima resa e minima spesa.
È un atto politico, ma non richiede in linea di principio a nessuno, salvo eccezioni limitate, una militanza pregressa o un’autorevolezza collegata alla lunga esperienza o all’onere di una carica in un soggetto politico collettivo (nemmeno nel caso dei già citati appelli per la sedicente unità della sinistra); tutte cose dispendiose a livello di tempo e che rischiano di intaccare la valorizzazione di un “capitale morale” che nel caso dell’intellettualità e della scienza – riflettendo in ciò un orientamento culturale complessivo di stampo neopositivistico – è tanto più assicurata quanto più ci si fa all’apparenza portatori di un sapere politicamente “neutro”.
Queste ultime considerazioni ci portano ad un secondo elemento, vale a dire il fatto che questi testi sono prodotti e diffusi in un contesto post-postmoderno in cui scienza e politica non riescono a trovare un modo ordinato di rapportarsi.
Le crisi gemelle delle grandi famiglie politiche europee e delle ideologie che le supportavano, travolte dalla fine della Guerra fredda e quindi della reciproca contrapposizione, dalle loro contraddizioni interne a fronte di un mondo culturale trasformato, dai colpi delle nuove teorie critiche della realtà, dall’appiattimento sul paradigma socioeconomico neoconservatore, o dalla cattiva gestione di una crescita che sembrava illimitata e dal malaffare, ma anche la fine dei grandi movimenti di contestazione, progressivamente riassorbiti e commercializzati, privati di ragioni di esistere o colpiti dalla furia della vendetta padronale anni ’80 hanno senza dubbio privato di forza – simbolica e non – la politica, intesa come piano di confronto di progetti di vita comune e di gestione/trasformazione storica del reale. Una disfunzione a lungo non notata, o addirittura assecondata e mitizzata, in quanto alla fin fine consonante con un ethos per il quale la risposta a problemi e bisogni dell’individuo va trovata nell’individuo stesso, che deve rimboccarsi le maniche e farsi artefice della propria fortuna, e non in una pratica collettiva: la politica è un fastidio per chi vuole fare i propri affari, se proprio non la si può eliminare che si occupi di garantire le condizioni migliori per la felicità di questi ultimi!
Ma gran parte di ciò che è politica si può “eliminare”, trasformando le scelte in più campi possibili in questioni tecniche di regolazione e ottimizzazione; una scelta che ha il vantaggio di poter fare a meno tanto del confronto tra progetti quanto del consenso, e di poter includere come parametro supremo proprio la variabile capitalistica senza apparire di parte. Un’ideologia, ma mascherata come sono invisibilizzati gli assunti su cui si basa, che dipinge chi non la condivide non come un avversario politico ma come un pazzo o uno stolto (dato l’ottimo, cos’è chi vuole qualcosa di diverso, ovvero di “meno”?); economica nel doppio senso[1] di economizzante (scarsità di risorse) e di tecno-economica (necessità della produzione). Un ideale di vita buona è sostituito dall’imperativo dell’ottimo, del “maggior possibile”: l’oggetto trionfa sul soggetto, definitivamente alienato. Un’ideologia, va detto, che si accorda benissimo, e alimenta, quella logica di rinomanza individuale di cui abbiamo parlato più sopra.
I saperi, specialmente quelli sociali e tecno-scientifici, si trovano così cooptati nella struttura di una antipolitica che si fa gestione del reale, riorientati teleologicamente verso l’accumulazione capitalistica. Si può obiettare che esistono e hanno successo partiti che fanno della cosiddetta “antiscienza” la loro bandiera, ma è un’obiezione superficiale, a cui è semplice rispondere: quando la presunta “antiscienza” in politica non è mera malafede acchiappaconsensi è postura estetica di predilezione per uno o un altro strumento tecnico, ma il dogma dell’ottimizzazione non è toccato (neppure da forze “ecologiste”, che dove hanno successo implementano non il primitivismo di facciata con cui si fanno campagna elettorale ma forme di capitalismo verde).
Questo sul piano ideale: nella pratica per una macchina politica debole, e che non può rafforzarsi se non vuole iniziare ad assomigliare ai suoi precedenti “ideologici”, anche quello dell’ottimizzazione e dell’armonizzazione degli interessi privati è un compito impari, che riesce a conseguire solo parzialmente e contraddittoriamente.
Nasce da questi presupposti la contrapposizione spuria cui assistiamo nella quotidianità: da un lato una politica debole che si è mutilata di ogni alternativa, dall’altro saperi informati (e deformati) dal dogma dell’ottimizzazione. La battaglia è combattuta dal lato politico con l’appello alla legittimazione democratica o agli arcani del potere, pretesa ridicola in una situazione in cui la politica è democraticamente discutibile e totalmente “smitizzata”, dal lato del sapere con la manifesta intolleranza verso qualunque cosa si ostini a non voler andare nella direzione indicata dai “fatti” (interpretati nell’unico modo ottimizzante, e quindi possibile) e dai “modelli”, che indicano senza appello il buono e il vero e quindi il giusto. In entrambi i casi con un appello al consenso diretto, ad una investitura: “vuoi essere governato dagli scienziati o dai rappresentanti che hai eletto?” e “vuoi essere zittito dai professoroni o vuoi dire la tua?” vs. “stai dalla parte di chi stimiamo, noi che siamo studiosi prestigiosi, o con quelli che non si meritano la nostra stima?” e “affidi il tuo benessere e la tua vita a bagginate prive di fondamento o segui chi ne sa di più?”.
Ecco perché l’appello continua una carriera di successo, anche se progressivamente meno brillante, come una rockstar in crisi che si riduca a comparire nelle pubblicità e a sagre di paese.
Ma un’alternativa, forse, c’è.
Una politica che non abbia paura di avere idee salde e prendere decisioni schierate, ideologiche, e quindi forze politiche che capiscano che c’è vita oltre un modello di ottimizzazione liberista che non è più in grado (se mai lo è stato) di gestire la complessità del presente. Saperi che non puntino a sostituirsi alla ricerca della vita buona, ma che si aprano alla collaborazione franca ad un progetto di società.
Per coloro che in filosofia politica seguono fino in fondo una linea kojèviana, il tiranno-filosofo dello stato omogeneo, capace di far trionfare l’assoluto, è un termine ultimo magari sgradevole ma inevitabile. Al saggio non rimarrebbe che la contrapposizione ironica all’ultimo potere.
Per coloro che seguono il grande amico-avversario di Kojève, Leo Strauss, uomo radicalmente conservatore ma il cui pensiero ha validità generale, il filosofo si porrà sempre contro la città e le opinioni e i pregiudizi che la governano, ed è meglio che trovi un modo per praticare la propria ricerca del vero il più libero possibile dagli infingimenti e dalle minacce del potere. Certo, criticando le leggi e i miti pubblici quando occorre, ma con prudenza; è infatti proprio la città a dargli la possibilità di filosofare o a togliergliela radicalmente.
Al tempo stesso, il tiranno che si presentasse come filosofo, come l’ultimo tiranno di Kojève, pretendendo di operare solo contro le “false dottrine” a favore della propria, quella “vera”, non solo rappresenterebbe l’estinzione di ciò che di umano c’è nell’uomo, ma anche della filosofia stessa. Il tiranno non può sfuggire a questo paradosso; la tirannia buona, filosofica, non può esistere.
Il filosofo deve educare i propri discepoli, col rischio di essere condannato dalla città come sovvertitore, questa è l’influenza cui può ragionevolmente aspirare.
Pur non volendoci schierare in questo dibattito un po’ polveroso è forse proprio quello di una comunità educativa il modello che si può proporre come alternativa per saperi che abbiamo descritto essere bloccati in un meccanismo nefando e sterile, a vantaggio dei pochi. Saper ragionare assieme, assieme cercare, con l’umiltà di ammettere che ciò che si trova anche collaborando possa non rappresentare per tutti una risposta; al tempo stesso collaborando alla ricerca del vero e della vita buona, senza equivalenze affrettate, senza imposizioni o tentativi di coartare l’una o l’altra.
-
Sono debitore a The Livelihood of man di Polanyi per la trattazione dei due sensi di economico. ↑
Immagine: Matthias Grünewald, Tentazione di S. Antonio (dettaglio)

Nato a Bozen/Bolzano, vivo fuori Provincia Autonoma da un decennio, ultimamente a Torino. Laureato in Storia all’Università di Pisa, attualmente studio Antropologia Culturale ed Etnologia all’Università degli Studi di Torino. Mi interesso di epistemologia delle scienze sociali, filosofia politica e del diritto, antropologia culturale e storia contemporanea. Nel tempo libero coltivo la mia passione per l’animazione, i fumetti ed il vino.