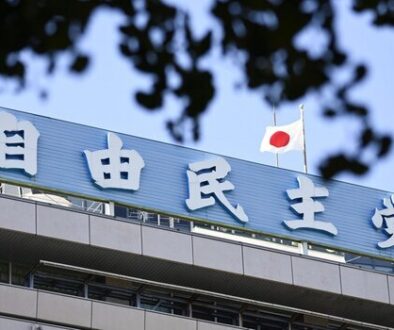Ad inizio del mese è stato presentato il rapporto dell’inchiesta Agro Pontino: un’impresa di lavoro e libertà. Tutti i numeri e le (vere) storie di un’integrazione riuscita promosso dall’europarlamentare di Fratelli D’Italia Nicola Procaccini. Un rapporto corredato da un video, che parte dalle bonifiche di mussoliniana memoria per arrivare fino ai giorni nostri, mostrando come i lavoratori agricoli indiani di oggi siano gli eredi “dei pioneri” dell’Agro Pontino, portatori di un modello straordinario di produttività, una bella storia di lavoro esemplare per tutto il mondo agricolo italiano.
L’intento del report è quello di presentare come “il tessuto imprenditoriale pontino, in particolare quello legato all’agroalimentare, costituisce un modello virtuoso di integrazione per migliaia di lavoratori stranieri, specie indiani e pakistani, che rappresentano un tassello essenziale di un settore in continua crescita fatto di aziende di eccellenza che esportano i loro prodotti in tutto il mondo.”
Quello di FDI è stato un tentativo di propaganda a tratti grottesco, per nascondere e/o minimizzare il sistema delle agro-mafie; l’intento dichiarato di questo report è quello di rispondere alle numerose denunce di capolarato, che danneggiano l’immagine economica del territorio.
In particolare si è voluto rispondere a Hilal Elver, Special Rapporteur ONU sul Diritto al Cibo che dopo una visita in alcune zone d’Italia (tra cui l’Agro Pontino) avvenuta a gennaio di quest’anno ha denunciato la presenza di molte aziende agricole fondate sullo sfruttamento. In tali realtà i lavoratori – in primis migranti che non trovano altre opportunità lavorative – non hanno protezioni sociali e legali adeguate, con il risultato di orari lavorativi eccessivamente lunghi e salari bassissimi, che non riescono a coprire i bisogni elementari della persona. Alla sua voce si è aggiunta quella di Federico De Siervo, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, che in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario ha definito come “allarmante” il fenomeno del caporalato, denunciando la situazione di moltissimi lavoratori stranieri, per lo più indiani, impiegati in condizioni di grave sfruttamento nei lavori in agricoltura.
Punti di vista differenti, che nonostante partano da indagini effettuate nello stesso periodo e si occupino dello stesso territorio, raggiungono risultati completamente diversi: da una parte si presenta una terra di integrazione, dove come nell’American Dream il giovane migrante da contadino diventa “imprenditore di sé stesso”, dall’altra si presenta un territorio dove il l’illegalità, la ghettizzazione e lo schiavismo sono fortemente radicati.
Pensare di nascondere le esperienze di caporalato dietro l’immagine del “duro lavoratore” perfettamente integrato e in sintonia con la comunità è di per sé un caso gravissimo. Questo fatto può essere però visto come una buona notizia, in quanto è il segnale che, dopo anni di denunce da parte dei sindacati (il primo sciopero dei braccianti Sikh è del 2016), delle organizzazioni e delle cooperative della zona, il sistema del caporalato è ormai alla luce del sole e dopo una storia trentennale di sfruttamento, inizia a sentirsi minacciato.
La ghettizzazione dei lavoratori indiani e i fenomeni di schiavismo che avvengono nelle campagne a pochi chilometri dalla capitale sono ormai di dominio pubblico. Questo spaccato è confermato non solo dai recenti casi di cronaca giudiziaria, ma anche dalle accurate ricerche etnografiche del sociologo Marco Ommizzolo, raccontate nel volume Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana (Feltrinelli 2019) e mostrate in maniera esemplare nel film The Harvest (un film di Andrea Paco Mariani al quale ha partecipato lo stesso Ommizzolo).
Lo scenario che ne emerge non è dei più rosei: un esercito silenzioso di persone, la maggior parte dei quali proveniente dalla provincia del Punjab e facenti parte della comunità Sikh, che ogni giorno lavorano per un padrone, con orari impossibili, che arrivano anche alle 10, 12 o addirittura 14 ore al giorno, per salari misere (3-4€ l’ora), con pagamenti che ritardano di mesi, violenze, incidenti sul lavoro che non vengono denunciati e minacce e licenziamenti facili per chi tenta di reagire. La necessità di sostenere ritmi di lavoro impossibili porta, soprattutto tra le persone più anziane, all’utilizzo di droghe, a volte spacciate ai lavoratori dai caporali stessi; la necessità di doparsi per lavorare porta con sé il rischio di cadere nella dipendenza, con effetti pesanti sulla salute psichica e fisica delle persone[1]. In particolare, la cronaca ha riportato casi di suicidi causati dagli effetti collaterali di queste sostanze.
Si tratta di lavoratori invisibili, che non possono abbandonare il proprio lavoro o denunciare la loro situazione in quanto sotto minaccia continua, perpetrata sia a livello di violenze fisiche, che con la perdita del posto di lavoro. Un ricatto che spesso coinvolge anche le famiglie rimasta nella terra natia. Questa situazione è peggiorata grazie ai decreti sicurezza, che – favorendo lo smantellamento del sistema SPRAR – hanno aumentando il numero di irregolari e ha reso ancora più numeroso l’esercito dei lavoratori “ricattabili”. Un sistema illegale basato su una rete di lavoratori-fantasma, che non è legato strettamente alla comunità indiana dell’agro pontino ma riguarda tutto il territorio nazionale, dai lavoratori delle vigne Venete fino ai braccianti di alcune aziende del foggiano.
In un’intervista al Manifesto di ieri (13/02/2020), Ommizzolo ha sottolineato come il sistema delle agro-mafie “nasce dai processi di deregolamentazione del mercato del lavoro prodotti nel corso degli ultimi trent’anni in Italia e in Europa, dalla subordinazione che questo Paese ha sviluppato nei confronti della globalizzazione economica neoliberista, di una visione mercantilista dei diritti che ha inteso il lavoro come variabile dipendente del profitto e l’ambiente come terreno dal quale estrarre potere, rappresentanza e denaro.”
Si tratta di una considerazione di interesse, che non riguarda solo il sistema delle agro-mafie: lo schiavismo che quotidianamente si perpetua nel nostro territorio, non interessa solo il settore agricolo, ma anche in altri campi, in primis quello della logistica.
Le situazioni descritte degli indiani dell’Agro Pontino sono simili a quelle dei lavoratori bengalesi e albanesi denunciate dalla FIOM all’interno degli stabilimenti di Fincantieri, dove i lavoratori delle ditte in subappalto lavorano senza sosta con turni estenuanti, senza tutele assistenziali, per paghe ridicole sostenute da buste paga false. Inoltre, come è emerso dai casi di cronaca a Marghera e Monfalcone, sono numerosi gli operai (di cui non ha la responsabilità legale, in quanto non formalmente non sono contrattati come dipendenti) che, per reggere i ritmi dettati dalle ditte del subappalto, fanno uso di sostanze dopanti. E questo accade in un’azienda importante come Fincantieri, che si vanta di promuovere iniziative sportive poiché queste “aiutino l’aggregazione dei giovani, il benessere psico-fisico e la promozione di stili di vita salutari”[2] .
Il caporalato è solo una delle tante facce che si celano dietro un capitalismo che mira ad essere sempre più “green” e “buono”, che ci presenta le aziende come attori impegnati nel benessere sociale, dove si punta sempre di più a esaltare l’importanza della responsabilità sociale delle imprese, ma che nei fatti nasconde fenomeni di sfruttamento paralegale e precariato estremo.
Non a caso, proprio durante una proiezione del film The Harvest, alcune voci dal pubblico hanno suggerito un parallelismo tra la situazione dei lavoratori dell’Agro Pontino e quella dei riders/corrieri, di cui si occupa Ken Loach nel suo recente film Sorry we missed you. Ovviamente si tratta di ambiti lavorativi diversi e di forme differenti di sfruttamento, unite però da un’unica logica, quella del profitto a tutti i costi, anche a scapito della stessa vita umana.
-
https://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/87_DOPARSI%20PER%20LAVORARE%20COME%20SCHIAVI.pdf ↑
Immagine Radio Alfa (dettaglio) da flickr.com

Nata a Treviso nel 1987, ha successivamente vissuto tra Bologna, Bucarest e Firenze. Femminista appassionata di musica, si interessa di politica, sociologia, antropologia e gender studies.