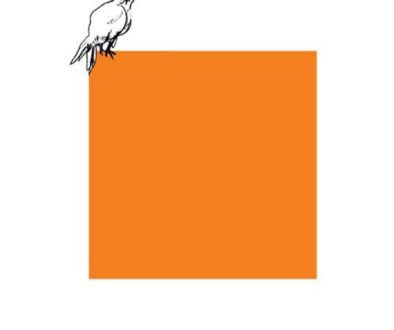E senza dubbio il nostro tempo… preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essere… Ciò che per esso è sacro non è che l’illusione, ma ciò che è profano è la verità. O meglio, il sacro si ingrandisce ai suoi occhi nella misura in cui al decrescere della verità corrisponde il crescere dell’illusione, in modo tale che il colmo dell’illusione è anche il colmo del sacro.
(Feuerbach, Prefazione alla seconda edizione de L’essenza del Cristianesimo).
Viviamo in un mondo in cui la comunicazione pervade ogni nostra azione quotidiana. Dall’alzarci la mattina da un letto di Ikea, a lavarsi i denti con un dentifricio di marca, siamo circondati dalle immagini, non importa navigare su internet o accendere la televisione per comprendere quanto la nostra vita sia circondata, pervasa dalla comunicazione, ogni giorno. Non volendo siamo costretti a subire e produrre comunicazione, basata sempre di più sull’immagine, quasi sempre filtrata, senza rapporti interpersonali diretti, se non necessari:
“Oggi ci votiamo a una comunicazione illimitata. Siamo quasi storditi dall’ipercomunicazione digitale. Il frastuono della comunicazione non ci rende comunque meno soli. Anzi, ci rende forse ancor più soli. […] L’ipercoumunicazione distrugge sia il tu sia la vicinanza, le relazioni sono sostituite dalle connessioni. L’assenza di distanza prende il posto della vicinanza.”[1].
La parola d’ordine del mondo è like, lo schermo digitale ci “scherma” da qualsiasi estraneità, allontana l’altro e la sua potenziale negatività, ci mescola tutti in un’indistinta omogeneità:
“Lo schermo digitale ci scherma sempre di più dalla negatività dell’estraneo, di ciò che è inquietante. L’estraneità è oggi sgradita, poiché rappresenta un ostacolo alla circolazione accelerata del capitale e dell’informazione. La coazione dell’accelerazione spiana tutto al livello dell’Uguale. Lo spazio trasparente dell’ipercomunicazione è uno spazio senza mistero, senza estraneità e senza segreto. […] Anche le immagini perdono sempre di più il loro carattere di qualcosa che ci sta di fronte e con cui interloquire. Alle immagini digitali manca ogni magia, ogni incanto, ogni forza di seduzione: non sono più immagini che ci stanno di fronte [Gegenbilder] con una loro vita propria, con una loro propria forza capace di irritare l’osservatore, di incantarlo, sorprenderlo, esaltarlo. Il mi-piace è il grado zero della percezione”[2].
Regna oggi una sorta di “indifferenza ontologica”, un’“ubriacatura dell’Uguale” (come le definisce il filosofo contemporaneo Byung-Chul Han) tutte votate all’obbligo della trasparenza, della visibilità, appiattita su un unico, per dirla con Deleuze, “piano di immanenza”. Tutto è sovraesposto, visibilizzato, e in questa marea di sovraesposizione di iper-visibilità, di iperinformazione, tutto risulta indistinto e in qualche modo indifferente.
La nostra stessa vita è mediatizzata: al di là del significato che possa avere, l’importante è apparire, che ciò avvenga tramite un selfie sui social network, o attraverso il post di uno stato personale. Privato e pubblico si con-fondono, trapassando l’uno nell’altro in maniera interscambiabile, in un’osmosi infinita in cui non riusciamo più a discernere cosa sia l’uno e cosa sia l’altro. Persino nel mondo del lavoro, dell’attivismo politico, dell’associazionismo, l’aspetto legato alla comunicazione è molto più ampio e risulta maggiormente incisivo rispetto al passato: se apri un ristorante dovrai tappezzare le mura della città con slogan e immagini di gustosi piatti, avere una pagina facebook con foto del locale, un funzionale ed efficace sito internet, delle buone recensioni su trip advisor; se fai parte di un’associazione e vuoi organizzare un’iniziativa, la componente grafica legata ai volantini e locandine da distribuire, da far girare sui social network, tra i contatti mail e whatsapp sarà preponderante; se militi in un partito politico, per la propaganda conteranno di più i “like” sulla pagina rispetto alla tua forza politica, l’efficacia di twitter e slogan sui social network rispetto a un lungo comizio.
Insomma, ora più che mai, possiamo dire che la nostra società è “società dello spettacolo”, come scriveva Guy Debord. Spettacolo che è diventato collettivo, in cui tutti siamo spettatori e attori consapevoli nella ricezione e produzione di immagini. La rappresentazione della realtà diventa essa stessa la realtà effettiva in cui ci muoviamo, perdendo il significato del vero e del falso:
“Esso [lo spettacolo n.d.r.] è una Weltanschauung divenuta effettiva, materialmente tradotta. Si tratta di una visione del mondo che si è oggettivata”[3].
Solo ciò che appare può assurgere il titolo di verità senza che nessuno si ponga il dubbio che questa possa essere finzione. La forma prevale sulla sostanza, in quanto funzionale alla narrazione della società dominante, che parla a immagini, perché si tratta di un linguaggio più semplice e diretto. Percorrere la strada che determina questo modo di comunicare significa fare dello spettacolo l’oggetto principale del vivere quotidiano, soppiantando l’individuo e il mondo che lo circonda, dalle proprie rappresentazioni.
“Lo spettacolo costituisce il modello presente della vita socialmente dominante […]. Forma e contenuto dello spettacolo sono ambedue l’identica giustificazione totale delle condizioni e dei fini del sistema esistente”[4].
Siamo di fronte a un mondo che vive della rappresentazione di sé e tutto ciò che non si traduce in immagine può difficilmente essere diffuso, recepito, compreso. L’acceleratore che il web ha posto in tutto questo è impressionante. In pochi decenni siamo arrivati alla possibilità di trovare in pochissimo tempo una quantità esorbitante di informazioni e a interagire con queste esponendoci continuamente al confronto con il resto del mondo. Siamo nel bel mezzo di quello che il sociologo Levy chiama “diluvio informazionale”.
Ma se da una parte è più immediato, più semplice, accedere a ogni tipo di informazione, dall’altra queste informazioni non sono selezionate da alcun tipo di controllo, così che ciascuna di esse è portatrice di uno stesso valore di legittimità. Non vi sono più gradi di verità, perché tutto è potenzialmente vero dal momento che qualcuno lo reputa tale e lo mette nero su bianco su una qualsivoglia piattaforma, digitale o cartacea che sia. Una massa di informazioni avaloriale in un mondo che rifiuta il principio dell’oggettività.
Tutti ci sentiamo in diritto di dare una nostra opinione sulle cose, o di dare credito a qualsiasi opinione giri sul web, perché sembra non siano più sufficienti i tradizionali strumenti di verificabilità e di ammissibilità dati dalle varie comunità scientifiche a quelli che un tempo si chiamavano fatti, storici e scientifici, e che sono stati accolti, introdotti e introiettati dalla nostra cultura. I fatti non sono più ritenuti tali da un cospicuo numero di persone (spesso senza alcuna autorevolezza scientifica) che si sentono in diritto di metterli in discussione, credendo di sfatare, in maniera anticonformista e anticonvenzionale le “verità accertate” dalle comunità scientifiche, presentandosi come portatori di “verità alternative” che, vincendo il braccio di ferro con le argomentazioni più attinenti al vero, finiscono col produrre nuovi punti di riferimento per l’opinione pubblica. Purtroppo questo tipo di “trappola dialettica” ha molta presa soprattutto su un pubblico frustrato dalle proprie condizioni materiali e sociali a caccia di capri espiatori che possano annullare qualsiasi tipo di responsabilità per la propria situazione di indigenza e malessere e che è pronto ad aggrapparsi a qualsiasi “rivelazione” presentata come la verità finalmente disvelata e che spesso appare anche più rassicurante.
È da qui che la comunicazione ha iniziato a diventare l’aspetto principale e insostituibile della vita-spettacolo, facendo in modo che tutto quello che facciamo sia destinato alla diffusione esteriore. È chiaro dunque che con l’aumentare dell’orizzontalità e della pervasività della comunicazione, il messaggio che si intende comunicare viene semplificato o appiattito sullo scopo che si vuole ottenere se non plasmato apposta per arrivare al pubblico cui ci si vuole rivolgere.
A ricoprire uno degli aspetti principali del comunicare è la conoscenza dei sentimenti e dei desideri del pubblico che vogliamo raggiungere. Nella rete accade quel che già un secolo fa aveva analizzato Gustave Le Bon riguardo alla “psicologia delle folle” (suo omonimo libro) dell’epoca moderna arrivata ormai all’ultimo stadio del processo di industrializzazione. La folla intesa non come un agglomerato numerico di individui ma un’unità collettiva, rappresenta il tema centrale del ragionamento di Le Bon:
“La personalità cosciente svanisce, i sentimenti e le idee di tutte le unità sono orientate in una stessa direzione. Si forma un’anima collettiva […]. La collettività diventa allora […] una folla organizzata, o […], una folla psicologica. Essa forma un solo essere e si trova sottomessa alla legge dell’unità mentale delle folle”[5]. Nella folla l’elemento razionale e cosciente scema lasciando il sopravvento alla emotività e all’istintualità; i sentimenti e i desideri sono orientati verso un unico senso o un’unica direzione.
Più avanti Le Bon scrive che la conoscenza di questi sentimenti e desideri è lo strumento principale per governare, manipolare e soggiogare le folle.
Questa riflessione sarà fatta propria dai grandi dittatori del secolo breve, quali Hitler e Mussolini, attenti lettori dell’opera dell’autore francese. Il concetto di controllo delle masse sarà poi ripreso, prendendo altre forme, da pensatori come Althusser – che ha parlato di apparati ideologici – o Foucault con la sua indagine sulla performatività degli strumenti di potere che, insieme a tutte le forme di sapere, produce regimi di verità.
La comunicazione mediatica ha contribuito a forgiare una massa indistinta, a creare “nuovi valori” che non tengono conto delle differenze di classe, di opinione politica, di condizioni economiche, perché si rivolgono a un tutto indistinto, a un’uniformità omologata. Già Pasolini sottolineava come la televisione, intesa come mezzo autoritario e non meramente tecnico, manifestasse lo spirito di quello che lui chiamava “il nuovo potere”, che per Pasolini, semplificando molto, poteva riassumersi in una sorta di totalitarismo consumistico, edonistico e conformante che ha mutato antropologicamente la vecchia cultura di classe sostituendola con una nuova cultura interclassista e mutando profondamente la natura delle coscienze:
“Il bombardamento ideologico televisivo non è esplicito. Esso è tutto nelle cose, tutto indiretto. Ma mai un «modello di vita» ha potuto essere propagandato con tanta efficacia che attraverso la televisione. Il tipo di donna o di uomo che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare, non è descritto o decantato: è rappresentato! Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Che viene dunque mimato di sana pianta, senza mediazioni, nel linguaggio fisico-mimico e nel linguaggio del comportamento nella realtà. […] Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova ideologia edonistica del consumo: e quindi è enormemente efficace”[6].
Secondo Pasolini la comunicazione e il linguaggio televisivo riproducono un sistema di potere che si radica nelle coscienze della massa (spogliata, appunto, di ogni sua particolarità) diffondendo, indirettamente e implicitamente, una sorta di “comandi”, di dogmi, di direttive, di ordini taciti che ciascuno introietta e si sente in dovere di fare propri:
“La proposizione prima di tale linguaggio [quello della televisione] fisico-mimico è la seguente: «Il Potere ha deciso che noi siamo tutti uguali». L’ansia del consumo è un’ansia di obbedienza a un ordine non pronunciato. Ognuno in Italia sente l’ansia, degradante, di essere uguale agli altri nel consumare, nell’essere felice, nell’essere libero: perché questo è l’ordine che egli ha inconsciamente ricevuto e a cui «deve» obbedire, a patto di sentirsi diverso. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è una «falsa» uguaglianza ricevuta in regalo […] Ma una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza dell’esprimersi vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale […] è la tristezza: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva, offensiva. La tristezza di cui parlo è profondamente nevrotica. Essa dipende da una frustrazione sociale. Ora che il modello sociale da realizzare non è più quello della propria classe, ma imposto dal potere, molti non sono appunto in grado di realizzarlo. E ciò li umilia orrendamente”[7].
Anche il già citato Byung-Chul Han parla del nostro tempo come caratterizzato da un’angoscia profonda, ma che non è più derivata dall’angoscia che si prova di fronte a ciò che è totalmente Altro da noi, bensì dalla frustrazione quotidiana insita in un sistema neoliberista che spinge l’essere umano a una continua, estenuante ottimizzazione di sé e delle proprie performance in ogni ambito della propria esistenza, che fa dell’individuo un imprenditore di sé stesso in continua competizione con gli altri, ansioso di ottimizzare le proprie “skills” e la propria capacità produttiva:
“Molti oggi sono tormentati da angosce diffuse: angoscia di fallire, angoscia di diventare dipendenti, angoscia di commettere un errore […], angoscia di non riuscire a soddisfare le proprie esigenze. Questa angoscia viene resa sempre più grande dal continuo paragonarsi agli altri. È un’angoscia laterale, opposta a quell’angoscia verticale che si risveglia di fronte al totalmente Altro, all’inquietudine, al nulla. Viviamo oggi in un sistema neoliberista che smantella le strutture temporali, frammenta il tempo della vita e disintegra tutto ciò che ha carattere vincolante, al fine di aumentare la produttività. Questa politica del tempo neoliberista genera angoscia e insicurezza. E il neoliberismo isola l’uomo, facendolo diventare un isolato imprenditore di se stesso […] La perfida logica del neoliberismo afferma: l’angoscia genera la produttività”[8].
[Continua nei prossimi giorni]
-
B.C Han, L’espulsione dell’Altro, Nottetempo, Milano 2017, p. 52. ↑
-
Ivi, pp. 52, 58. ↑
-
G. Debord, La società dello spettacolo, p. 11. ↑
-
Ibidem. ↑
-
G. Le Bon, La psicologia delle folle, p.10. ↑
-
P. P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 2008, p. 59. ↑
-
Ivi, pp. 60-61. ↑
-
B.C Han, op. cit., p. 48. ↑
Immagine di Michael Jastremski (dettaglio) da openphoto.net

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.