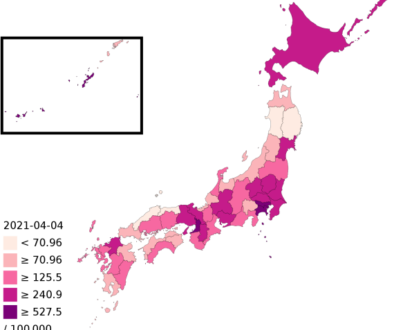Di banche italiane e intervento pubblico
Il ministro Padoan dopo averci ripetuto all’infinito quanto il sistema bancario italiano fosse solido si è trovato a dover gestire la risoluzione monster delle banche venete. Tuttavia, molto più interessanti e significative sono le modalità di questa.
Il gigante Banca Intesa si è appropriato al prezzo simbolico di un caffè degli ultimi crediti rimasti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo Stato – cioè la collettività, noi cittadini in parole povere– si è occupato di liquidare la parte “tossica”. Dunque da un lato lo Stato si è impegnato a coprire la gestione scellerata dei conti delle banche venete intervenendo con una spesa di 5,3 miliardi di euro, con la possibilità di arrivare fino a 17 miliardi, una spesa pro-capite di 300 euro per ripianare i passivi, mentre Banca Intesa si è presa tutti gli attivi.
Il solito tema della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti sembra dunque essersi ripresentato in questi giorni, mentre l’attenzione pubblica è stata totalmente deviata su temi più futili.

Il salvataggio delle “banche venete” ha sicuramente fatto molto discutere, rivangando in molti brutti ricordi risalenti agli albori della crisi. Per capire cosa significhi questa vicenda bisogna prima di tutto abbandonare l’ingannevole definizione localistica di questi due istituti di credito, che molto spesso ricorre anche nelle giustificazioni ufficiali del salvataggio («non possiamo deprimere l’economia del Veneto», ecc.). Entrambi gli istituti rivestono un’importanza che trascende l’ambito veneto. A Prato, la città dove ho vissuto fino a pochi anni fa, la Banca Popolare di Vicenza è diventata assolutamente egemone assorbendo la vecchia Cassa di Risparmio di Prato tra il 2003 ed il 2010, comunque in precedenza controllata dal gruppo Monte dei Paschi. Non è solo una questione di correttezza terminologica. Nel secondo dopoguerra uno degli aspetti più peculiari dalla regolamentazione bancaria market negating (ovvero non motivata nella sostanza dall’adeguatezza al mercato o dall’efficienza economica) adottata quasi ovunque in Occidente consisteva proprio nella differenziazione funzionale tra istituti di credito settoriali (banche dell’agricoltura, popolari, casse di risparmio, ecc.) e locali e grandi banche. La reazione all’ordine postbellico, iniziata con la disastrosa liberalizzazione delle casse di risparmio statunitensi e diffusasi sull’onda della finanziarizzazione dell’economia, ha spazzato via questa come altre precise limitazioni; un’anarchia che, se ha garantito per qualche tempo l’illusione del credito facile a tassi vantaggiosi, alla fine si è dimostrata nociva per le banche stesse, oltre che per i loro clienti.
Paradossalmente, in un’epoca in cui qualunque azione politica non market conforming è stata (ed è) vista come fumo negli occhi, almeno implicitamente i principi del too big to fail e della garanzia pubblica su depositi e risparmi non sono stati toccati. Qualunque regolamentazione in senso contrario, come la normativa corrente sul bail-in, pur se in astratto giuridicamente inattaccabile, è destinata a scontrarsi con la (patologica) realtà dei fatti italiana, in cui l’azzeramento dei (pessimi) investimenti di un gran numero di cittadini ed il ricorso a soluzioni di mercato è troppo politicamente costoso per essere accettabile. L’inazione non può essere una soluzione: oltre al prezzo politico esatto dalla furia dei risparmiatori si finirebbe per pagare il risparmio di una qualche cifra di denaro pubblico e la salvaguardia di un principio di non interferenza nel mercato (o un cupio dissolvi nichilista, diffusissimo a sinistra), con anni e anni di crisi, depressione e miseria. Meglio sarebbe imparare la lezione, e studiare nuovi metodi per prevenire il ripetersi di situazioni del genere.
BpVi, trasformata in una società per azioni solo pochi anni fa e tra le polemiche, in una situazione già compromessa e segnalata dalla BCE, secondo un recente articolo uscito sul Sole 24 ore era solita concedere mutui a chiunque ne sottoscrivesse le azioni, in una spirale tossica di crediti inesigibili e capitalizzazione gonfiata. Non è difficile tirare le somme, collegando la disonestà del management, la scarsa conoscenza delle basi della finanza moderna da parte dei clienti-investitori e l’assenza di una regolamentazione degna di questo nome da quarant’anni a questa parte, per farsi un idea di quanto sia impellente la necessità di tornare a concepire gli istituti di credito come interessi pubblici cruciali da salvaguardare, prima di tutto da sé stessi. Potrebbe essere un primo passo per iniziare a discutere di riportarne almeno una parte sotto l’ala della proprietà pubblica, dei soci o delle comunità.

In seguito all’ultima crisi economica Riccardo Bellofiore ha coniato il termine di “keynesismo finanziario” per spiegarci come l’indebitamento delle famiglie fosse in realtà stimolato ed agevolato dalla politica di denaro facile da parte della Federal Reserve. Questa politica era d’altra parte l’ultimo argine per colmare i vuoti di potere d’acquisto determinati da un impoverimento progressivo di fasce sempre più estese della popolazione. In seguito allo scoppio di questa crisi abbiamo visto crollare nell’ordine: i conti di alcune banche e in seguito i conti pubblici di alcuni stati. Il legame non è casuale, perché vede lo Stato intervenire sistematicamente in soccorso dell’economia privata.
Prima stimola all’indebitamento per sostenere il consumo; poi quando questi debiti assumono una mole pericolosa se ne assume gli oneri, collettivizzandoli. Così tra gli ultimi moniti di Luciano Gallino troviamo quello verso “il keynesismo a favore delle banche” che andava ad erodere risorse a un indispensabile e agognato Piano del Lavoro. Era il 2013 e all’epoca il rimpianto Gallino poteva lamentarsi per l’Ue di Barroso che tirava fuori (dall’inizio della crisi al novembre del 2011) 4,6 miliardi di euro. Per renderci conto di quanto stia precipitando la crisi sistemica e la finanziarizzazione circoscriviamo l’area d’intervento alla sola Italia sempre negli ultimi tre anni. Se si fa un breve conto solo dei costi diretti per il salvataggio delle banche piene di debiti si arriva a circa 12 miliardi e mezzo di costi diretti. Fondo Atlante è costato alla collettività circa 4 miliardi e 250 milioni; il secondo Fondo Atlante altri 3miliardi; la Bad-bank banche venete 5 miliardi e 300milioni. A questi non osiamo poi aggiungere il conteggio dei costi indiretti della continua gestione emergenziale delle vicende, come invece ha fatto il quotidiano La Stampa (leggi qui). Il tutto per ribadire un concetto che dovrebbe essere ormai elementare: i debiti privati vengono ripianati dallo Stato che li accolla alla cittadinanza, salvo poi rilevare come essa abbia osato vivere tra spese folli e insostenibili. Di qui nuove politiche austeritarie, nuovo drastico calo del potere d’acquisto e nuova crisi da finanziarizzazione con interventi statali a drogare un’economia ormai in crisi sistemica.

Il livello di alfabetizzazione rispetto ad un argomento determina la capacità di poter incidere politicamente sul determinato piano. Ammetto senza difficoltà l’ignoranza sul tema delle banche, nonostante sia un quotidiano lettore del Sole 24 Ore da oltre tre anni (assieme a il manifesto, che però mi accompagna dal 2006). Le pagine sulla finanza e sulle crisi bancarie sono però quelle in cui colgo meno elementi di riflessione. Manca il tempo per capire un mondo descritto in una modalità sempre più autoreferenziale. Ci hanno provato film (come La grande scommessa), romanzi (in Italia abbiamo recensito I signori della cenere) e trasmissioni televisive (in Italia su la 7 vanno in onda anche teorie cospirazioniste).
Il nodo pare semplice: i soldi per salvare le banche li trovano ma per salvare vite umane no. La risposta di solito a un ragionamento così semplicistico è che non ci possiamo permettere il fallimento delle banche e della finanza. Mi fermo umilmente a questo livello, questa settimana. Perché io, lavoratore dipendente a tempo indeterminato, correntista alle Poste, non posso permettermi il crollo di un pezzo di economica corrotta del nord-est? Perché la politica è così compromessa? Dare la colpa alla casta appare troppo semplice. Esiste un’economia diffusa fin troppo coinvolta in operazioni di speculazione. Siamo pur sempre un Paese campione in evasione fiscale. Destrutturare le notizie e alfabetizzare: questa è la mia esigenza, ben poco utile alla discussione probabilmente.

La Borsa di Milano, e i titoli del credito in particolare, ha salutato con una chiusura positiva l’ulteriore passo di ristrutturazione del sistema bancario costituito dalla vicenda di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. La liquidazione delle banche venete procede di pari passo con il prospettato aumento di capitale per il Monte dei Paschi di Siena. La banca senese, rimpolpata dai fondi del Tesoro, dovrebbe quindi poter riaccedere al FTSE MIB, da cui fu esclusa dopo la vittoria del No al referendum costituzionale e la conseguente impossibilità di reperire sul mercato i 5 miliardi necessari (ora quadruplicati e sulle spalle dei contribuenti).
Questo denaro, così come quello impiegato per la tutela del credito offerto dalle banche venete, sarà recuperato? Secondo il ministro Padoan sì – porta ad esempio i “Monti bond” i cui interessi, restituiti da MPS, hanno fruttato un guadagno netto per lo Stato italiano.
L’obiettivo di Padoan appare esattamente quello di limitare la partecipazione statale nel sistema bancario alla sola fase emergenziale per poi disimpegnarsi avendo raggiunto un triplice obiettivo: garantire un’immutata offerta di credito al tessuto socio-economico del territorio, restituire agli istituti la competitività sul mercato, uscirne come Stato con un bilancio a saldo positivo.
Tutta politica, invece, la partita che si gioca sulla commissione d’inchiesta: a sette mesi dalle elezioni politiche i partiti di opposizione proveranno a sfruttarla contro Renzi e il Pd sul modello di quanto già fatto nel 2006 (Berlusconi su Unipol) e 2013 (Grillo su MPS). Ma anche la dirigenza del Pd potrebbe essere tentata dall’usarla contro avversari interni come D’Alema, nume politico dell’affaire Banca 121, o De Benedetti, primo debitore insolvente della banca senese.

La scarsa preparazione in materia mi impedisce di azzardare un ragionamento complesso e approfondito sul salvataggio delle banche venete. Mi limito dunque a una piccola considerazione di carattere generale.
Ultimamente in Italia, nonostante le continue rassicurazioni sul fatto che vada tutto bene, si sono susseguite una serie di gravi situazioni di fallimenti finanziari piuttosto gravi, come Alitalia e appunto gli istituti di credito veneti. La domanda che sorge spontanea a un profano come il sottoscritto è: ma perché lo Stato, se mette così tanti soldi, non procede all’acquisto di queste imprese? Che senso ha mettere fondi che non si trovano per finanziare il Welfare se poi queste imprese o banche restano in mano privata?
Il dramma è che in casi come questi la nazionalizzazione non è nemmeno un’opzione messa sul tavolo. Uno strumento, magari non sempre efficiente, ma comunque spesso impiegato profiquamente qualche decennio addietro, ora non sembra poter essere nemmeno immaginato. Il sistema culturale è talmente spostato a destra, che parlare di nazionalizzazioni equivale a evocare i Soviet. Non sembra esserci più nemmeno spazio anche solo per pensare una politica economica di stampo lievemente dirigista mentre il ruolo dello stato sembra essere sempre più solo quello di mettere le toppe a un sistema finanziario neoliberista che appare sull’urlo dell’ennesima crisi sistemica.

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.