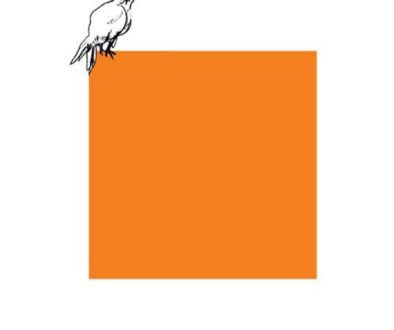”… E il suo nome, a motivo dell’essere amministrata non nell’interesse dei pochi ma dei molti, è democrazia, e secondo le leggi ciascuno ha pari diritti nelle dispute private, e per quanto riguarda la considerazione dei cittadini ognuno, secondo quanto si distingue in qualche campo, nell’amministrare le faccende pubbliche non è stimato per la classe sociale da cui proviene più che per il suo valore…”
(Tucidide, II 37)
Democrazia. Questa parola la usiamo ogni giorno, la sentiamo in televisione, la leggiamo nei giornali, la osanniamo, la innalziamo come vessillo contro i regimi dittatoriali, ci promettiamo – ma sempre troppo tardi – di difenderla dal potere autocratico dell’uomo solo e del suo entourage, o dalla “dittatura del mercato” che la schiaccia, o anche più semplicemente da certe azioni e decisioni politiche che a volte, per non dire spesso, la tradiscono, la mortificano, la vituperano, la uccidono.
E noi ci ritroviamo a piangere lacrime di coccodrillo ogni qualvolta assistiamo alla sua lenta agonia o, nel peggiore dei casi, al suo funerale. Certo, non sembra mai morire del tutto, per fortuna, o in ogni caso non ne muoiono l’essenza – anche se la forma può cambiare – , il principio, la parola. Ma quando poi rinasce, come una fenice dalle proprie ceneri, sembra sempre un po’ più acciaccata, come se non avesse potuto rimarginare tutte le ferite ricevute negli anni. E rinasce sempre un po’ mutata, sempre con qualche pezzettino in meno, sempre meno demo e un po’ più kratos.
La parola democrazia è l’esito di un lungo processo, che, guarda caso, parte proprio dalla culla in cui essa ha preso forma e vita, la culla della civiltà greca.
Il primo a usare il termine demokratia, con quella particella ia che significa astrazione, è stato il grande storico Erodoto nel VI libro delle sue Storie, due volte. Nel primo passo scrive che Mardonio, generale persiano, nel 492 a.C (poco più tardi della sconfitta persiana, da parte greca, a Maratona) instaura le democrazie al posto delle tirannidi nelle città ioniche; nel secondo passo, il grande legislatore Clistene è ricordato come colui che nel 506 ad Atene “istituì le tribù (territoriali anziché genetiche) e la democrazia”. Nel mondo greco questa idea nasce ed è usata in prima istanza – anche da Erodoto appunto – come contrapposizione al regime tirannico, tanto avverso in Grecia, da Atene in primis. Democrazia per i greci è in primo luogo anti-tirannide, antitesi al governo di uno solo.
Già però dal V secolo – e come vedremo fondamentale in questo sarà l’apporto di Pericle – quella che era “semplice” ideologia antitirannica si riveste di atti e principi formali e istituzionali che ne fanno un vero e proprio sistema, anzi un vero e proprio modello di libertà, giustizia e legalità (per quanto non sempre giuste né tantomeno egualitarie, se non a livello teorico) da esportare sia dal punto di vista culturale (“Atene patria della civiltà”), sia dal punto di vista politico, tanto che durante l’espansionismo ateniese democrazia diventa quasi sinonimo di imperialismo sfrenato. Con la scusa dell’esportazione di questo modello privilegiato io sono autorizzato a portarti la guerra o comunque a entrare nelle vicende economiche delle poleis alleate (si veda il caso di Nasso o dell’isola di Taso nel V secolo).
L’Atene democratica vuole difendere la sua egemonia proprio perché madrina di una civiltà unica e perfetta, proprio perché fondatrice di un modello di democrazia ineguagliabile a cui tutti devono adeguarsi, volenti o nolenti. E questo ruolo di culla democratica Atene lo svolgerà sia intervenendo a difesa di città minacciate dalle tirannidi, sia in maniera offensiva, contro la defezione di queste stesse città, spesso oppresse dall’ingerenza e dall’egemonia di Atene e del suo imperialismo eccessivo, che la porterà infatti, a una dura capitolazione già alla fine della guerra del Peloponneso.
Tornando ad Erodoto, se è vero che demokratia è usata in funzione di contrapposizione alla tirannide, bisogna aggiungere che lo storico – che ha già maturato una coscienza più complessa di quell’idea, essendo nato nel 484 a.C, quindi in quel V secolo che già ha conosciuto gli sviluppi di un’idea che si è investita di più alti ideali e forme più articolate – nel III libro presenta una concezione ben vicina a quello che noi pensiamo quando parliamo di democrazia. Ciò traspare nel dialogo tra i “Grandi della Persia” alla vigilia dell’ascesa di Dario al trono, quando discutono sulla forma politica da adottare, dopo la fine di Cambise, figlio di Ciro il Grande.
“Il versante greco della presunta discussione tra Otane, Megabixio e lo stesso Dario conserva tutto il suo valore, per capire le caratteristiche del pensiero greco sulla democrazia e anche, in qualche misura, la personale posizione di Erodoto. La forza della democrazia di incarnare un principio, la sua caratterizzazione di fondo attraverso connotazioni teoriche e pratiche inequivocabili, il suo diritto di porsi, almeno in linea di principio, come il ‘più bel nome’ che esista al mondo, in quanto identificabile con isonomìa, cioè uguaglianza di fronte alla legge, risultano con la più grande evidenza nel discorso di Otane.”
(Domenico Musti, Demokratia. Origini di un’idea).
Dunque in questo passo Erodoto mostra, pur stando attento a non usare in quel contesto persiano la parola democrazia, di creare un’affinità concettuale tra quella parola e il “governo delle leggi” , l’uguaglianza di fronte alla legge, così importante per il pensiero greco e che troverà il suo apice in Efialte (il primo vero democratico radicale) e piena teorizzazione in Pericle.
Isonomìa è un sistema di principi e valori radicati nei Greci e “l’aspetto della definizione istituzionale prevale, nella descrizione di Otane, rispetto al dato comportamentale e morale, che semmai è evocato, contro la democrazia e a favore delle altre due forme politiche (oligarchia e monarchia), nei discorsi di Megabixio e Dario. Tipica del regime monarchico è la non soggezione a rendiconto – aneùthynos – , mentre le caratteristiche del regime isonomico-democratico sono l’esercizio delle cariche per sorteggio, e con soggezione a rendiconto (hypeùthynos arché), e l’assoggettamento delle delibere al vaglio della comune decisione: in definitiva, uguaglianza di diritti politici, rendicontazione e trasparenza”. (D. Musti)
Occorre però fare una piccola precisione sull’uso originario del termine demokratia. Se è vero che il primo ad utilizzarla apportandovi quella fondamentale e non trascurabile particella astrattiva, la prima parafrasi del termine la si trova insospettabilmente nel testo della Grande Rhetra (la costituzione) spartana, in cui viene assicurato un nesso tra demos e kratos. Ciò è insospettabile perché il demos di cui si parla è il meno democratico che si possa immaginare, così come la stessa costituzione e mentalità spartana sono e saranno sempre caratterizzate da ideali di compattezza, conservazione, chiusura di fronte alle novità, paura del diverso, xenofobia, reazionarietà. Al massimo Sparta si farà, soprattutto durante il venti settennale conflitto del Peloponneso (431 a.C – 404 a.C) di una eleutherìa, di una libertà che però anziché essere la libertà con la elle maiuscola piuttosto difesa dell’autonomia particolaristica delle poleis greche, non un modello ben costruito e caratterizzato come quello democratico.
Se comunque un primo nesso tra i due termini, “popolo” e “forza” lo troviamo nell’antidemocratica Sparta, il culmine di questo legame è meravigliosamente e abilmente tessuto, sempre attraverso una meravigliosa parafrasi, dal grande tragico di V secolo Eschilo e precisamente nelle Supplici, probabilmente del 463/2, quindi all’epoca delle riforme di Efialte che andavano in direzione della democrazia radiacale.
Brevemente la trama. Siamo ad Argo (e la scelta del luogo non è casuale, essendo la città passata in quel periodo a regime democratico). Le figlie di Danao – le danaidi – , oggetto della passione dei cugini che vorrebbero sposarle con la forza, fuggono dall’Egitto per raggiungere Argo, loro patria di origine; accompagnate e protette dal padre, chiedono ospitalità al re del luogo, Pelasgo. Raggiunte dai cugini e costrette a sposarli , ricevono dal padre l’ordine di uccidere i loro mariti. Lo fanno tutte tranne Ipermestra che salva Linceo, dal quale poi discenderà la popolazione argiva. Nel bellissimo testo eschileo la città di Argo e la sua “democrazia” (che tale ancora non è, non può esserlo in epoca di alto arcaismo, sarebbe un errore di anacronismo storico e l’autore ne è ben consapevole) fungono da metafora della recente democrazia ateniese. Tramite la vicenda delle Danaidi il poeta esprime, valuta e descrive in termini politici una situazione che solo apparentemente è di ordine etico-religioso.
“Il coro delle Danaidi, presenta al pubblico la sua condizione umana, politica e giuridica, con immagini che già dalle prime battute introducono elementi lessicali di chiaro profilo politico. Di sé dicono di aver lasciato la patria (l’Egitto) non perché condannate da un voto della città (chiaro richiamo alla psephos – voto – che è parola chiave nel lessico procedurale della neo-democrazia); e neppure in quanto cacciate dal popolo per un delitto di sangue: esse hanno lasciato la patria per una istintiva fuga dal maschio. Sono quindi immediatamente giocati tutti i piani, umano, morale, religioso, politico; e il lessico politico traspare da tutte le situazioni.”
L’abilità e l’arguzia sottile di Eschilo esplodono nella scomposizione e ricomposizione che egli fa della parola demokratia, restituita nelle sue due componenti, demos e kratos, che ricorrono in tutto il testo. Il coro delle supplici, che appartengono a un posto e a una mentalità esotica “barbara”, lontana dai principi di uguaglianza propri del popolo argivo dice al re Pelasgo, dopo che quest’ultimo ha affermato che la loro non è una faccenda privata, ma che se si contamina la città sia il popolo a cercare in comune di riparare ai guasti:
“Ma tu sei la città, tu sei il popolo. Tu sei principe un principe non giudicabile, tu domini [kratyneis] l’altare, il focolare della terra, con i tuoi cenni, che valgono come voto unico, tutto decidi”.
Replica allora Pelasgo: “Non è facile decidere, non mi scegliere come giudice. Non senza il popolo io potrei fare queste cose, nemmeno kraton [“se come è vero, io sono il capo”; oppure: “neanche se ne avessi il potere”]”.
Formidabile il graduale avvicinamento della Danaidi alla lettura autentica di democrazia: “la parola demokratia va sciolta in ‘potere del popolo’, ma il genitivo può essere sintatticamente un genitivo soggettivo o uno oggettivo. È come se, di fronte a una lettura demou kratìa come dominio che può esercitarsi sul popolo – è così che il coro delle Danaidi legge il potere eccezionale di Pelasgo – questo rovesciasse il tutto nella giusta interpretazione, sì da rendere il demos soggetto e non oggetto del kratein. È quasi una lezione concettuale e lessicale di democrazia”. (Musti)
La punta più alta però di questo gioco sintattico sulla parola demokratia è raggiunta al momento del voto, da parte dell’assemblea, che deve decidere, per alzata di mano se accogliere o meno le povere supplici.
Ed ecco che Pelasgo chiede “dèmou kratousa cheìr hopei plethynetai”, ovvero, dove “si addensa la mano dominante del popolo?”.
Eschilo, ben consapevole del fatto che non si può parlare nell’età di Pelasgo di “democrazia”, scioglie la parola in demou kratousa cheìr, che è la mano dominante del popolo. E la constatazione del re a questo punto è che “il popolo degli Argivi ha deciso, non dividendosi […]: infatti col voto di tutto il popolo l’aria è diventata irta di mani destre [letteralmente quasi “rabbrividì di mani”], di persone che approvano questo discroso”.
Si avverte perciò l’esultanza per l’unanimità di una decisione libera, legittima, giusta, su un grande valore come quello della protezione (così importante per i greci, sebbene ogni tanto tradita nei fatti. Si pensi all’episodio dei Ciloniani che nel VI secolo, nonostante si fossero legati con una corda – che però si spezza – alle statue della dea e che perciò in quanto supplici avrebbero dovuto esser risparmiati, furono massacrati in maniera sacrilega dalla famiglia degli Alcmeonidi, una delle famiglie più ricche e importanti della storia della città di Atene) del supplice.
Il voto dell’assemblea è essenziale anche in un’altra delle tragedie eschilee, le Eumenidi, terza della trilogia dell’Orestea. In questo caso però non si assiste a un vibrare dell’aria per la quantità di mani alazate, bensì ci si trova di fronte a una spaccatura. Di fronte alla scelta della condanna di un matricida (Oreste ha ucciso la madre Clitemnestra per vendicarsi del padre Agamennone, da lei assassinato a tradimento insieme all’amante Egisto) o alla sua assoluzione (il diritto del padre è più importante dell’uccisione di una madre che si è macchiata di un delitto ancor più grande ammazzando il proprio marito) il popolo si divide.
Diritto materno – difeso dalle Erinni – contro diritto paterno – difeso da Apollo, che considera legittima la vendetta di Oreste. Qui non basta dare uno sguardo alle mani alzate, ma trattandosi di una vita umana il conto deve essere preciso. Qui non vale più il discorso della maggioranza, perché anche un solo voto in più potrà salvare o meno la vita del giudicato. E il risultato sarà proprio un 50 più un voto, dato da Atena che con il suo voto riuscirà a garantire la salvezza ad Oreste e istiuirà l’Areopago come tribunale giudicante i delitti di sangue.
Quindi, è vero che nella mentalità greca vale di norma il principio della maggioranza e la stessa parola demos potrebbe più facilmente indicare non la totalità (Plethos) dei cittadini ma un corpo civico (si ricordi che all’ekklesia, l’assemblea vedeva una partecipazione di 6000 cittadini a fronte dei 20/30.000 che contava Atene), che pur non essendo tutta la città, vuole farsi carico di diritto e doveri della totalità, cioè anche della minoranza. Pur ammettendo il principio maggioritario, però avviene che in certe questioni basti un solo voto a far la differenza, soprattutto quando si tratta di salvare qualcuno. Al contrario, a volte anche lo stesso principio di maggioranza sembra non bastare. Per certe delicatissime decisioni occorre l’unanimità.
È questo che ad esempio sembra volerci far capire il più grande padre occidentale della storia, Tucidide, quando all’avvento della spedizione in Sicilia del 415 scrive che l’avallo della guerra avrebbe avuto bisogno dell’unanimità e non solo della maggioranza. È lo stesso Tucidide che scrive quello che si può chiamare “manifesto della democrazia”, nel II libro (vv. 35-40) in cui compare il bellissimo Epitaffio pronunciato da Pericle per i caduti del primo anno della guerra del Peloponneso (431 a.C).
Non possiamo sapere se Pericle pronunciò quelle esatte parole, ma sicuramente l’essenza del suo discorso e la sua originalià sono state riportate fedelmente dallo storico, che ha sempre perseguito e portato avanti la sua esigenza assoluta di verità ed oggettività. La prima originalità è dovuta al fatto che contro il tradizionale pessimismo greco, dovuto a una concezione naturalistica (già di matrice Esiodea, con la sua scansione delle età) di nascita-declino-morte, le parole Periclle sembrano un inno al progresso e ai contributi che ciascuna generazione dà alla propria città e alla propria esistenza:
“Infatti, abitando sempre i medesimi la regione in successione di coloro i quali sono sopravvenuti nel corso del tempo, fino ad ora la trasmisero libera in forza del loro volere. E quelli sono degni di lode, ma ancor più i nostri padri. Infatti avendo acquistato, oltre alle cose che avevano ricevuto, quell’impero che abbiamo, non senza fatica l’hanno trasmesso a noi di ora. Ma la maggior parte di questa arché noi che siamo ancora nell’età assestata accrescemmo e la città per tutti gli aspetti abbiamo resa del tutto autosufficiente per la guerra e la pace”.
Altra novità dell’epoca periclea è il ruolo, mai così forte, dell’opinione pubblica che diventa un’arma politica da sfruttare abilmente. E Pericle in questo è forse il maestro: riesce a essere la voce del popolo. Ne smuove gli animi, usa il noi collettivo per coinvolgere il suo pubblico, lo incalza quando lo avverte fiacco, lo intimorisce quando sembra arrogante o insuperbito. Il suo discorso si snoda tutto su un piano razionalistico ma anche emozionale, accompagnato anche da una teatrale gestualità che rende più facile l’empatia e la partecipazione emotiva della folla che lo ascolta e in cui lo stratega cerca di immedesimarsi. Il suo discorso riflette gli animi, i pensieri, la mentalità del pubblico che pende dalle sue labbra, ma senza dimenticare di mantenere una giusta distanza tra la folla e colui che la guida, sebbene non la governi, né tantomeno tiranneggi.
È proprio in età periclea che finalmente si può parlare di Stato, come esito di un processo che gradualmente va a separare le due sfere – fino ad allora inscindibili e confuse, o meglio, il pubblico era solo l’interesse del privato aristocratico – di pubblico e privato. Le due dimensioni con Pericle si distinguono nettamente ma armonizzandosi ed equilibrandosi perfettamente. Pericle non vuole entrare nella vita privata dell’individuo a cui è lasciata la libertà, anzi, è dovuta la possibilità e l’opportunità (il kairos, la chance, l’occasione) di realizzare la sua piena felicità, fisica, economica, mentale. L’ideale di Pericle si spinge persino verso una sorta di edonismo, che non è triphè, ovvero lo scialo, l’ozio smodato, scomposto e parassitario, ma una aneimente dìaita, la vita rilassata cui ciascun cittadino ha diritto: “Amiamo il bello senza sprechi, e ci dedichiamo alla cultura senza che questo comporti mollezza”.
Ciascun individuo ha diritto ad essere felice per Pericle e questa felicità la si può ottenere anche con il riposo dal lavoro, lo svago, le feste, i banchetti. Se però c’è una forte attenzione al privato, è il pubblico che assurge a dimensione prioritaria ed è la sua forza, la forza del sistema democratico ad essere decantata ed esaltata da Pericle.
La forza di questa democrazia consiste soprattutto nel fatto che a ciascuno, ricco e povero, è consentito accedere a una carica importante, se ne ha il merito e ne possiede le capacità e le giuste qualità. Contro un sistema che privilegiava il censo o il ghenos, la stirpe di origine nobile, Pericle oppone un modello meritocratico e attivistico, precursore di quell’idea del fare, del provare, del lanciarsi nelle sfide e nelle opportunità che la vita sociale e politica può e deve offrire a chiunque abbia il coraggio di osare e di uscire dalla propria condizione di miseria. Ognuno, anche un teta (un salariato) può diventare stratega, grazie alla forma del sistema democratico stesso e chiunque, cogliendo il kairos può uscire dal suo stato di povertà:
“Di fronte alle leggi tutti hanno parte uguale in ordine di divergenze private; e, secondo la valutazione che si riceve, se qualcuno eccelle, non viene scelto per le funzioni pubbliche in base alla sua parte di ricchezze, più che in base alle sue qualità, né d’altro canto, viene ostacolato dalla oscurità del suo ruolo sociale, se è in grado di rendere qualche buon servizio alla città”. E ancora: “Non è vergogna ammettere di essere poveri, è vergogna non far nulla per uscire dallo stato di povertà.”
È un invito, quello pericleo, alla partecipazione politica, e al lavoro visto come produzione di ricchezza e di riequilibrio sociale, funzionale anch’esso alla piena realizzazione dell’individuo in una società libera e democratica che prevede uguali chance di riuscita, pur se non staticamente uguali condizioni economiche. Il diritto alla partecipazione politica così tanto difeso da Pericle, si esprime innanzitutto in quelle che sono le principali caratteristiche della democrazia greca: la libertà/uguaglianza nella libertà di parola – isegoria – e la libertà di poter dire tutto, la parrhesia, unite ovviamente alla libertà nella scelta politica, nella decisione politica. Per questo diventa così fondamentale il ruolo dell’assemblea, che decide e si esprime, e non avalla semplicemente la decisione di un capo, come ad esempio si vede nei poemi omerici.
Ora i cittadini riuniti in assemblea assumono un ruolo determinante, partorendo persino degli eccessi, delle degenerazioni che le stesse regole del gioco democratico hanno permesso e permettono. Saranno isegoria e parrhesia a creare demagoghi, così come sarà la stessa giurisdizione troppo cavillosa e fitta di decreti, in nome di una esasperata precisione a far diffondere la sempre più ingente ed affaristica attività dei sicofonti, i quali approfittandosi della cavillosità delle leggi riusciranno ad aggirarle per ritorcele a proprio favore.
Così come quel potere dato ai tribunali popolari, che se da una parte toglievano alla boulè (il consiglio) aristocratico il diritto di condannare, multare, fare ammende sui cittadini, dall’altra l’introduzione dei misthoi, le indennità per lo svolgimento di funzioni e cariche pubbliche volute da Pericle e successivamente l’innalzamento dell’obolo ai giudici, farà sì che questi ultimi entrino nelle giurie solo per guadagno personale, senza realmente intendersi di leggi e costituzione, come mostra bene il conservatore Aristofane nella sua commedia Le vespe, parodia di questi vecchi giudici che si recano in tribunale solo per ricevere l’obolo.
In realtà però, la stessa misura dell’indennità (il misthos) non è un semplice trasferimento di denaro, o una forma di assistenza da privato a privato, né è fondata sulla generosità individuale. Anch’essa rientra in un processo che si sviluppa interamente al livello del pubblico, poiché si tratta di denaro pubblico che è distribuito come ricompensa per l’esercizio di una funzione pubblica: giurato, consigliere, magistrato, soldato. Che poi ci siano gli abusi o i degeneri è cosa che accade ancora oggi, anzi, soprattutto oggi. Viene subito in mente il caso dei consiglieri comunali che prendono il gettone e nemmeno presenziano i consigli.
I parallelismi tra democrazia di V secolo e democrazia attuale sono tanti, sia nelle sue caratteristiche migliori, che anche, purtroppo, in quelle peggiori. Corruzione, abusi, assenteismo sono residui malati e marci di un sistema che però non va rimesso in discussione nei suo valori e nei suoi principi. Pericle stesso è cosciente che quel sistema che non ha mai smesso di difendere e di esaltare poteva partorire i suoi nemici, ma non ha mai rinnegato quella libertà di espressione, partecipazione, rispetto per le leggi e uguaglianza di fronte ad esse che la democrazia, per lo meno in linea teorica, portava con sé (pur con tanti e vari difetti, primo fra tutti una ancora forte gerarchizzazione sociale e una economica per niente egualitaria, per non parlare di una politica imperialistica e piuttosto guerrafondaia che lo stesso stratega portava avanti) e quegli stessi valori dovremmo difenderli noi oggi, contro chi cerca di distruggerli o di svilirli.
La demokratiai greca ha fatto di tutto per difendersi contro gli accentramenti di potere, attraverso la rotazione delle cariche o lo strumento dell’ostracismo, che impediva che qualche personaggio della scena politica e non solo, prendesse troppo potere e potesse instaurare una tirannide – sebbene poi sia degenerato diventando uno strumento volto solo a eliminare i propri avversari politici – in nome di quella libertà che i greci hanno sempre cercato di difendere.
Oggi non è meno importante difendere quella stessa libertà e lottare, affinché la nostra democrazia non rischi di diventare un mero nome che non racchiuda poi, di fatto, quasi più nulla.
Pubblicato per la prima volta il 14 aprile 2015

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.