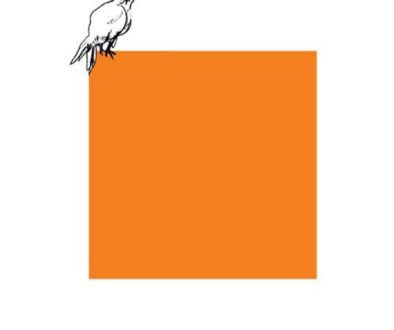Dal 14 ottobre 2007, in poco più di dodici anni di esistenza, il Partito Democratico ha cambiato 9 volte segretario, per otto dirigenti diversi (Renzi ha ripetuto due volte, con un breve interim di Orfini). La tormentata esistenza di quel collettivo politico, diviso in almeno una mezza dozzina di correnti e che ha già subito una mezza dozzina di scissioni, ha un riflesso importante sulla politica nazionale: propriamente o impropriamente il PD è ancora il punto di riferimento di un ampia fetta dell’elettorato genericamente “di sinistra”, che guarda alle vicende di quel partito con preoccupazione. La fragorosa uscita dell’ultimo segretario può essere il colpo di grazia o il momento del rilancio per una formazione in grande affanno nei sodaggi e apparentemente priva di una strategia chiara per uscire dal guado.
Leonardo Croatto
Non ho mai considerato il PD un riferimento politico interessante, così come non ho mai considerato anche vagamente potabili i soggeti che lo hanno generato per fusione. Non solo non ho mai codiviso la proposta moderatamente riformista e per niente critica del capitalismo (con pericolosi scartamenti verso destra, a seconda dei periodi) del PD, ma ancor di più ho trovato indigeribili tutti gli elmenti che ne hanno caratterizzato l’evoluzione ed il consolidamento delle forme organizzative. Valutai all’epoca la fusione a freddo di soggettività politiche diverse un’operazione puramente politicistica alla quale non ho mai attribuito alcun valore politico. Peggio ancora, ho sempre considerato lo strumento delle “primarie” un’americanata nella forma e un’orribile soluzione plebiscitaristica nella sostanza; giudico quel sistema per l’elezione del segretario la scelta organizzativa primariamente responsabile dello svuotamento delle assemblee di partito come spazio di confronto e di sintesi delle idee.
Insomma, considero il PD un luogo assolutamente inospitale per chiunque intenda il partito come luogo di partecipazione, militanza e crescita, inadatto alla formazione e alla selezione di quadri che possano poi diventare classe dirigente del paese.
La confusione di idee (per essere generosi) e un’organizzazione strutturata per favorire lo scontro tra aristocratici della politica più che la partecipazione attiva dei militanti ha prodotto lo svuotamento del partito (che ha visto dimezzare i propri iscritti) e la scomparsa dei presidi territoriali fissi (le sedi) e mobili (le feste). Il frenetico succedersi dei segretari è semplicemente l’epifenomeno, la manifestazione esteriore, dei difetti congeniti del progetto Partito Democratico.
Se è innegabile che Zingaretti si sia dimostrato un segetario particolarmente debole, non sarà una sua sostituzione a salvare un soggetto politico nato sbagliato nelle forme e vuoto nella sostanza, privo di identità e organizzato in modo da scoraggiare la militanza anziché incentivarla.
Dmitrij Palagi
Si fa un gran discutere di politica popolare e populista, tanto per cambiare. Quasi la pandemia Covid-19 fosse un elemento secondario, di contorno.
Straordinario vedere la politica muoversi con tanta disinvoltura all’interno di uno spettacolo assolutamente autoreferenziale.La scelte delle parole del Segretario nazionale del Partito Democratico in riferimento alla sua “comunità” palesano una rottura non rimediabile. Non è detto che sia la fine della storia organizzativa di questa formazione. Occorre però mettere insieme i giudizi di Bersani con questo gesto, associando il giudizio diffuso nei confronti di Matteo Renzi, all’interno di una parte non marginale dello stesso partito che scelse di consacrarlo come nuovo Blair per i progressisti del XXI secolo.
Cos’è un partito, se non il suo insieme di iscritte e iscritti? Un’organizzazione che non è uno spazio partecipato e condiviso difficilmente può essere considerata un partito, secondo la nostra Costituzione.
La narrazione egemone sosteneva che il Partito Democratico fosse l’ultimo vero partito del sistema politico italiano.Affermazione ormai definitivamente opinabile.Questa pandemia sta cambiando anche le modalità di interazione tra individualità, ma sembra che non sia un tema di cui prendere consapevolezza, a livello politico.
Jacopo Vannucchi
Sarebbe bello poter considerare le dimissioni di Zingaretti solo come un passaggio operativo interno al PD, o, al massimo, come la certificazione di una inadeguatezza personale a svolgere una certa mansione. Esse in realtà sono spia di una crisi più profonda, e non solo perché riguardano uno dei maggiori partiti del Paese, ma per il generale contesto politico in cui si inseriscono.È possibile riassumere molto brevemente la situazione.
1) Giuseppe Conte ha ribadito ciò che diceva durante il suo primo governo, cioè di essere un populista, e su queste basi chiede la guida del Movimento 5 Stelle.
2) Giuseppe Conte ha già anche la guida del centrosinistra, per gentile deposizione di armi da parte del PD.
3) Giuseppe Grillo ha annunciato di candidarsi alla segreteria nazionale del PD.
4) La destra sta cercando con un certo successo di rifarsi un’immagine liberale e, senza un avversario che lavori sulle contraddizioni fra liberalismo e sovranismo, non è difficile immaginare la (ri-)formazione di un ampio blocco dal centro alla destra ultracon.
Ampio blocco che naturalmente, viste le condizioni di debolezza del centrosinistra, partirebbe favorito in nuove elezioni politiche e, in caso di vittoria, potrebbe contare su un’opposizione incapace di essere tale perché invischiata nell’abbaglio mortale del populismo. Invece in caso di scenario 2018, con la destra maggioranza solo relativa, le carte le darebbero le forze di centro (Renzi, Calenda, Bonino), che dovrebbero scegliere se consentire l’insediamento o di un governo Giorgetti o di un Conte III (i nomi siano qui presi come esemplificazioni della linea politica).Non è inoltre ancora chiaro se il successore di Mattarella sarà eletto da questa Legislatura o dalla prossima, poiché il semestre bianco scatta fra cinque mesi. Ma anche con questo Parlamento è evidente che la posizione negoziale del centro-destra è ampiamente rafforzata: ciò per via della disarticolazione del centrosinistra, affondato assieme a Trump e al suo consonante italiano Conte.
E il bello è che a Conte ci si sono legati da soli.
Alessandro Zabban
La crisi del governo Conte ha sparigliato le carte della politica. Il partito che rischia di rimetterci più di tutti è proprio il Partito Democratico. A prima vista ciò può apparire bizzarro: in fin dei conti sono stati Salvini e i grillini a mostrarsi i meno coerenti nella gestione di questa nuova fase. Il primo ha per anni alimentato una polemica antieuropeista agli antipodi rispetto a Draghi mentre i secondi hanno sempre visto qualsiasi governo tecnico come il male assoluto. Il PD è invece coerentemente rimasto a disposizione per qualsiasi governo di salvezza nazionale in una fase di emergenza.
Eppure il partito è stato preso in contropiede dalla decisione della Lega di appoggiare il governo Draghi. Non si tratta di un imbarazzo passeggero, in quanto tutta la strategia elettorale del PD negli ultimi anni (pensiamo alle regionali in particolare in Emilia Romagna e Toscana) si è fondata sulla demonizzazione della Lega e sull’appello al voto per fermare l’avanzata dei nuovi “barbari”, anche col soccorso delle Sardine (una sorta di Popolo Viola anti-salviniano). Aver richiesto il voto utile come argine alle destre su base regionale per poi finirci a governare insieme a livello nazionale è quanto di più scorretto si possa pensare, e qualcuno nel PD se ne rende conto, alimentando un profondo malcontento che scuote un partito frammentato.
Queste tensioni sono del resto acuite dalla mossa del 5 Stelle di proclamare Conte come capo politico. Grazie alla sua popolarità, ancora alta e spesso sottovalutata, l’ex Premier rischia di prendere molti voti nel bacino elettorale di centrosinistra. I nodi di un partito diviso in molte correnti ma allo stesso tempo complessivamente troppo poco attento alla dimensione dei diritti sociali e del lavoro, stanno venendo al pettine. Zingaretti poteva dimettersi senza alimentare polemiche interne che potessero danneggiare il PD, ma la sua invettiva contro chi “pensa solo alle poltrone”, è sintomo di una tensione altissima e di una guerra fratricida interna che rischia di frammentate ulteriormente il campo della sinistra.
Immagine da commons.wikimedia.org

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.